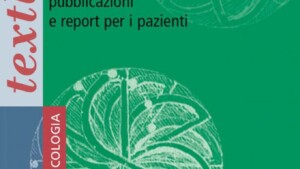L’ assessment o valutazione psicodiagnostica rappresenta un iter propedeutico all’intervento terapeutico: la raccolta di informazioni e dati orienta il terapeuta, dà origine ad una storia, e crea le condizioni per costruire con il paziente una relazione, un’ alleanza, basata sull’empirismo collaborativo.
“Qual è la sua difficoltà?”
Il paziente si rivolge a noi, psicologi e psicoterapeuti, con una domanda, implicita oppure esplicita, ma comunque una richiesta che deve essere, in primo luogo, accolta ed interpretata.
Presso Psicoterapia e Scienze Cognitive, scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitivo comportamentale e centro di psicoterapia, si effettua una esauriente prima fase di inquadramento e valutazione psicodiagnostica, definita assessment, ovvero accertamento del problema.
La fase di assessment è decisiva, in quanto permette, attraverso l’utilizzo di modalità e strumenti specifici, quali ad esempio il colloquio, l’intervista, strumenti self-report (test autosomministrati a crocette), di raccogliere informazioni e prendere decisioni strategicamente orientate e fondamentali per l’efficacia della fase successiva, il trattamento.
Perché l’ assessment in Psicoterapia?
La valutazione psicodiagnostica rappresenta un iter propedeutico all’intervento: la raccolta di informazioni e dati orienta il terapeuta, dà origine ad una storia, e crea le condizioni per costruire con il paziente una relazione, un’ alleanza, basata sull’empirismo collaborativo.
In generale si parla di situazione di assessment quando ad esempio si valutano dei candidati ad una selezione del personale, si esaminano degli studenti a scuola o all’università per saggiarne la preparazione, o si vedono dei pazienti al fine di stabilirne una diagnosi. Nello specifico, in riferimento alla psicologia e psicoterapia, la funzione principale del processo di assessment è rappresentata dal tentativo di comprendere il paziente e il suo mondo di significati, spiegarsi in che cosa consiste, come può essere nato e come si mantiene il problema che ci viene presentato. Si tratta in altre parole di:
- Cercare di capire la difficoltà del paziente: la valenza e i significati che essa assume ai suoi occhi nella vita quotidiana e rispetto all’immagine che egli ha di se stesso, delle relazioni con gli altri, del proprio futuro;
- Cercare di costruire un modello (nel linguaggio professionale) delle modalità di funzionamento del sistema-paziente e delle sue caratteristiche strutturali nel complesso;
- Tentare di ricostruire i processi, le tappe e i momenti critici dello sviluppo che hanno condotto all’attuale struttura individuale;
- Comprendere e spiegarsi la funzione che la sintomatologia svolge, al fine di organizzare un progetto di intervento clinico, laddove se ne verificassero le condizioni.
Procedure e strumenti della valutazione psicodiagnostica
Spesso i colloqui o le terapie iniziano proprio perché vi è una difficoltà che non si riesce a risolvere. Per questo motivo, la prima cosa da fare è accertare. Il racconto potrà iniziare con la descrizione di alcuni stati d’animo problematici o dolenti, oppure una serie di situazioni spiacevoli in cui ci si è trovati o ancora relazioni problematiche con le proprie figure di riferimento. Trattandosi di problemi di tipo psicologico è bene accompagnare questa prima fase di accertamento e di conoscenza iniziale con accertamenti diagnostici più formalizzati.
Il centro Psicoterapia e Scienze Cognitive di Genova si rifà all’approccio cognitivo comportamentale secondo il quale la valutazione psicodiagnotica non ha tanto l’intento di porre una diagnosi quanto quello di comprendere il funzionamento globale della persona per poterne migliorare la qualità di vita e scegliere le modalità di psicoterapia più efficaci.
E’ infatti fondamentale effettuare un accertamento anche per i pazienti che già conoscono la propria diagnosi. Infatti le diagnosi spesso sono delle etichette che descrivono, ma non sempre spiegano. È importante valutare in un’ottica funzionale – ovvero mettendo a nudo i rapporti causali tra pensieri, emozioni e comportamenti – i fattori specifici che sono alla radice del problema. Due pazienti con la stessa diagnosi possono avere comunque due problemi molto diversi tra loro e aver bisogno di trattamenti differenti.
Gli strumenti principali di cui può avvalersi il terapeuta per portare a termine l’ assessment sono: il colloquio clinico, l’intervista, e test self-report. In aggiunta, possono essere utilizzati numerosi altri strumenti standardizzati come inventari, checklist, schede di osservazione e diari.
Quale durata prevede un assessment?
Solitamente i primi colloqui di assessment (3-5 sedute, della durata di 50 minuti circa) hanno lo scopo di approfondire la conoscenza della persona che si rivolge al professionista.
Vengono dunque raccolte, in primo luogo, le informazioni biografico-anamnestiche, l’anamnesi del problema riportato, eventuali altre situazioni chiave collegate ad esso.
A tale scopo ci si avvale degli strumenti sopra elencati, a discrezione del terapeuta. Il lavoro si conclude con la restituzione al paziente di quanto emerso e la condivisione di un eventuale progetto terapeutico, dopo un’attenta concettualizzazione del caso e la formulazione di un piano terapeutico.
Il Centro clinico e la Scuola di specializzazione Psicoterapia e Scienze Cognitive di Genova danno una forte importanza alla valutazione psicodiagnostica, sia dal punto di vista del colloquio clinico che dal punto di vista della testistica, sia psichiatrica che psicologica che cognitiva. Ciò rappresenta una premessa fondamentale per l’organizzazione del progetto clinico e psicoterapeutico e per l’integrazione tra diverse figure professionali: lo psichiatra, lo psicoterapeuta individuale, l’invio in doppio setting ai gruppi, e così via.
Alleanza e gestione terapeutica del problema
A conclusione della fase di accertamento del problema vi è la concettualizzazione del problema da parte del terapeuta, cui fa seguito la fase di restituzione.
Essa permette la condivisione degli obiettivi terapeutici e rappresenta uno degli elementi fondamentali per promuovere e mantenere la cosiddetta alleanza terapeutica, ovvero la particolare relazione di collaborazione che si stabilisce tra un paziente e il terapeuta.
L’ alleanza rappresenta sia il punto di partenza del lavoro, senza il quale sarebbe difficile il procedere della psicoterapia, sia l’elemento che accompagna i due viaggiatori per tutta la durata del loro viaggio. A questo proposito Linehan (2012) ritiene che “il compito essenziale del terapeuta sia quello di riconoscere e legittimare gli stati mentali, le emozioni e le credenze del paziente”. Questo, nelle prime fasi della terapia, contribuisce alla costruzione di una relazione terapeutica costruttiva e accettante. Un importante punto della terapia cognitiva è la concettualizzazione del problema presentato e la sua restituzione al paziente, momento che precede il “contratto terapeutico” ma che già di per sé è una fase cruciale per creare tra il terapeuta ed il paziente un clima di fiducia ed un’ alleanza basata anche sulla condivisione tra terapeuta e paziente di una teoria del suo funzionamento mentale ancor prima che del suo disturbo.
Clinici di orientamenti diversi concordano che sicurezza e sintonizzazione o meglio una alleanza terapeutica, cioè quel clima di fiducia e collaborazione tipico delle relazioni di aiuto efficaci, sia indispensabile per avviare e mantenere una psicoterapia.
Accertare non è che l’inizio.