di Elena Del Rio, Silvia Pomi, Giorgia Righi
“Quando amiamo troppo, in realtà non amiamo affatto perché siamo dominate dalla paura: paura di restare sole, paura di non essere degne d’amore, paura di essere abbandonate o ignorate”
R. Norwood (2003).
 Love addiction: l’innamoramento è un’esperienza che plasma l’identità dei giovani e l’autostima. Kaarina Maatta, nel 2011 ha chiesto a 55 giovani adulti di descrivere le loro esperienze amorose; i partecipanti allo studio hanno definito la fase dell’innamoramento e il suo significato attraverso connotazioni differenti: come risultato di azioni razionali, come volontà di cambiamento, come distacco dall’età infantile e dalle influenze del gruppo di appartenenza.
Love addiction: l’innamoramento è un’esperienza che plasma l’identità dei giovani e l’autostima. Kaarina Maatta, nel 2011 ha chiesto a 55 giovani adulti di descrivere le loro esperienze amorose; i partecipanti allo studio hanno definito la fase dell’innamoramento e il suo significato attraverso connotazioni differenti: come risultato di azioni razionali, come volontà di cambiamento, come distacco dall’età infantile e dalle influenze del gruppo di appartenenza.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: AMORE E RELAZIONI SENTIMENTALI
I partecipanti hanno poi descritto tutti i “sintomi” dell’innamoramento: la sensazione di leggerezza, l’aumento di forza ed energia, la positività, il desiderio irresistibile di passare il maggior tempo possibile con la persona amata e l’abbandonarsi spesso a giochi e atteggiamenti infantili e frivoli con il partner, con il quale sembra sussistere una sorta di “sesto senso”, un legame che “nessun altro può capire”.
Erri de Luca (1998) descrive così l’innamoramento: “ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono solo a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo, ci si innamora da un angolo acuto un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano”. Tutte queste descrizioni possono essere facilmente riassunte con l’espressione “avere le farfalle nello stomaco”.
Ma le farfalle nello stomaco possono trasformarsi in una gastrite fulminante, una droga d’amore, una vera e propria dipendenza affettiva.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: LOVE ADDICTION
Nella dipendenza affettiva, o “love addiction”, è la relazione stessa a costituire l’oggetto di dipendenza; i soggetti “dipendenti d’amore” non riescono ad avere una vita piena e soddisfacente, vivono in balia delle emozioni, vengono ingoiati dalle storie d’amore arrivando anche all’autodistruzione, non sono autonomi e sono incapaci di prendere decisioni; senza l’altro si sentono persi, smarriti, senza significato.
I dipendenti affettivi sono incapaci di relazionarsi con l’altro in modo maturo, come se non riuscissero a vivere una storia alla pari, e si ritrovano ad avere una relazione asimmetrica come quella che hanno vissuto nell’infanzia con le figure di riferimento.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ATTACCAMENTO – ATTACHMENT
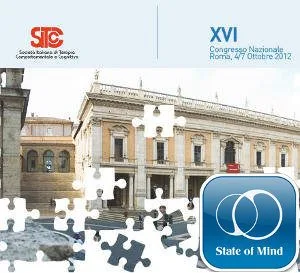
Alla base del legame con l’altro vi è un “bisogno d’amore” che si basa su una significativa carenza, “la ferita dei non amati”, così definita da Schellenbaum (2005); questa condizione ha origine nell’infanzia, dalla necessità di soddisfacimento dei bisogni primari di nutrimento emotivo e di accettazione incondizionata da parte dell’adulto.
Nel caso in cui questi bisogni non siano stati soddisfatti lo sviluppo può avere un esito negativo, da cui possono comparire il senso di insicurezza, di incertezza rispetto alle proprie capacità, e il costante bisogno d’amore. Qualunque espressione d’amore anche da adulto non sarà mai in grado di riempire il vuoto originario, dato dalla mancanza di quell’accettazione incondizionata da parte delle figure di riferimento (Costantini, 2009).
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ACCETTAZIONE
Secondo Giddens (1992), la dipendenza affettiva è un disturbo autonomo e presenta caratteristiche quali l’ebbrezza (il soggetto dipendente prova una sensazione di ebbrezza dalla relazione con l’altro, paragonabile a quella del tossicodipendente quando sta andando a procurarsi la sostanza) e la dose (il soggetto dipendente trova nell’altro una sorta di droga e cerca così sempre quantità maggiori in termini di presenza e di tempo da trascorrere insieme).
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DIPENDENZA
Numerose ricerche infatti mostrano che la dipendenza affettiva condivide alcune caratteristiche negative con altre dipendenze, in particolare con l’abuso di sostanze (Fisher, 2006; Peele & Brodsky, 1992; Wolfe, 2000). Il partner, assume il ruolo di “eroe”, che diviene unico scopo di vita e la cui mancanza dà alla persona la sensazione di “non esistenza” (DuPont, 1998).
LEGGI ANCHE ARTICOLI: DROGHE E ALLUCINOGENI
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ALCOOL
L’aspetto fondamentale proposto da Giddens (1992) è la paura che caratterizza il dipendente affettivo: una caratteristica che precede sempre ogni forma di dipendenza. Paura di perdere l’amore, paura dell’abbandono e della separazione, paura di mostrare se stessi, di amare l’altro per quello che è.
Si tratta di una paura schiacciante, che si può riassumere nella terrificante massima del poeta latino Publio Ovidio Nasone (Amores, III, 11b, 7): “così non riesco a vivere, né con te né senza di te”. Con te, per il dolore che si prova nel subire umiliazioni, maltrattamenti e offese; senza di te perché non si può sopportare l’angoscia che si sente al solo pensiero di perdere la persona amata. Dalla letteratura risulta che il 99% dei soggetti dipendenti affettivi sono di sesso femminile (Miller, 1994) distribuiti in differenti fasce di età. Si tratta spesso di donne con una bassa autostima, che si sentono colpevoli e poco meritevoli e quindi destinate a non essere ricambiate dell’immenso amore che provano e dimostrano continuamente.
Nelle interviste condotte dalla Maatta (2011) su adolescenti e giovani adulti possiamo ritrovare alcuni aspetti descrittivi dell’innamoramento che connotano quella che potrebbe sfociare in dipendenza affettiva.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ADOLESCENTI
I ragazzi infatti riportano di provare una sorta di “regressione e esperienza simbiotica” con l’innamorato agli inizi della storia, che richiama la relazione di totale dipendenza che un bambino ha con la figura di accudimento; il problema è che, come loro stessi riferiscono, questa regressione porta con sé anche l’insicurezza, la paura e il senso di confusione che possono aver provato da bambini di fronte alla percezione che dalla figura di accadimento e dalla sua vicinanza dipendesse la propria felicità in modo esclusivo.
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ACCUDIMENTO
Infine, oltre a essere un’importante occasione per capire meglio se stessi e le proprie reazioni, l’innamoramento diventa per alcuni depositario di alte aspettative salvifiche rispetto a una fuga da quello che non va in tutti gli altri ambiti di vita. Per questo, i ragazzi riferiscono di stare attenti a adattarsi alle aspettative dell’altro, per minimizzare le possibilità di perdere lui/lei e annullare la relazione che sta nascendo.
Ritornando alle giovani generazioni, i mass media potrebbero avere un impatto sullo sviluppo della love addiction; nella giovane musica pop infatti l’amore è spesso rappresentato in associazione a crisi emotive, forte desiderio della persona amata, alta idealizzazione fantastica, pensiero ossessivo ed estrema dipendenza dall’oggetto d’amore (Vannini & Mayers 2002).
LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: MUSICA
Del resto, da sempre l’amore e tutte le sue sfaccettature sono l’oggetto d’ispirazione musicale per eccellenza; negli anni sessanta una famosa canzone dei Temptations “Ain’t too proud to beg”, faceva della dipendenza affettiva un elemento di cui andare fieri: “because I want to keep you any way I can, ain’t too proud to beg, sweet darlin’, please don’t leave me girl…”.
LEGGI ANCHE:
AMORE E RELAZIONI SENTIMENTALI – LOVE ADDICTION – DIPENDENZA
ADOLESCENTI – ATTACCAMENTO – ATTACHMENT – ACCUDIMENTO
BIBLIOGRAFIA
- Costantini, S. (2007). Dipendenze e falsi bisogni.
- De Luca, E. (1998). Tu, mio. Milano: Feltrinelli.
- DuPont R. (1998). Addiction: A New Paradigm. Bulletin of the Menninger Clinic, 62 (2) 231-242.
- Fisher H. (2000). Broke hearts: the nature and risks of romantic rejections. In A. C. Crouter & A. Booth (Eds.): Romance and sex in adolescence and emerging adulthood: risks and opportunities. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associaties, pp. 3-28.
- Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, love and Eroticism. Cambridge: Polity Press, pp. 64-86.
- Maatta, K. (2011). The sweet poison of love in adolescence and early adulthood. Elixir Psychology, 37, 3836 -3843.
- Miller D. (1994). Donne che si fanno male. Milano: Feltrinelli.
- Norwood R. (2003). Donne che amano troppo. Milano: Feltrinelli.
- Peele, S., & Brodsky, A. (1992). The truth about addiction and recovery. New York: Fireside, pp.144-157.
- Publio Ovidio Nasone (Amores III, 11b, 7).
- Schellenbaum, P. (2005). La ferita dei non amati. Milano: RED Edizioni.
- Sussman, S. (2010). Love addiction: Definition, Etiology, Treatment. Sexual Addiction & Copulsivity, 17, 31-45.
- Vannini, P., & Myers, S.M. (2002). Crazy about you: reflections on the meanings of contemporary teen pop music. Elettronic journal of sociology.
- Wolfe J.L. (2000). Assessment and treatment of compulsive sex/love behavior. Journal of rational-emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 18, 235-246.


