 I risultati di numerose ricerche indussero i ricercatori a denominare Effetto Mozart l’influenza della musica sul ragionamento spaziale.
I risultati di numerose ricerche indussero i ricercatori a denominare Effetto Mozart l’influenza della musica sul ragionamento spaziale.
Un celebre studio condotto nel 1993 da Rauscher e colleghi suggerì che l’ascolto di un brano musicale potesse promuovere un incremento delle capacità visuo-spaziali; il brano scelto per l’indagine sperimentale fu la Sonata per due pianoforti in Do Maggiore (K448) di Mozart, e i risultati ottenuti indussero i ricercatori a denominare Effetto Mozart l’influenza della musica sul ragionamento spaziale.
La tesi, da cui l’ Effetto Mozart, era che la sonata di Mozart generasse l’attivazione di pattern neuronali all’interno di aree corticali implicate in attività di ragionamento spazio-temporale, e in particolare la corteccia temporale, la corteccia dorso laterale pre-frontale, la corteccia occipitale, il cervelletto.
LEGGI GLI ARTICOLI SU: INTELLIGENZA
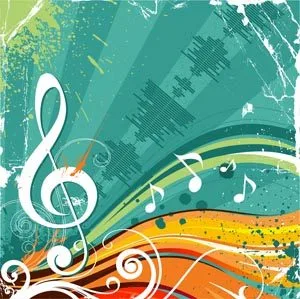
In seguito altri lavori hanno messo in discussione questi risultati, individuando elementi più generali che si possono considerare validi nel descrivere le prestazioni dei soggetti sperimentali. Chabris (1999) ha utilizzato due gruppi di controllo, uno nella condizione di silenzio e l’altro sottoposto a istruzioni rilassanti, e ha osservato che gli effetti della musica di Mozart si riscontravano nel secondo caso, quando le istruzioni rilassanti avevano determinato una riduzione dell’arousal. Steele (2000) è giunto alla medesima conclusione riconoscendo quali fattori decisivi nel miglioramento delle prestazioni cognitive un innalzamento del livello di attivazione e una variazione positiva dell’umore, in linea con le ipotesi confermate da Thompson et al. (2001) e Nantais e Schellenberg (1996).
Questi ultimi alla musica di Mozart avevano affiancato l’ascolto di un brano di Stephen King, notando come le prestazioni dei soggetti fossero sì prodotte da un’attivazione superiore rispetto a quella del gruppo di controllo ma anche discriminabili in base alla preferenza soggettiva nei confronti dei due differenti stimoli sonori. La letteratura scientifica giudica, quindi, poco plausibile il modello elaborato da Rauscher, privilegiando invece aspetti più generali che indicano come il contatto con stimoli capaci di sollecitare un aumento dell’arousal e un miglioramento del tono dell’umore possa favorire la buona riuscita in compiti di intelligenza cognitiva. Barbato et al. (2007) esprimono un sostanziale accordo con le altre ricerche ma propongono uno spunto di riflessione ulteriore, poiché i loro soggetti sperimentali mostrano un arousal più elevato, sebbene in misura statisticamente non significativa, dopo l’ascolto di Mozart rispetto a un brano jazz.
LEGGI GLI ARTICOLI SU: NEUROPSICOLOGIA
Potrebbe essere interessante approfondire se una sorta di Effetto Mozart minore sia riconducibile alle caratteristiche melodiche e armoniche di quella musica, capaci di coinvolgere in modo più sensibile le aree cerebrali deputate al controllo dell’arousal e dell’umore.
LEGGI GLI ARTICOLI SU:
MUSICA – INTELLIGENZA – NEUROPSICOLOGIA
BIBLIOGRAFIA:
- Barbato, G., De Padova, V., Martini, V., Paolillo, A. R., Arpaia, L., Russo, E., Ficca, G. (2007). Effetti attivanti della musica nelle prestazioni cognitive. Il ruolo della funzione dopaminergica. Giornale Italiano di Psicopatologia, 13: 149-154. (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)
- Chabris, C. F. (1999). Prelude or requiem for the Mozart effect? Nature, 400: 426-427.
- Nantais, K. M., Schellenberg, E. G. (1996). The Mozart effect: an artifact of preference. Psychology, 10:370-373. (READ FULL ARTICLE)
- Rauscher, F. H, Shaw, G. L., Ky, K. N. (1993). Music and spatial task performance. Nature, 365: 611. (READ FULL ARTICLE)
- Steele, K. M. (2000). Arousal and mood factors in the Mozart effect. Perceptual and Motor Skills, 9: 188-190. (READ FULL ARTICLE)
- Thompson, W. F., Schellenberg, E. G., Husain, G. (2001). Arousal, mood and Mozart Effect. Psychological Science, 12:248-251.


