Giovanni M. Ruggiero e Sandra Sassaroli
Un bilancio finale sulla EABCT 2012 e sullo stato di salute del Cognitivismo Europeo
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SU: EABCT 2012

Ha avuto momenti trionfali, quando le terapie cognitivo-comportamentali, con la loro efficacia, sembravano spazzare via gli altri approcci e confrontarsi con forza con gli psichiatri e le ricerche di psicofarmacologia, con la sensazione che il nuovo paradigma fosse ineluttabile.
Poi da Helsinki (2008) fino a Reykjavik (2011) si è vista una grande crisi. Avanzavano approcci diversi con i pazienti difficili, e molti ricercatori e clinici si sentivano sempre più stretti nel confronto con certe rigidità e chiusure dei protagonisti della seconda ondata di Salkovskis, Clark e Fairburn. La reazione di alcuni è stata quella di lasciare e formare una propria società. Così hanno fatto Hayes, Young e Wells. Ma non è detto che abbiano fatto bene. La scelta di trovarsi solo tra adepti dello stesso orientamento non ci sembra creativa in questa fase.
Noi temevamo, andando a Ginevra, di trovare una società sclerotica e poco aggiornata con le nuove ricerche nate dalle riflessioni cliniche di chi approccia pazienti difficili e non riesce a adattare i modelli della seconda ondata ai pazienti complessi. Ma gli organizzatori del congresso sono stati molto bravi. L’esperienza e l’intelligenza di Lucio Bizzini e del suo gruppo ha saputo radunare le nuove correnti e ha portato al congresso esperienze e ricerche nuove e molto, molto interessanti. Certo, mancava un’intera generazione. Non c’erano i “vecchi” protagonisti che hanno contribuito a portare il cognitivismo a essere leader del mondo, mancavano Clark, Hayes, Salkovskis e Wells.
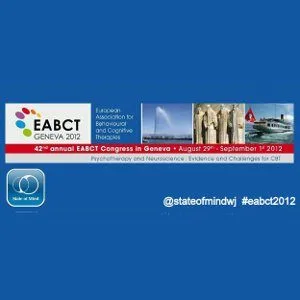
Ma gli stessi organizzatori (e noi con loro) sono rimasti basiti di fronte alla ricchezza dei contribuiti di tantissimi giovani e poco meno giovani che portano ricerche importanti spesso in aree del tutto innovative.
Cosa sono le cose nuove? L’area di integrazione tra neuroscienze, neuropsicologia, imagery e psicoterapia (il tutto talvolta denominata audacemente neuropsicoterapia); le varie modalità di somministrazione della psicoterapia che affrontano le esigenze della modernità, come le Internet Based Psychotherapy (standard e individualizzata), la CBT a bassa intensità, ovvero adattata alla domanda clinica estensiva e non intensiva dei servizi pubblici, la prevenzione dei disturbi e applicazioni sociali delle tecniche CBT. La CBT insomma si adatta e lavora anche per formalizzare gli interventi con pazienti nuovi, gli anziani, i malati organici, i sex offenders.
Ma ci ha colpito anche la presenza di nazioni che fino a pochi anni fa erano presenti solo come fruitori di formazione dai paesi anglosassoni, e oggi producono ricerca originale su vari temi, dall’attaccamento, alla mindfulness, all’integrazione tra terapia e neuroscienze. Abbiamo assistito a lavori scientifici provenienti dalla Serbia, dalla Lettonia, dalla Tunisia. La sensazione è di una grande vitalità e di un cambiamento in atto che non si può non guardare con interesse. L’Italia ha fatto la sua parte. In futuro forse la crisi della vecchia egemonia di seconda ondata potrà aprire a paesi di seconda linea la possibilità di essere ascoltati e di contribuire con ricerche originali al mainstream del cognitivismo.
Chi è rimasto nelle EABCT ha chiaro che certi trionfalismi che vorrebbero mettere sotto un’unica etichetta tutta la creatività clinica e scientifica hanno (in parte) fallito o perlomeno non hanno potuto rispettare certe promesse eccessive e che ora l’assetto integrativo e curioso verso il nuovo, da qualunque parte esso arrivi, è la posizione scientifica migliore. Meno profeti e più clinici e scienziati. Una grande lezione di maturità della cultura clinica e scientifica europea.

