Heavy Metal e Adolescenti: gli Effetti sull’Umore.
 La musica ha un ruolo significativo nella vita di ognuno di noi. È parte integrante della nostra esistenza e ci accompagna da tempi antichissimi, radicati nella storia evolutiva dell’uomo.
La musica ha un ruolo significativo nella vita di ognuno di noi. È parte integrante della nostra esistenza e ci accompagna da tempi antichissimi, radicati nella storia evolutiva dell’uomo.
Proprio per la sua importanza, alcuni ricercatori si stanno interrogando sul peso e sul significato che la musica possa avere in un’età difficile come l’adolescenza. Per molti adolescenti infatti, la musica risulta essere l’attività preferita tra le mura di casa propria.
Nella nostra epoca, la gamma e la diversità dei generi musicali a disposizione degli adolescenti è in continuo aumento e la rivoluzione degli mp3 e del libero scambio tra pari attraverso il web consente di ascoltare una straordinaria varietà di canzoni provenienti da ogni parte del mondo. È per questo che l’aumentato livello di accesso alla musica da parte degli adolescenti obbliga gli educatori (genitori ed insegnanti) ad essere informati sull’impatto che questa possa avere sul potenziale sviluppo di una giovane mente.
Tra i ricercatori, c’è chi si è schierato a favore della musica e del suo impatto positivo sullo sviluppo emotivo di un giovane adolescente, e chi ha preferito sottolinearne le qualità negative sulla scia delle polemiche originate dall’avvento delle nuove quanto variegate forme di musica partorite dagli anni Settanta.

Sul versante del negativismo, ad esempio, la Parent-Teacher Association of America e l’American Academy of Paediatrics sfidò l’industria musicale con una vasta serie diaccuse. Il Rock inparticolare finì nel mirino delle ingiurie per la sua associazione tra adolescenza e suicidio. La musica Heavy Metal fu presa di mira dal Parent’s Music Resource Centre, peri suoi legami con i comportamenti antisociali dei giovani adolescenti. Oltre alla preoccupazione dell’opinione pubblica per una ipotetica relazione causale tra ascolto di stili di musica aggressiva e condotta antisociale, la ricerca ha inoltre identificato una connessione tra problematiche psichiche e preferenze musicali anche per il Rap e il Rave. Le accuse nascono dalla presenza in alcune canzoni di messaggi cosiddetti “subliminali”, anche se queste hannodimostrato di avere intenzioni ben più superficiali, come ad esempio il successo commerciale. L’impatto di temi di estrema violenza, ribellione e sessualitàpromiscua tipicamente utilizzati nell’Hip-Hop e nell’Heavy Metal può però esseremitigato in qualche misura da una ricerca che suggerisce che gli adolescenti diano attenzione più alla musica che ai testi (in molti casi già pesantemente camuffati dalla distorsione delle chitarre elettriche e dal tipico canto fatto di urla e suoni gutturali, comunque tecnicamente apprezzabili).
Le ricerche di Stack e Gundlach (1992) su questo tema sono state le più provocatorie, arrivando a trovare una relazione tra la predominanza della proposta di musica Heavy Metal da parte di alcune Stazioni Radio occidentali e i tassi di suicidio. La loro indagine delle variabili ha però portato in ultima analisi al suggerimento che sia stata la mancanza di religiosità ad essere più fortemente legata ad uno stato d’animo suicida rispetto alla preferenza stessa per la musica Heavy Metal.
I ricercatori hanno spesso suggerito che certe preferenze musicali possano essere comunque indicative di una certa vulnerabilità ai problemi di salute mentale (Scheel e Westefeld, 1999). Roe (1987) e Coleman (1960) trovarono che le scelte musicali erano legate al successo scolastico e all’invalidazione del successo previsto dagli studenti stessi. Questo è stato sostenuto anche da Took e Weiss (1994) che hanno trovato un’associazione tra l’insuccesso scolastico e il crescente interesse per la musica Heavy Metal di alcuni adolescenti, che ne farebbero utilizzo come fuga dal confronto con i propri fallimenti.
Ultima ma non meno importante, la ricerca della McFerran (2011) sta mostrando come gli adolescenti ad alto rischio di disagio psicologico riportino la più alta percentuale di stati d’animo negativi dopo aver ascoltato musica Heavy Metal e la più bassa percentuale di stati d’animo migliori dopo l’ascolto della stessa. Con ulteriori ricerche, questo potrebbe dimostrare che gli adolescenti ad “alto rischio” abbiano difficoltà ad utilizzare la musica per migliorare il loro umore.
Sul versante dell’ottimismo invece, ed in modo altrettanto significativo, lo studio di Lester e Whipple (1996) non ha trovato alcuna relazione significativa tra esperienza passata di ideazione suicida e preferenze per la musica Heavy Metal, suggerendo che questa possa essere uno stato transitorio per molti adolescenti. LaCourse (2001) ancora, ha scoperto che l’ascolto della musica è in realtà inversamente correlato con l’ideazione suicida nelle ragazze. È per questo che Saarakallio e Erkilla (2007) hanno suggerito che la ricerca si sia focalizzata eccessivamente sui risultati negativi ed hanno raccomandato una maggiore attenzione ai suoi effetti positivi. Gli stessi autori hanno anche sottolineato l’aspetto dell’intenzionalità della regolazione dell’umore attraverso l’ascolto della musica, opponendosi al presunto processo di ascolto passivo.
Insomma, nonostante la vastità dei dati rispetto alle influenze negative della musica, è comunque in generale riconosciuto che la musica possa svolgere un ruolo positivo nella vita di molti adolescenti.
È importante considerare il ruolo della musica nell’adolescenza da una prospettiva evolutiva. Il processo di formazione dell’identità che definisce questo stadio di sviluppo si basa sul passaggio dalla famiglia alle alleanze tra coetanei (Erikson 1965). L’adolescenza sana è definita dal rifiuto del nucleo familiare primario e dalla preferenza per lo sviluppo di reti sociali esterne alla famiglia. La musica può essere vista come parte integrante di questo processo, così costellato dalle preoccupazioni genitoriali per i video musicali sessualmente provocanti di Madonna, per l’Heavy Metal degli Slayer ed il Rap di Eminem.
A prescindere da questi risultati, siano essi positivi o negativi, riteniamo sia utile che gli adulti riconoscano intuitivamente il disagio negli adolescenti e che sviluppino capacità di dialogo con gli stessi su come la musica influisca sul loro umore. È importante non criticare il genere musicale in sé, rischiando di suscitare una naturale reazione difensiva, ma focalizzarsi su come la musica vada utilizzata. Questo porterebbe a conversazioni più produttive e a relazioni significative, specialmente se il genitore o l’insegnante accettasse di ascoltare la loro musica e si mostrasse interessato.
BIBLIOGRAFIA:
- Coleman, J. S. (1960). “The adolescent subculture and academic achievement.” The American Journal of Sociology 65(4): 337-347.
- Erikson, E. (1965). Childhood and society. London, Penguin Books.
- Lacourse, E., M. Claes, et al. (2001). “Heavy metal music and adolescent suicide risk.” Journal of Youth and Adolescence 30(3): 321-332.
- Lester, D. and M. Whipple (1996). “Music preference, suicide preoccupation, and personality.” Suicide & Life-Threatening Behaviour 26: 68-70.
- McFerran K., O’Grady L., Grocke D., Sawyer S. M. (2011). “How teenagers use music to manage their mood: An initial investigation.” (in corso di pubblicazione, per gentile concessione tramite corrispondenza della Dr. Katrina McFerran)
- Roe, K. (1987). The school and music in adolescent socialisation. Pop music and communication. J. Lull. CA, SAGE: 212-230.
- Saarikallio, S. and J. Erkkila (2007). “The role of music in adolescents’ mood regulation.” Psychology of Music 35(1): 88-109.
- Scheel, K. R. and J. S. Westefeld (1999). “Heavy metal music and adolescent suicidality: An empirical investigation.” Adolescence 34(134): 253-273.
- Stack, S. and J. Gundlach (1992). “The effect of country music on suicide.” Social Forces 71(1): 211-218.
- Took, K. J. and D. S. Weiss (1994). “The relationship between heavy metal and rap music on adolescent turmoil: Real or artifact?” Adolescence 29: 613-621.
CRITICHE? CONSIGLI? DOMANDE? IDEE? LASCIACI LA TUA OPINIONE!



 Qual è stata la grande rivoluzione della società degli ultimi anni? Secondo Robin Dunbar, antropologo all’Università di Oxford, è il fatto che il nostro mondo sociale è stato ridefinito dai social network. Questi siti, oltre ad aver infranto le costrizioni della geografia che limitavano le dinamiche sociali, sembrano anche aver dato avvio ad una strana competizione sul numero di amici che si possono contare sulla propria pagina personale, con cifre che possono raggiungere anche le decine di migliaia (1). Tuttavia la lista degli “amici” andrebbe ampiamente sfoltita. Infatti in base alle ricerche condotte dal Prof. Dunbar il numero massimo di amici che si possono avere è 150 – cifra anche detta il Numero di Dunbar (2).
Qual è stata la grande rivoluzione della società degli ultimi anni? Secondo Robin Dunbar, antropologo all’Università di Oxford, è il fatto che il nostro mondo sociale è stato ridefinito dai social network. Questi siti, oltre ad aver infranto le costrizioni della geografia che limitavano le dinamiche sociali, sembrano anche aver dato avvio ad una strana competizione sul numero di amici che si possono contare sulla propria pagina personale, con cifre che possono raggiungere anche le decine di migliaia (1). Tuttavia la lista degli “amici” andrebbe ampiamente sfoltita. Infatti in base alle ricerche condotte dal Prof. Dunbar il numero massimo di amici che si possono avere è 150 – cifra anche detta il Numero di Dunbar (2).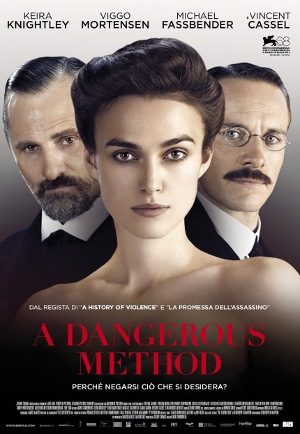 Freud e Jung, i due padri della psicoanalisi, hanno sancito la nascita e l’affermazione della “cura con le parole”. La curiosità mossa da molti nei confronti delle loro vite, delle loro opere, lavori complessi di non facile impatto, ha portato alla realizzazione di numerose rappresentazioni. Ricordiamo ad esempio Prendimi l’anima di Roberto Faenza, del 2002, o il recentissimo A Dangerous Method diretto dal “mastro indagatore” David Cronenberg, tratto dal libro di John Kerr che ha poi ispirato una pièce teatrale su tematiche che scandagliano le pulsioni dell’animo umano.
Freud e Jung, i due padri della psicoanalisi, hanno sancito la nascita e l’affermazione della “cura con le parole”. La curiosità mossa da molti nei confronti delle loro vite, delle loro opere, lavori complessi di non facile impatto, ha portato alla realizzazione di numerose rappresentazioni. Ricordiamo ad esempio Prendimi l’anima di Roberto Faenza, del 2002, o il recentissimo A Dangerous Method diretto dal “mastro indagatore” David Cronenberg, tratto dal libro di John Kerr che ha poi ispirato una pièce teatrale su tematiche che scandagliano le pulsioni dell’animo umano.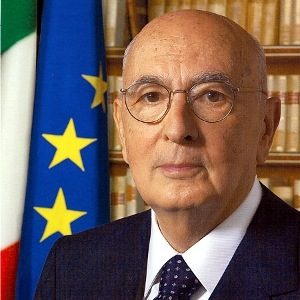 Si festeggia la caduta del sovrano Berlusconi, ma comunque si percepisce il bisogno di una guida, se non di un capo. Il problema di Berlusconi non è stato affatto il suo potere, ma la sua anarchia. Come altrimenti spiegare l’ammirazione discreta per Napolitano che serpeggia e cresce nell’opinione pubblica? Ora lui appare il timoniere, se non il vincitore. Destino imprevedibile per Napolitano. Per decenni figura importante eppure in fondo irrilevante nel PCI. Era il leader dei cosiddetti miglioristi, i riformisti del PCI visti con perenne sospetto dai militanti. I miglioristi non erano accettati dall’ortodossia di partito, perfino dopo lo strappo con i sovietici di Berlinguer…
Si festeggia la caduta del sovrano Berlusconi, ma comunque si percepisce il bisogno di una guida, se non di un capo. Il problema di Berlusconi non è stato affatto il suo potere, ma la sua anarchia. Come altrimenti spiegare l’ammirazione discreta per Napolitano che serpeggia e cresce nell’opinione pubblica? Ora lui appare il timoniere, se non il vincitore. Destino imprevedibile per Napolitano. Per decenni figura importante eppure in fondo irrilevante nel PCI. Era il leader dei cosiddetti miglioristi, i riformisti del PCI visti con perenne sospetto dai militanti. I miglioristi non erano accettati dall’ortodossia di partito, perfino dopo lo strappo con i sovietici di Berlinguer… Esperienza, fatica, sensibilità, tutte componenti che giocano un ruolo. Io, da giovane psicoterapeuta, mi meta-accorgo di come si evolve la mia sensibilità. Cioè mi accorgo di come avverto diversamente molti dei segnali che si succedono in una seduta di psicoterapia.
Esperienza, fatica, sensibilità, tutte componenti che giocano un ruolo. Io, da giovane psicoterapeuta, mi meta-accorgo di come si evolve la mia sensibilità. Cioè mi accorgo di come avverto diversamente molti dei segnali che si succedono in una seduta di psicoterapia. 
 Il concetto di ‘mode’, un termine difficilmente traducibile nella lingua italiana, rappresenta un costrutto sempre più importante nel trattamento cognitivo dei disturbi di personalità. Il mode è un insieme di schemi e prospettive mentali attive in un individuo in un determinato momento (Young, Klosko & Weishaar, 2003). Si può considerare una modalità di vedere il mondo e gli eventi e di reagire ad essi sintetizzabile in un ruolo più o meno stereotipato (es: il narciso disprezzante, il debole e indifeso, il freddo manipolatore, il libertino disregolato ecc…). Tutte le persone sviluppano diversi mode che prendono il sopravvento in particolari situazioni (es: una persona che se viene criticata entra in modalità contrattacco furioso oppure sottomissione incondizionata). Nelle persone senza disturbi psicologici i vari mode sono integrati sotto un cappello unitario (l’identità personale) e soprattutto volontariamente regolati nella loro espressione.
Il concetto di ‘mode’, un termine difficilmente traducibile nella lingua italiana, rappresenta un costrutto sempre più importante nel trattamento cognitivo dei disturbi di personalità. Il mode è un insieme di schemi e prospettive mentali attive in un individuo in un determinato momento (Young, Klosko & Weishaar, 2003). Si può considerare una modalità di vedere il mondo e gli eventi e di reagire ad essi sintetizzabile in un ruolo più o meno stereotipato (es: il narciso disprezzante, il debole e indifeso, il freddo manipolatore, il libertino disregolato ecc…). Tutte le persone sviluppano diversi mode che prendono il sopravvento in particolari situazioni (es: una persona che se viene criticata entra in modalità contrattacco furioso oppure sottomissione incondizionata). Nelle persone senza disturbi psicologici i vari mode sono integrati sotto un cappello unitario (l’identità personale) e soprattutto volontariamente regolati nella loro espressione. Donne bisessuali a maggior rischio di depressione e abuso alcolico rispetto a uomini bisessuali
Donne bisessuali a maggior rischio di depressione e abuso alcolico rispetto a uomini bisessuali  Un recentissimo
Un recentissimo  Poiché notoriamente “chi di spada ferisce, di spada perisce” come suggerì Gesù al focoso Pietro, confuso evidentemente dal fatto che lui stesso aveva precedentemente detto di essere venuto a portare la spada (Cristo,mettiamoci d’accordo una buona volta!). prima o poi doveva toccarmi questa sorta di abiura galileiana. Non c’è momento migliore per riparare al mio peccato che il ritiro nel ricovero per i poveri infermi costruito da Bernardino da Siena in quel di Barga, enclave fiorentina nella lucchesia, nel 1456, esattamente 400 anni prima della nascita di Sigmund Freud.
Poiché notoriamente “chi di spada ferisce, di spada perisce” come suggerì Gesù al focoso Pietro, confuso evidentemente dal fatto che lui stesso aveva precedentemente detto di essere venuto a portare la spada (Cristo,mettiamoci d’accordo una buona volta!). prima o poi doveva toccarmi questa sorta di abiura galileiana. Non c’è momento migliore per riparare al mio peccato che il ritiro nel ricovero per i poveri infermi costruito da Bernardino da Siena in quel di Barga, enclave fiorentina nella lucchesia, nel 1456, esattamente 400 anni prima della nascita di Sigmund Freud.
 In una recente ricerca della
In una recente ricerca della  Siamo forse giunti all’epilogo della carriera politica di Berlusconi, per alcuni un’epopea per altri un incubo lungo 17 anni. Tralascio molti altri aspetti di questa parabola e mi dedico all’analisi del sogno italiano di copiare i modelli sociali americani. Un’analisi poco freudiana e molto personale.
Siamo forse giunti all’epilogo della carriera politica di Berlusconi, per alcuni un’epopea per altri un incubo lungo 17 anni. Tralascio molti altri aspetti di questa parabola e mi dedico all’analisi del sogno italiano di copiare i modelli sociali americani. Un’analisi poco freudiana e molto personale.  Non si tratta del delirio florido di uno psicotico, ma è il risultato di studio della Keele University’s School of Psychology (Gran Bretagna), secondo cui le persone che imprecano riescono a tollerare il dolore fisico più a lungo rispetto a quelli che non dicono parolacce, in risposta ad un forte trauma o ad una disavventura.
Non si tratta del delirio florido di uno psicotico, ma è il risultato di studio della Keele University’s School of Psychology (Gran Bretagna), secondo cui le persone che imprecano riescono a tollerare il dolore fisico più a lungo rispetto a quelli che non dicono parolacce, in risposta ad un forte trauma o ad una disavventura. 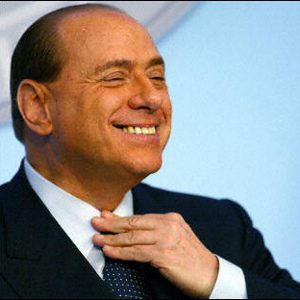 Chiusa, o quasi, la lenta agonia di Berlusconi, ci si chiede perché un uomo che sulla carta dominava Parlamento, Esecutivo e Comunicazioni, primo, secondo e quarto potere, si sia dimostrato così poco incisivo nel muovere le leve del potere. Capace di conquistarlo e di conservarlo, ma poco di usarlo, questo potere. La spiegazione più semplice è che non gli interessasse, in fondo, fare politica. A Berlusconi non interessava governare, ma controllare il potere per proteggere i propri interessi. È la spiegazione più feroce e becera, ma per ora mettiamola da parte…
Chiusa, o quasi, la lenta agonia di Berlusconi, ci si chiede perché un uomo che sulla carta dominava Parlamento, Esecutivo e Comunicazioni, primo, secondo e quarto potere, si sia dimostrato così poco incisivo nel muovere le leve del potere. Capace di conquistarlo e di conservarlo, ma poco di usarlo, questo potere. La spiegazione più semplice è che non gli interessasse, in fondo, fare politica. A Berlusconi non interessava governare, ma controllare il potere per proteggere i propri interessi. È la spiegazione più feroce e becera, ma per ora mettiamola da parte…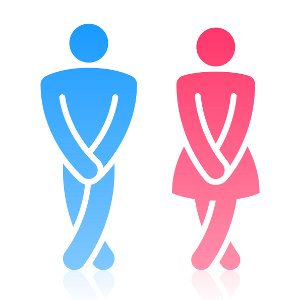 Se la vostra risposta fosse positiva, allora concordate su quanto ottenuto nella seguente ricerca in cui si dimostra che l’urgente bisogno di urinare può farvi prendere decisioni migliori in certi campi, e peggiori in altri.
Se la vostra risposta fosse positiva, allora concordate su quanto ottenuto nella seguente ricerca in cui si dimostra che l’urgente bisogno di urinare può farvi prendere decisioni migliori in certi campi, e peggiori in altri.  La pratica della mindfulness ci insegna molte cose in termini di consapevolezza e di “presenza” a noi stessi ma ci mostra anche come il respiro sia un “ancora di aggancio” per imparare a notare i nostri pensieri e le nostre emozioni e non rimanervi impantanati, ritenendoli la verità assoluta e non un prodotto della nostra mente.
La pratica della mindfulness ci insegna molte cose in termini di consapevolezza e di “presenza” a noi stessi ma ci mostra anche come il respiro sia un “ancora di aggancio” per imparare a notare i nostri pensieri e le nostre emozioni e non rimanervi impantanati, ritenendoli la verità assoluta e non un prodotto della nostra mente.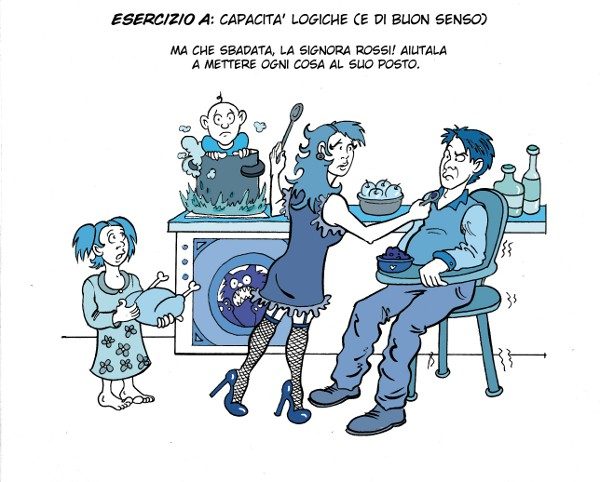
 Copertina 1: Elisa Sednaoui, dall’alto del suo vestito da sposa semitrasparente (sembra un po’ la sposa cadavere), con in mano guantoni di gomma e spazzolone per pulire, ci ricorda:
Copertina 1: Elisa Sednaoui, dall’alto del suo vestito da sposa semitrasparente (sembra un po’ la sposa cadavere), con in mano guantoni di gomma e spazzolone per pulire, ci ricorda: Seconda copertina: “Sono una mamma e mi sento ancora più donna”.
Seconda copertina: “Sono una mamma e mi sento ancora più donna”. L’ultima copertina (se vogliamo sceglierci come amica Irina Shayk) recita: Amo gli animali. Devo proprio rinunciare alle pellicce? E poi spiega: “Le persone che si scandalizzano per le pellicce spesso dimenticano le scarpe di cuoio che stanno calzando in quel preciso istante. Questa sì che è una contraddizione”. Con la stessa stringente logica con cui si potrebbe sostenere che siccome in alcuni stati esiste la pena di morte allora va benissimo andare in giro ad ammazzare la gente. Anche perché, in fondo, disprezzare i problemi legati all’ambiente è così cool al giorno d’oggi. Soprattutto in un posto come l’Italia, evidentemente situato all’interno del circolo polare artico, per cui, come per gli Inuit, usare una pelliccia è praticamente una questione di sopravvivenza.
L’ultima copertina (se vogliamo sceglierci come amica Irina Shayk) recita: Amo gli animali. Devo proprio rinunciare alle pellicce? E poi spiega: “Le persone che si scandalizzano per le pellicce spesso dimenticano le scarpe di cuoio che stanno calzando in quel preciso istante. Questa sì che è una contraddizione”. Con la stessa stringente logica con cui si potrebbe sostenere che siccome in alcuni stati esiste la pena di morte allora va benissimo andare in giro ad ammazzare la gente. Anche perché, in fondo, disprezzare i problemi legati all’ambiente è così cool al giorno d’oggi. Soprattutto in un posto come l’Italia, evidentemente situato all’interno del circolo polare artico, per cui, come per gli Inuit, usare una pelliccia è praticamente una questione di sopravvivenza.