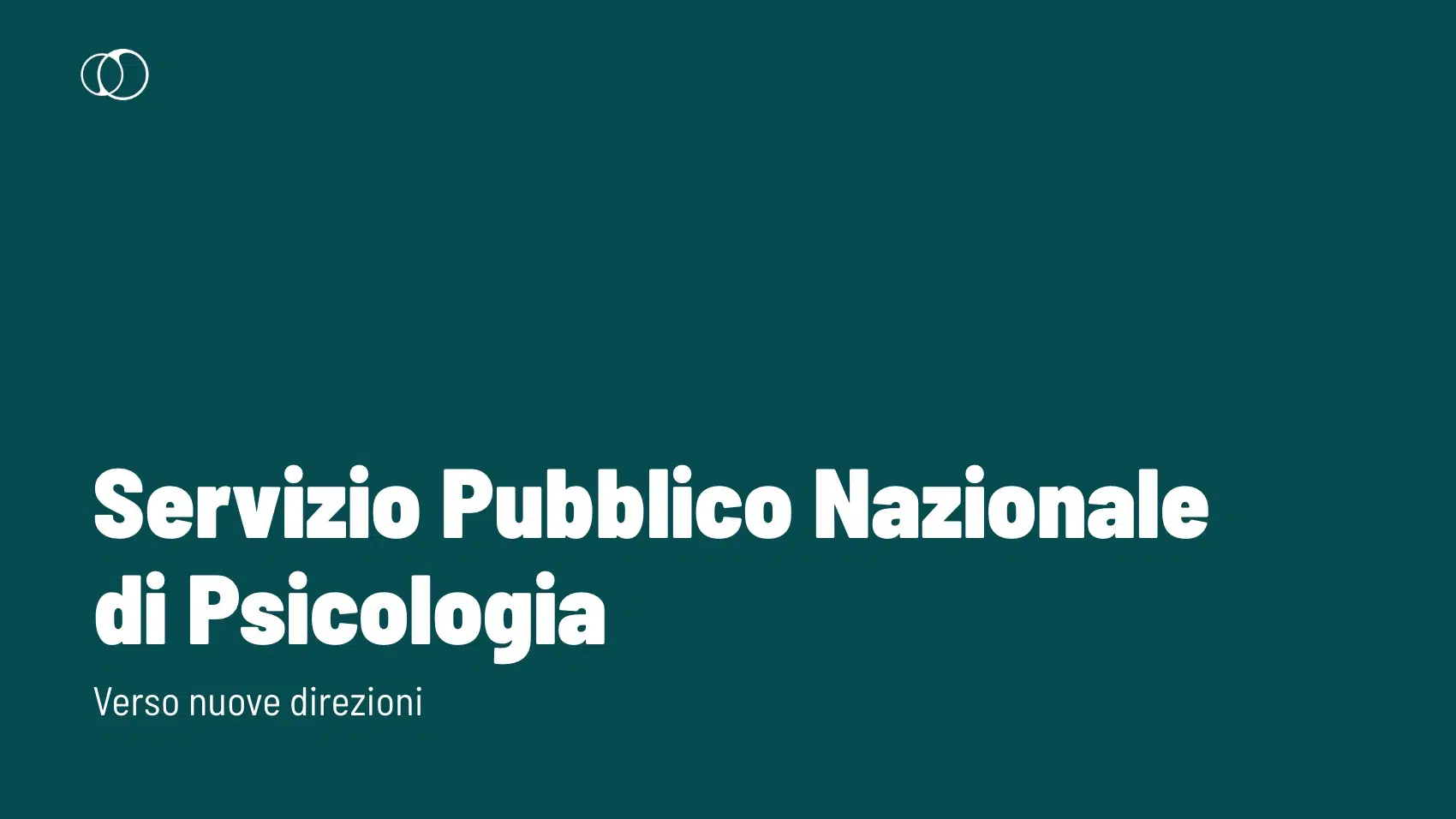Introduzione
Il crescente riconoscimento della salute mentale come determinante fondamentale del benessere collettivo ha accelerato negli ultimi anni la definizione di politiche pubbliche orientate a una presa in carico globale della sofferenza psichica. A tale proposito, due eventi recenti segnano una possibile svolta nell’architettura del welfare psicologico in Italia: la presentazione al Senato della proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un Servizio Pubblico Nazionale di Psicologia (luglio 2025) e il varo da parte del Ministero della Salute del nuovo Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025–2030.
Queste due iniziative, pur nate in ambiti differenti, convergono su un modello bio-psico-sociale e integrato, che riconosce la salute mentale come diritto di cittadinanza e come investimento strategico per la coesione sociale e la sostenibilità economica del SSN (Starace & Ferrara, 2020; WHO, 2021).
Il Servizio Pubblico Nazionale di Psicologia: accesso universale, prevenzione e capitale umano
La proposta di legge promossa dalla campagna “Diritto a stare bene” prevede un investimento strutturale da 3,3 miliardi di euro annui per la creazione di una rete psicologica pubblica, capillare e integrata. I principali assi di intervento includono:
- L’introduzione dello Psicologo di Base, figura destinata a diventare il primo riferimento nei percorsi di cura per disagio lieve e moderato, sul modello del general practitioner (Lazzari et al., 2022);
- La retribuzione della formazione specialistica universitaria degli psicologi, sul modello dei medici specializzandi;
- La stabilizzazione del Bonus Psicologo come misura strutturale;
- La creazione di una Autorità Garante dei Diritti Psicologici.
Lo studio dell’Università Sapienza e UnoBravo (2025) ha evidenziato una riduzione significativa degli accessi al pronto soccorso (-50%), degli esami di laboratorio (-15%) e delle visite specialistiche (-10%) tra soggetti in trattamento psicologico da almeno sei mesi. Questi dati confermano quanto documentato nella letteratura internazionale circa l’impatto dell’intervento psicologico precoce sulla riduzione della spesa sanitaria e sull’appropriatezza delle cure (Chiles et al., 1999; Layard & Clark, 2014; Andersson et al., 2014).
Il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025–2030: un quadro sistemico e multilivello
Contemporaneamente alla proposta legislativa, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata il nuovo PANSM 2025–2030. Il documento, redatto dal Tavolo Tecnico della Salute Mentale, definisce sei aree di intervento prioritario:
- Promozione, prevenzione e cura, con l’introduzione di alfabetizzazione emotiva, linguaggio antistigma, e programmi scolastici di salute mentale.
- Infanzia e adolescenza, con transizione assistita dai servizi di neuropsichiatria infantile a quelli per adulti, équipe dedicate e attenzione ai disturbi del neurosviluppo.
- Ambito penale e forense, con integrazione tra REMS, giustizia minorile e servizi territoriali.
- Gestione del rischio clinico, attraverso la formazione, la prevenzione degli eventi critici e la tutela del benessere degli operatori.
- Integrazione socio-sanitaria, con strumenti come il Budget di Salute, la prescrizione sociale, l’abitare supportato e l’inclusione lavorativa.
- Formazione e ricerca, con focus su psicopatologie complesse, adolescenza, nuove dipendenze e perinatalità.
Il documento assume come pilastri concettuali:
- Il modello bio-psico-sociale (Engel, 1977),
- Il paradigma One Health/One Mental Health (WHO, 2022),
- La centralità della persona, intesa come attore attivo nei percorsi di cura, insieme a caregiver e comunità.
Le innovazioni del PANSM: strumenti operativi e nuovi ruoli professionali
Tra gli strumenti introdotti dal PANSM, si segnalano:
- Lo psicologo di primo livello, figura prevista anche nella proposta di legge della campagna Diritto a stare bene, incaricato della presa in carico precoce dei disturbi psicologici lievi e moderati.
- Il case management, con piani terapeutici individualizzati e continuità assistenziale (Muntingh et al., 2019).
- L’uso della telemedicina e dell’intelligenza artificiale, con attenzione alla validazione scientifica, all’etica e alla protezione dei dati.
- L’inclusione della salute mentale perinatale tra le priorità, con percorsi terapeutici e screening sistematici durante gravidanza e post-partum.
- La formalizzazione del ruolo dei Consultori familiari nella gestione della giustizia minorile.
Il PANSM prevede inoltre un sistema di monitoraggio basato su indicatori di esito e qualità della vita, a carico delle Regioni e del Ministero, sebbene non siano previste risorse aggiuntive.
Convergenze strategiche: verso un ecosistema pubblico per il benessere mentale
La proposta legislativa e il PANSM, pur distinti per origine, mostrano evidenti sinergie concettuali e strutturali:
Tali convergenze suggeriscono la possibilità di armonizzare e integrare le due progettualità, rendendo la salute mentale una priorità sistemica delle politiche sanitarie italiane. L’assenza di risorse dedicate nel PANSM costituisce tuttavia un limite potenziale, che potrebbe essere colmato attraverso l’approvazione della proposta di legge in Parlamento.
Il ruolo delle direzioni aziendali
Un elemento cruciale per l’effettiva implementazione del Servizio Pubblico Nazionale di Psicologia e del Piano Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025–2030 è rappresentato dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Ospedaliere. Queste strutture, in qualità di snodo operativo tra le politiche centrali e la rete dei servizi territoriali, sono chiamate ad assumere un ruolo strategico in termini di pianificazione, allocazione delle risorse, coordinamento interprofessionale e valutazione degli esiti.
Nella logica delineata dal PANSM, le Direzioni Generali dovranno farsi promotrici di una riorganizzazione interna dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) in chiave integrata e multidisciplinare, favorendo l’interconnessione tra ospedale e territorio, tra servizi clinici, sociali e comunitari, nonché con il Terzo Settore. Sarà loro compito garantire:
- la definizione di piani aziendali per la salute mentale coerenti con le linee strategiche nazionali e regionali;
- l’inserimento strutturale dello psicologo di base e di primo livello nelle équipe multiprofessionali dei distretti e delle cure primarie;
- il coordinamento tra servizi di neuropsichiatria infantile e servizi per adulti, specie nella gestione della transizione e della continuità assistenziale;
- l’adozione di strumenti innovativi come il case management, la prescrizione sociale e il Budget di Salute;
- la valutazione dell’impatto degli interventi psicologici tramite indicatori di esito, accessibilità, qualità percepita e sostenibilità economica.
Le Direzioni Generali dovranno inoltre facilitare lo sviluppo della formazione in servizio per psicologi, medici e operatori sanitari, promuovendo una cultura organizzativa che valorizzi la salute mentale come componente trasversale dell’assistenza. In questo senso, il loro impegno sarà determinante anche per garantire equità di accesso su base territoriale, evitando disomogeneità tra Regioni e aree socio-economiche differenti (OCSE, 2023).
Infine, il rafforzamento delle funzioni di governance locale dovrà accompagnarsi a una responsabilità istituzionale trasparente, con meccanismi di monitoraggio e rendicontazione pubblica, in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e la Commissione Salute. Le Direzioni Generali sono dunque chiamate a essere agenti attivi del cambiamento, capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e giustizia sociale nell’ambito della salute mentale.
Conclusioni
Il Servizio Pubblico Nazionale di Psicologia e il PANSM 2025–2030 rappresentano due risposte complementari a un’urgenza comune: rendere la salute mentale parte integrante dei diritti sociali. L’introduzione di nuove figure professionali, la valorizzazione del capitale umano, la prevenzione precoce e l’integrazione socio-sanitaria sono elementi fondanti di una riforma attesa da decenni. Le evidenze scientifiche, sia sul piano clinico che economico, confermano la sostenibilità e l’efficacia di questi approcci.
Affinché tali trasformazioni si realizzino concretamente, sarà necessaria una governance multilivello, il coinvolgimento attivo delle Regioni, l’allocazione di risorse stabili e una visione condivisa del benessere psicologico come diritto e come infrastruttura essenziale per la società.