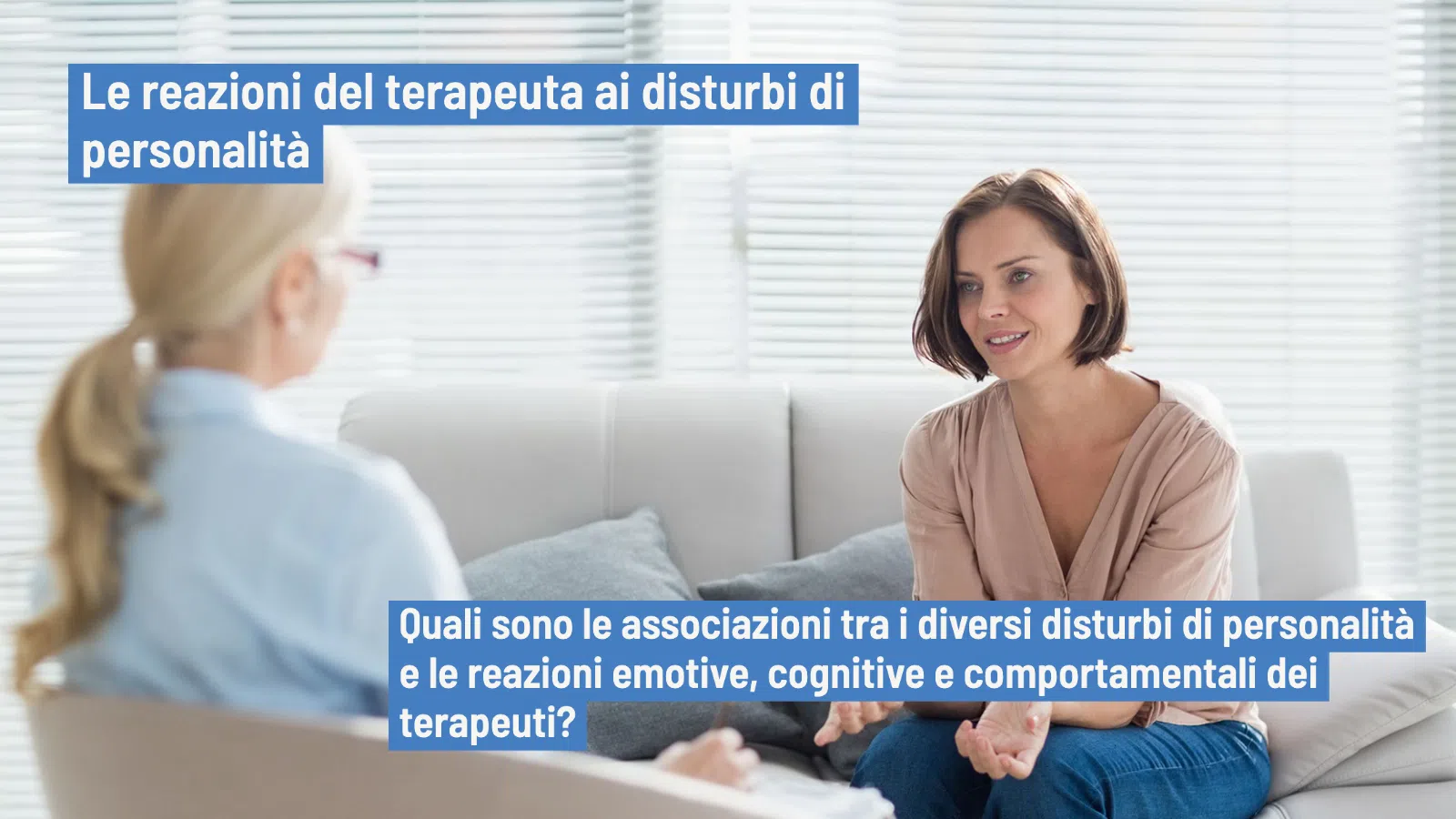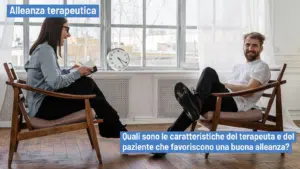Lo studio di Stefana e colleghi (2020) ha lo scopo di indagare l’associazione tra i disturbi di personalità dei pazienti e le reazioni emotive, cognitive e comportamentali degli psicoterapeuti. È utile esplorare questa tematica perché i terapeuti che lavorano con pazienti difficili possono avere un rifiuto verso i propri stati emotivi e così influenzare negativamente la psicoterapia (Yakeley et al., 2014).
Le reazioni del terapeuta e il fenomeno del controtransfert
Quando si parla delle reazioni del terapeuta non è possibile non citare il controtransfert, fenomeno psicologico teorizzato da Freud nel 1909 per far riferimento alle difficoltà che l’analista incontra nella relazione con il paziente (Stefana, 2015). Freud, concependo l’analista come uno schermo opaco in cui il paziente proietta il suo mondo interno, adottò una visione monopersonale della relazione terapeutica. A partire dal 1940, però, la letteratura iniziò a diffondere una nuova visione del fenomeno in cui la soggettività e l’identità dell’analista sono inseparabili dall’essere una persona con sentimenti e pensieri che, inevitabilmente, vengono attivati nella terapia. Quest’idea diede una svolta verso una visione bipersonale della situazione terapeutica (Stefana, 2017), dove la relazione terapeuta-paziente gode di una maggiore enfasi. A progredire in questa direzione, infine, fu la definizione di controtransfert complementare (Epstein e Feiner, 1988), secondo cui il controtransfert rappresenterebbe tutte le reazioni del terapeuta che completano lo stile relazionale del paziente. Tali reazioni sarebbero il risultato delle proiezioni del paziente sul terapeuta, che reagirebbe in modi comunemente attesi da altre persone nella vita quotidiana del paziente. Il terapeuta, in questo senso, dovrebbe utilizzare queste reazioni per comprendere meglio le dinamiche relazionali del paziente e per non metterle in atto.
Lo studio di Stefana e colleghi (2020)
La letteratura è concorde nel riportare che i disturbi di personalità tendono ad evocare reazioni emotive più fastidiose e problematiche nei terapeuti (Bateman e Fonagy, 2006; Gabbard, 2009, 2014; Kernberg, 1975, 2004; McWilliams, 2011). Questi pazienti mostrerebbero dei pattern interpersonali ricorrenti che, nella relazione terapeutica, metterebbero a dura prova il clinico (Hopwood, 2018). Tuttavia, i risultati sono discordanti in merito a se e come i differenti disturbi di personalità scatenino reazioni differenti fra i terapeuti. Conoscere le reazioni di quelli che lavorano con pazienti difficili è importante dal momento in cui esse possono servire a comprendere il mondo psicologico del paziente e assumere così utilità diagnostica.
In questa direzione, Stefana e colleghi (2020) si sono posti lo scopo di fornire una valutazione complessiva delle associazioni fra i diversi disturbi di personalità e le reazioni emotive, cognitive e comportamentali dei terapeuti nel contesto della psicoterapia individuale. Ciò che è emerso dai risultati è una forte convergenza nel mostrare che i differenti funzionamenti di personalità suscitano reazioni diverse ma abbastanza coerenti fra tutti gli psicoterapeuti partecipanti. In particolare:
- sono emerse associazioni tra il cluster A (caratterizzato da disturbi di personalità tipicamente eccentrici e bizzarri) e sentimenti di non apprezzamento e svalutazione da parte del terapeuta (Betan et al., 2005; Meehan et al., 2012);
- sono emerse associazioni tra il cluster B (caratterizzato da disturbi di personalità tipicamente drammatici, emotivi e disregolati) e sentimenti di inadeguatezza, incompetenza, mancanza di speranza, ansia, desiderio di evitare il paziente o forti affetti negativi (come repulsione o risentimento) da parte del terapeuta (Betan et al., 2005; Tanzilli et al., 2017);
- sono emerse associazioni tra il cluster C (caratterizzato da disturbi di personalità tipicamente ansiosi e fobici) e desiderio di protezione o affetti negativi da parte del terapeuta (Betan et al., 2005; Meehan et al., 2012).
Questi risultati sono in accordo con quanto suggerito dalla letteratura clinica che afferma che i pazienti con disturbi di personalità appartenenti al cluster A o al cluster B tendono ad evocare reazioni emotive più problematiche nei terapeuti rispetto ai disturbi del cluster C (Gabbard, 2014; McWilliams, 2011). In generale, quindi, i risultati ottenuti sono concordi nel suggerire che i pazienti che condividono gli stessi disturbi di personalità (e che quindi condividono modi simili di sentire, pensare e comportarsi) tendono a scatenare reazioni cognitive, emotive e comportamentali specifiche e simili negli psicoterapeuti. Inoltre, queste associazioni sembrano essere indipendenti sia dalle caratteristiche non diagnostiche dei pazienti sia dagli approcci degli psicoterapeuti e dai loro anni di esperienza professionale. Ciò consente di ipotizzare l’esistenza di reazioni in qualche modo “oggettive” che costituiscono la risposta tipica del terapeuta al paziente sulla base dello specifico disturbo di personalità di quest’ultimo. Parallelamente, il riscontro di lievi differenze nelle reazioni ai pazienti con profili di personalità simili ha portato gli autori a ipotizzare anche l’esistenza di reazioni “soggettive”, in linea col concetto di controtransfert: tali reazioni, di fatto, si baserebbero più sulla storia di vita del singolo terapeuta e sulla qualità della formazione psicoterapeutica ricevuta.
Conclusioni
In conclusione, è possibile assumere che se le reazioni oggettive possono essere utili per comprendere i tratti di personalità del paziente e il suo impatto sugli altri, la gestione efficace delle reazioni soggettive (che può avvenire solo se il terapeuta è sufficientemente in grado di riconoscere e tollerare le sue vulnerabilità) può dirsi correlata a migliori risultati psicoterapeutici (Hayes et al., 2018). In questa direzione, future ricerche avranno il compito di indagare longitudinalmente il peso specifico degli elementi interconnessi della reazione del terapeuta (cioè, il soggettivo e l’oggettivo), considerando le caratteristiche professionali, personali e interpersonali sia del terapeuta che dei pazienti; solo così si avrà una migliore comprensione di ciò che è all’interno della reazione complessiva del terapeuta e del suo valore diagnostico e/o terapeutico (Stefana et al., 2020).