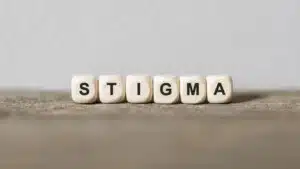La stigmatizzazione dei disturbi mentali è un problema importante nelle scienze sociali e uno dei più importanti ostacoli nel campo dell’assistenza alla salute mentale pubblica.
Cosa vuol dire stigma?
Il punto di partenza per definire lo stigma del disturbo mentale è la definizione di Goffman (1963), che definisce lo stigma come un attributo che produce un profondo discredito. Il riconoscimento di questo attributo conduce la persona stigmatizzata ad essere “declassata da persona completa, dotata di un valore e a cui siamo comunemente abituati, a persona segnata, screditata” (p. 636). Questo presenta lo stigma come la relazione tra l’attributo e lo stereotipo.
Nei termini di Goffman (1963), gli attributi possono essere classificati in tre gruppi principali:
- difetti fisici (es. disabilità fisica o deformità visibile);
- imperfezioni di carattere individuale, (es. malattia mentale, condanna penale);
- stigmi tribali (es. etnia, genere, età.).
Quali effetti ha la stigmatizzazione dei disturbi mentali?
La letteratura indica che la stigmatizzazione delle persone con disturbi mentali è piuttosto diffusa nella popolazione generale (Crisp, Gelder, Goddard, & Meltzer, 2005; Link, Phelan, Bresnahan, Stueve, & Pescosolido, 1999). Tuttavia, esiste una variazione significativa a seconda delle diverse componenti dello stigma che sono state considerate (Corrigan, 2004).
Lo stigma ha molti effetti negativi sulle persone che vivono con un disturbo mentale, tra cui: assenza o ritardo nel ricercare supporto o un trattamento, diminuzione della qualità della vita, minori opportunità di lavoro, aumento della solitudine, minore possibilità di ottenere un alloggio, e diminuzione dell’autostima (Corrigan, 2004; Hansson, Stjernswärd, & Svensson, 2014; Lawrie, 1999; Link, Phelan, Bresnahan, Stueve, & Pescosolido, 1999). Inoltre, lo stigma non ha soltanto un impatto sulle persone che soffrono di un disturbo mentale, ma anche sui loro parenti e su chi si prende cura di loro (Muralidharan, Lucksted, Medoff, Fang, & Dixon, 2016). Diversi studi hanno rilevato che un aumento dello stigma è associato all’“etichettare” una persona come mentalmente malato, inoltre il riconoscimento dei disturbi mentali risulta essere piuttosto basso nella popolazione (Jorm, 2000; Martin, Pescosolido, & Tuch, 2000; Peluso & Blay, 2009). Secondo Jorm e colleghi (1997) alla base dello stigma è presente una bassa conoscenza dei disturbi mentali; introducono inoltre il termine “Mental Health Literacy” (MHL), con cui si fa riferimento ad aspetti di riconoscimento dei disturbi mentali, di ricerca di informazioni sulla salute mentale, alla conoscenza dei fattori e delle cause di rischio (ad esempio, biomedico, psicosociale), dei trattamenti (cioè farmaci o psicoterapia) e della prognosi. Per di più, MHL è essenziale per promuovere la diagnosi precoce e il trattamento dei problemi di salute mentale, quindi, portando a migliori risultati a lungo termine (Jorm, 2000; Wright et al., 2005).
Nello studio di Serra e colleghi (2013) è stato dimostrato che, per gli studenti delle scuole superiori italiane, la conoscenza dei disturbi mentali era positivamente correlata con la disponibilità a fornire aiuto a persone con un disturbo mentale, ed entrambi erano correlati ad atteggiamenti più positivi verso le persone con psicosi. Questo conferma che una conoscenza della salute mentale è correlata sia ad uno stigma inferiore sia ad una ridotta distanza sociale dalle persone con gravi disturbi mentali. Gli studenti sono risultati avere una sufficiente conoscenza dei disturbi mentali, tuttavia, sebbene abbiano mostrato dubbi sulla natura psicopatologica dei disturbi, gran parte degli studenti rimaneva piuttosto scettica riguardo l’efficacia del trattamento o sulla possibilità di recupero delle persone con gravi disturbi mentali. In questo studio, i soggetti con punteggi di stigma più alto erano anche meno disposti a fornire aiuto a qualcuno con un disturbo mentale. Le studentesse hanno mostrato una maggiore conoscenza dei disturbi mentali rispetto agli studenti maschi ed erano più propense a offrire un supporto volontario a persone con disturbi mentali, in accordo con quanto sostenuto da Horowitz (1982). Tuttavia, è emersa un’alta tendenza di atteggiamenti non stigmatizzanti in quei soggetti che hanno avuto una storia familiare di psicosi. Questo potrebbe indicare che l’esposizione diretta alla psicosi può abbassare lo stigma e ridurre la distanza sociale da persone con disturbo mentale (Serra et al., 2013). Tuttavia, il grado di stigma dipende largamente dal disturbo a cui è attribuito. Uno stigma maggiore è correlato ai disturbi mentali più gravi, in particolare alla schizofrenia e alla psicosi (Angermeyer & Matschinger, 1997; Norman, Sorrentino, Windell, & Manchanda, 2008). I pazienti con diagnosi di psicosi hanno maggiore probabilità di venire emarginati e discriminati a causa dello stigma correlato (Buizza et al., 2007).
A questo proposito vari studi hanno rilevato che il livello dello stigma aumenta in modo esponenziale a partire dalla depressione, per poi passare alla schizofrenia fino a raggiungere il picco con i disturbi da uso di sostanze. Il forte stigma nei confronti di persone con disturbi da uso di sostanze potrebbe essere spiegato in diversi modi. Per esempio, lo stigma può verificarsi più frequentemente perché le persone possono essere considerate molto più deboli e responsabili per la loro condizione rispetto alle persone con schizofrenia o depressione. Inoltre, sia i soggetti con disturbi da uso di sostanze che soggetti con schizofrenia sono stati etichettati come pericolosi e imprevedibili. La pericolosità percepita è stata identificata come un mediatore molto importante della stigmatizzazione; di fatto può rafforzare il rifiuto e la distanza, aumentando così la discriminazione e l’emarginazione causate dallo stigma (Crisp, Gelder, Goddard, & Meltzer, 2005; Hengartner et al., 2012; Link, Phelan, Bresnahan, Stueve, & Pescosolido, 1999; Pescosolido et al., 2010). A sua volta la paura dell’emarginazione può rafforzare la stigmatizzazione interiorizzata nelle persone con un disturbo mentale e può anche ridurre l’accesso alle cure.
Le persone spesso si astengono dal ricercare supporto e cure di cui hanno bisogno per paura di venire etichettati negativamente da parte di amici o parenti per la loro condizione mentale (Angermeyer & Matschinger, 2003; Thornicroft, 2008). Inoltre, lo stigma interiorizzato riduce l’autostima. Gli atteggiamenti negativi sono particolarmente forti contro chi fa uso di farmaci per trattare i disturbi mentali (Jenkins & Carpenter-Song, 2009; Sorsdahl & Stein, 2010). Ad esempio, l’utilizzo di antidepressivi per il trattamento del Disturbo Depressivo Maggiore è spesso percepito come un segno di debolezza emotiva e incapacità ad affrontare i problemi (Castaldelli-Maia et al., 2011). Oltre ciò, la stigmatizzazione di per sé esercita un’influenza negativa sia sul decorso che sull’esito del trattamento del disturbo (Van Zelst, 2009). Ci sono prove che lo stigma contro i disturbi mentali incide seriamente sulla volontà dei giovani di cercare aiuto per risolvere la propria condizione (Fröjd, Marttunen, Pelkonen, von der Pahlen, & Kaltiala-Heino, 2007; Mukolo, Heflinger, & Wallston, 2010; Pescosolido, Martin, Lang, & Olafsdottir, 2008; Quinn, Wilson, MacIntyre, & Tinklin, 2009; Yap & Jorm, 2011). In particolare, i giovani maschi sembrano essere maggiormente influenzati da atteggiamenti stigmatizzanti, determinando così una riduzione nella ricerca di supporto sociale (Eisenberg, Downs, Golberstein, & Zivin, 2009; Gonzalez, Alegria, & Prihoda, 2005). Qui di seguito possiamo menzionare brevemente due conseguenze deleterie della stigmatizzazione.
In primo luogo, lo stigma pubblico si traduce, nella vita di tutti i giorni, in discriminazioni nelle interazioni interpersonali e negli stereotipi e con immagini negative riguardanti i disturbi mentali nei media (Wahl, 1995). Secondo, la discriminazione strutturale include istituzioni private e pubbliche che intenzionalmente o involontariamente limitano le opportunità delle persone con disturbi mentali (Corrigan, Markowitz, & Watson, 2004).
Come riportato da Thornicroft, Rose, Kassam, e Sartorius (2007), per quanto riguarda lo stigma verso le persone con disturbi mentali, l’obiettivo finale degli interventi non è solo aumentare la conoscenza e migliorare gli atteggiamenti (ridurre il pregiudizio), ma anche migliorare il comportamento reale (ridurre la discriminazione).