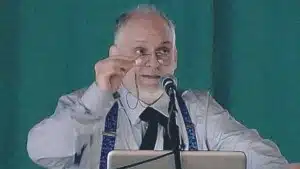Nonostante l’obiettivo per cui la meta-analisi nasce sia proprio superare i limiti di ciascun studio singolo, spesso si verifica un effetto iatrogeno secondo cui alcuni limiti metodologici non solo non vengono superati, ma addirittura esacerbati: se ne aggiungono ulteriori e spesso ancora più ostici.
La meta-analisi è una tecnica clinico-statistica finalizzata a integrare i risultati generati da molteplici studi clinici, con l’obiettivo di ottenere un indice quantitativo attendibile, che possa trascendere i limiti intrinseci degli studi singoli. Tale ‘studio degli studi’ combina i risultati generati da differenti studi singoli, al fine di incrementare la numerosità campionaria complessiva e la relativa potenza statistica; per poter auspicare a conclusioni teoricamente più attendibili rispetto a quelle raggiunte da uno studio singolo (Dalle Grave & Calugi, 2019). Nonostante l’obiettivo per cui la meta-analisi nasce sia proprio superare i limiti di ciascun studio singolo, spesso si verifica un effetto iatrogeno secondo cui alcuni limiti metodologici non solo non vengono superati, ma addirittura esacerbati: se ne aggiungono ulteriori e spesso ancora più ostici.
Le meta-analisi possono, infatti, essere considerate attendibili e aderenti al dato soltanto quando includono studi di alta qualità con omogeneità campionaria e metodi di studi analoghi; sono, invece, frequenti casi di eclettismo metodologico che conducono a conclusioni clinicamente non significative, specialmente in ambito psicologico e psicoterapico (Barnard, Willett, & Ding, 2017). Nonostante ciò, le meta-analisi continuano a essere considerate come la tecnica di ricerca più autorevole e d’elezione per l’analisi della letteratura concernente la psicologia e la psicoterapia, al punto tale da influenzare le linee guida sanitarie internazionali (Dalle Grave & Calugi, 2019).
Generalmente la problematica più ostica si verifica nel momento in cui all’interno di una meta-analisi si presenta un’eccessiva varietà d’inclusione degli studi: estrema eterogeneità nei metodi, inclusione di campioni eterogenei, somministrazione di trattamenti disomogenei, ma raggruppati nella medesima categoria. Nell’ambito dei disturbi alimentari, ad esempio, una meta-analisi ha inglobato studi fortemente sottodimensionati per poter rilevare una significatività clinica e ha raggruppato format eterogenei di terapia cognitivo-comportamentale (Kraemer & Blasey, 2015). Un’altra, invece, ha incluso in un’unica categoria trattamenti eterogenei per l’anoressia nervosa, combinando campioni con target d’età adulto e adolescenziale; nonostante sia ormai noto in letteratura che gli adolescenti tendenzialmente manifestano una migliore risposta al trattamento rispetto agli adulti (Calugi, Dalle Grave, Sartirana & Fairburn, 2015), adoperando differenti misure di outcome e tempi di esito non omogenei (Murray, Quintana, Loeb, Grifths, & Le Grange, 2019). La diretta conseguenza è che entrambe le meta-analisi non hanno rilevato differenze significative nell’esito dei diversi trattamenti (van den Berg et al., 2019). Vengono di seguito riportati alcuni dei limiti metodologici più frequentemente riscontrati nelle meta-analisi: bassa potenza statistica (Byrne et al., 2017), scarsa validità interna e implementazione del trattamento psicologico non accurata (Zipfel et al., 2014), misure di outcome e tempi di misurazione eterogenei (Lock, Kraemer, Jo, & Couturier, 2018) e infine poca chiarezza sulla definizione di drop-out, come ad esempio l’inclusione di pazienti ospedalizzati durante la psicoterapia (Lock et al., 2010; Zipfel et al., 2014). In tali casistiche l’esito comporta spesso risultati inattendibili, come ad esempio riscontrare la medesima efficacia in tutti i trattamenti analizzati (Grenon et al., 2018); senza alcun criterio evidence-based per poterlo affermare.
Le meta-analisi imprecise, che affermano ugual efficacia delle terapie psicologiche oggetto d’analisi, conducono a due conseguenze potenzialmente iatrogene: 1) la credenza erronea secondo cui non sarebbe poi così vantaggioso ricercare e intraprendere trattamenti evidence-based 2) la riduzione del desiderio dei clinici di apprendere e implementare modelli teorici e clinici evidence-based (Lock, Kraemer, Jo & Couturier, 2018). Le meta-analisi possono, dunque, continuare a essere uno strumento di ricerca autorevole, al fine di far progredire la ricerca sui trattamenti psicologici e psicoterapici; a patto che venga garantita una certa precisione metodologica e aderenza al dato effettivo.
Spesso alcune meta-analisi combinano studi con campioni e metodi estremamente eterogenei, perdendo così i reali effetti dei singoli studi; per la semplice spiegazione teorica secondo cui una maggiore numerosità di studi assemblati implicherebbe una popolazione più ampia e un conseguente maggior potere statistico. In questo modo il rischio sarebbe quello di inficiare la differenziazione dei reali gradi di efficacia di ciascun trattamento analizzato: trattamenti non realmente superiori (o inferiori) figurerebbero come tali (Dalle Grave & Calugi, 2019). Considerato il potere intrinseco delle meta-analisi di poter influenzare la politica sanitaria e l’attività clinica, viene di seguito presentano un vademecum di suggerimenti per poter garantire una certa solidità metodologica (Barnard et al., 2017):
- 1) implementare una revisione da parte di esperti sul tema e sulla progettazione di una meta-analisi
- 2) richiedere agli autori della meta-analisi di confrontarsi con gli autori dei singoli studi per garantire una corretta rappresentazione dei dati
- 3) chiedere agli autori della meta-analisi di condividere i metodi e la sintesi dei dati
- 4) includere i dati originali dello studio, non soltanto il dato di sintesi pubblicato
- 5) creare un sistema di monitoraggio dei conflitti d’interesse tra i ricercatori coinvolti nelle meta-analisi, al fine di arginarli.
In sintesi, alla luce di quanto riportato, risulta necessario e doveroso aggiornare le linee guida esistenti (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009), con l’obiettivo di trascendere i limiti emersi nelle revisioni di meta-analisi riguardanti i trattamenti psicologici; infine, potrebbe risultare utile avviare corsi di formazione ad hoc per ricercatori e giornalisti scientifici, affinché possa avvenire una divulgazione accurata delle revisioni dei trattamenti psicologici (Dalle Grave & Calugi, 2019).