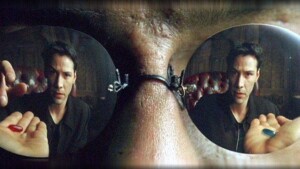Diverse ricerche hanno cercato di determinare le varianti personologiche, emotive e ambientali che agiscono nel determinare l’ipocrisia morale dimostrata da un individuo per comprendere perché alcune persone siano più propense di altre ad agire moralmente.
Viene chiamata ipocrisia morale, la tendenza a predicare un certo tipo di comportamento come corretto, ma agire poi diversamente: il tentativo sarebbe quello di apparire moralmente retti pubblicamente (Barden et al., 2005) ma tentare ugualmente di trarre un beneficio personale dalle situazioni (Batson et al., 2002; Monin & Merritt, 2012). Se quindi a livello intrapersonale l’ipocrisia morale si traduce nel proverbiale ‘predicare bene ma razzolare male’, diversa è la forma che questo bias prende se consideriamo il livello interpersonale: le ricerche sul Moral Judgment hanno svelato un altro fenomeno comune, ovvero la tendenza a giudicare più severamente le trasgressioni messe in atto dagli altri rispetto alle proprie (Sun et al., 2012).
Una plausibile spiegazione per questo ‘doppio standard’ sarebbe dovuta alla distanza morale dalla situazione: nel giudicare infatti le proprie trasgressioni le persone non potrebbero fare a meno di figurarsi una situazione reale che li coinvolge, garantendo una bassa distanza psicologica che lascia spazio ad una connotazione emotiva o attenuanti situazionali, laddove invece nel giudicare gli altri ci si appella a degli standard morali più rigidi e astratti (Sun et al., 2012).
Sicuramente, tutti possiamo avere un’idea di come agire moralmente implichi talvolta il porre un freno alla propria soddisfazione egoistica, orientandosi verso comportamenti più altruistici (Martinsson et al., 2014), rimandando quindi l’idea di uno sforzo attivo compiuto dall’individuo per esercitare autocontrollo e allenare il proprio ‘muscolo morale’; tuttavia, vi sono variabili che influenzano la capacità di esercitare l’autocontrollo e possono portare ad uno stato detto Ego Depletion caratterizzato da una ridotta capacità di autoregolazione e riduzione delle inibizioni, disregolazione emotiva (Gailliot & Baummeister, 2007), performance intellettuali temporaneamente ridotte e minor controllo degli impulsi (Vohs & Faber, 2007).)
Diverse ricerche hanno cercato di determinare le varianti personologiche, emotive e ambientali che agiscono nel determinare l’ipocrisia morale dimostrata da un individuo per comprendere perché alcuni individui siano più propensi di altri ad agire moralmente.
La propensione al senso di colpa è un tratto personologico che sembra agire come una sorta di barometro morale, che fornisce feedback relativamente costanti e stabili nel tempo circa la nostra accettabilità morale e che guida il nostro comportamento; inoltre, gli individui che riferiscono un senso di colpa maggiore risultano essere più empatici e propensi a considerare il punto di vista altrui (Cohen et al., 2012). È stato postulato che il senso di colpa possa anche avere la capacità di contrastare gli effetti dell’Ego Depletion: non richiedendo energie cognitive supplementari per risolvere dilemmi morali, l’individuo riuscirebbe quindi ad agire in accordo con i propri e condivisi standard morali anche in quelle situazioni in cui le risorse cognitive risultano esaurite o rivolte altrove (Ren et al., 2014).
Un recente studio di Du e colleghi (2019) si è proposto di indagare gli effetti dell’Ego Depletion sull’ipocrisia morale, valutando inoltre una possibile moderazione del senso di colpa nell’estinguere questo effetto. I ricercatori hanno ideato due esperimenti, volti ad indagare i due differenti aspetti dell’ipocrisia morale sopra menzionati, ovvero quella intrapersonale e quella interpersonale.
Nel primo esperimento, dopo aver compilato un questionario sulla propensione al senso di colpa, ovvero la Guilt Proness Scale (GP-5), sono stati selezionati i 104 partecipanti che avevano totalizzato un punteggio più alto e altrettanti sono stati selezionati dal 30% che aveva registrato il punteggio inferiore. In seguito, i due gruppi sono stati sottoposti ad uno Stroop task, un compito di interferenza cognitiva, con l’intento di indurre diversi livelli di Ego Depletion.
Per valutare l’effetto sull’ipocrisia morale è stato usato il paradigma dell’assegnazione del compito (Tong & Yang, 2011), nel quale i soggetti decidono se assegnare un compito piacevole a sé stessi o ad un’altra persona, dopo aver dichiarato la propria intenzione di utilizzare un metodo imparziale come il lancio di una moneta. Dal momento che all’animazione di lancio di una moneta, che assegnava invariabilmente il compito più ambito all’altra persona, veniva ugualmente data al partecipante la possibilità di procedere manualmente con l’assegnazione, questo induceva a credere che i ricercatori registrassero solo la risposta finale, lasciando aperta la possibilità di barare e omaggiarsi con il task favorito. I ‘moral hypocrites’ sarebbero quindi quei soggetti che dichiarano che la maniera più corretta di assegnare un compito sia ricorrendo al metodo imparziale, ma che distorcono poi il risultato in loro favore quando hanno la percezione di non incorrere in sanzioni o reprimende da altri (Batson et al., 1997; 1999; 2002)
In seguito, sono stati proposti dei dilemmi morali su un’ipotetica situazione, che coinvolgeva il soggetto stesso o un personaggio fittizio di nome Chris, per i quali il soggetto doveva esprimere un grado di accettabilità su di una scala da 1 a 7.
I risultati ottenuti da Du e colleghi sono in linea con le precedenti ricerche nel campo del Moral Judgment: è stato riscontrato un effetto dell’Ego Depletion sull’ipocrisia morale, indicando una maggiore probabilità di ricorrere a comportamenti egoriferiti quando l’individuo risultava essere cognitivamente provato; inoltre, è stato confermato come gli individui che riportavano una minore disposizione al senso di colpa avessero maggiori probabilità di essere moral hypocrites. In linea con le aspettative degli sperimentatori, non è stata riscontrata alcuna differenza tra i due gruppi sottoposti ad un differente carico cognitivo quando interveniva il senso di colpa: l’aderenza a delle norme di comportamento, che risultano interiorizzate e quindi immediatamente disponibili senza necessitare di sforzo cognitivo, risentirebbero in maniera minore di una ridotta disponibilità di risorse per far fronte al dilemma.
Nel secondo esperimento, il gruppo con basso senso di colpa rispecchiava la nota tendenza ad essere più tollerante verso le proprie trasgressioni che non verso quelle degli altri. Gli individui caratterizzati da un forte senso di colpa non esibivano differenze significative in termini di tolleranza verso le trasgressioni proprie o altrui, anche quando si trovavano in una condizione di Ego Depletion maggiore; è inoltre emerso che in condizioni di basso sovraccarico cognitivo, gli individui inclini al senso di colpa si sono dimostrati più intransigenti verso loro stessi e meno propensi ad accettare l’idea di una trasgressione commessa da loro che non da altri.