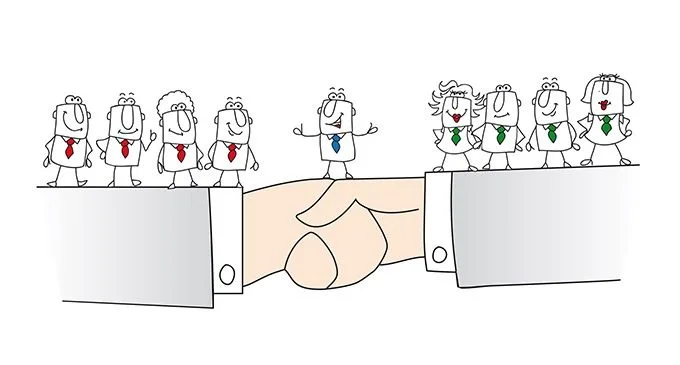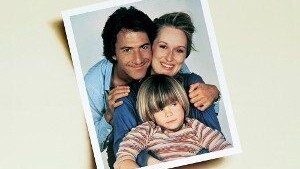Supponiamo che la commissione di un reato (un’appropriazione indebita, una diffamazione, delle lesioni personali…) abbia dato luogo ad una relazione conflittuale tra l’autore e la vittima, oppure che l’escalation di un conflitto si sia espressa attraverso la commissione di un reato (ad esempio, ingiurie, minacce, percosse…)
Alberto Quattrocolo, Associazione Me.Dia.Re
Supponiamo che la figlia di un paziente deceduto sia in conflitto con un medico dell’ospedale in cui l’uomo era ricoverato e che, per quanto alcuni accertamenti sembrino escludere l’esistenza di una responsabilità professionale, la donna sia convinta di una negligenza colpevole e letale da parte del medico. E supponiamo che il professionista sia adirato con la donna, a suo dire, immatura e irrazionale nel tradurre l’incapacità di accettare la morte del padre nella ricerca di un capro espiatorio e nell’accusare l’ospedale di mascherare degli errori inesistenti..
Supponiamo ancora che una coppia si stia separando e che i due coniugi stiano lottando per ottenere l’affidamento dei due figli accusandosi reciprocamente di essere genitori inadeguati.
Supponiamo che alcuni lavoratori siano in conflitto tra di loro e che ciò metta in difficoltà il loro responsabile, comprometta la loro produttività e, in generale, nuoccia all’ente, generando anche malessere nei colleghi.
Per tali situazioni la nostra società dispone di alcune risorse di diversa efficacia e con diversi obiettivi: tra queste, oggi, in molte città, inclusa Torino, vi sono i servizi di mediazione, intesi come interventi realizzati da professionisti formati ad hoc.
Pertanto per situazioni come quelle accennate si realizzano attività o servizi di mediazione penale, mediazione sanitaria, mediazione familiare, organizzativo-lavorativa, ecc.
In cosa consiste la Mediazione
Cosa vuol dire, però, mediazione? Si tratta di una procedura finalizzata alla conciliazione, alla costruzione di un accordo?
La risposta è indubbiamente sì rispetto alla mediazione civile e commerciale recentemente introdotta dal legislatore nell’ordinamento italiano (con il D.Lgs. 28/2010) per alcune controversie in ambito civile e commerciale, ma al di fuori di quello specifico ambito, la risposta al quesito potrebbe essere no. Dipende, in realtà, dall’impostazione che si adotta, dal mandato in virtù del quale il mediatore interviene, dalla cornice istituzionale o normativa in cui la sua opera si inserisce.
A prescindere dal metodo e dalla cornice, però, vi è un aspetto, un ingrediente, che è o, almeno, dovrebbe essere considerato, irrinunciabile in tutte le ipotesi e le pratiche di mediazione: l’ascolto.
Ascolto ed empatia nella mediazione
Pur essendo esperienza comune che, quando si litiga, le emozioni spesso prendono il sopravvento sulla nostra razionalità, la dimensione emotiva è, in generale, quella meno riconosciuta e accolta in tutte le sedi nelle quali il conflitto tradizionalmente approda per essere risolto.
Ciò accade tipicamente nel procedimento giurisdizionale, dove il terzo (il giudice), tentando di accertare i fatti ed esaminando la legittimità delle posizioni portate e delle condotte tenute, per stabilire chi ha ragione e chi ha sbagliato, non si occupa – non può farlo: non è la sua funzione – di come si sentono le parti che gli stanno di fronte. Mentre, questo aspetto, a prescindere dal paradigma adottato, è un aspetto centrale del percorso di mediazione. Infatti, anche per quelle impostazioni che non esaltano la dimensione empatica, il sapere far sentire accolte le parti è fondamentale.
Tuttavia, il ricorso alla giustizia, nonostante l’entità notevole dei costi di varia natura implicati, continua ad essere la scelta più seguita dalle parti in conflitto. Perché?
Una risposta veloce (e un po’, ma non troppo, superficiale) potrebbe essere che si tratta di un sintomo dell’escalation conflittuale.
Soprattutto, però, questo aspetto pone un problema anche pratico, relativo al rendere accessibile un percorso mediativo anche a chi non vuole fin dall’inizio mettersi in discussione, a chi teme il confronto, a chi non è interessato a sentire le ragioni altrui, a chi non si fida della possibilità di trattare con un avversario considerato un campione di doppiezza e malafede.
Rispetto alle situazioni astrattamente suscettibili di essere gestite con interventi di mediazione familiare, penale, sanitaria e lavorativo-organizzativa, il quesito non è di scarso rilievo.
Certo, la domanda potrebbe contenere un trabocchetto nel senso che è suscettibile di essere tradotta nei seguenti termini: come si può persuadere delle persone a mediare un conflitto che non vogliono mediare?
Mediare è innanzitutto ascoltare
In realtà non si tratta di introdurre alla mediazione chi non vuole sentire neppure pronunciare tale parola, ma di offrire la possibilità di essere ascoltati anche a coloro che non si sentono fin dall’inizio disponibili a “mediare” i loro conflitti. E l’esperienza dice che non sono (siamo) pochi, anzi che sono (siamo) la maggioranza.
Offrire l’opportunità di conoscere lo strumento, semmai di sperimentarne un frammento, prima di scegliere se avvalersene o meno, significa dare un’occasione di ascolto. Un ascolto non condizionato né condizionante. E ascoltare, in tal caso, non significa cercare a tutti i costi una soluzione, né tentare di ‘guarire’ le persone dalle loro emozioni – e neppure procurargli vaghe consolazioni – ma tentare di comprendere quel che portano.
Infatti, un elemento di non poco conto da tenere presente è il seguente:
uno degli aspetti più difficili da gestire quando parliamo con dei terzi di un nostro conflitto è il timore di essere giudicati negativamente per il solo fatto di essere parti di una lite. Ci poniamo, spesso, in tal caso, in una posizione difensiva e cerchiamo di chiarire subito che è colpa della controparte se siamo in conflitto con essa.
Si può, allora, facilmente immaginare il sollievo che potrebbe derivarci, se il nostro interlocutore più che concentrare la sua attenzione su chi ha torto o ragione, su chi è il maggior responsabile della svolta conflittuale della relazione, su chi ha iniziato per primo le ostilità, ci facesse sentire non approvati ma compresi. E non solo rispetto al “caso”, cioè come parti, ma come esseri umani, liberandoci dall’onere di dover dimostrare in maniera inoppugnabile che siamo dalla parte della verità e della giustizia.
Una fondamentale premessa nel percorso di mediazione
Il conflitto, com’è noto, molto spesso sorge dalla sensazione di non essere riconosciuti e, comunque con la sua progressione induce i suoi attori a riconoscersi sempre meno, spingendoli a sviluppare rappresentazioni reciproche monodimensionali, spesso spregiative, all’insegna della spersonalizzazione e finanche della de-umanizzazione, con ciò impedendo ogni possibilità di ascolto reciproco e svuotando lo strumento della parola di ogni possibilità espressiva profonda.
Quando i mediatori (familiari, penali, sanitari, ecc.), il cui unico strumento è la parola, riescono, nel loro rapportarsi con gli attori del conflitto, a farli sentire riconosciuti nella loro tridimensionalità, come esseri umani, allora riducono di molto il vuoto, l’isolamento, che tante volte il conflitto crea negli individui, nelle famiglie, nei gruppi, nelle comunità e nelle organizzazioni.
In tal senso, dunque, fanno da ponte, riconnettono. E tale connessione tra il mediatore e ciascun soggetto in conflitto è la necessaria premessa per una successiva eventuale fase di riconoscimento reciproco tra i secondi.