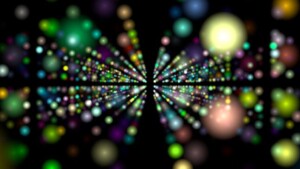Il dietilamide dell’acido lisergico (LSD) è una sostanza psichedelica potente che produce esperienze profonde e che ha attirato l’attenzione dei ricercatori che tutt’oggi cercano di esaminare il suo effetto sull’attività cerebrale attraverso studi di neuroimaging (Carhart-Harris et al., 2016).
Questo allucinogeno serotoninergico fu sintetizzato per la prima volta nel 1938, nonostante ciò i suoi effetti furono scoperti cinque anni dopo nel 1943 (Hofmann, 1980). Dato che questo psichedelico ha un’alta affinità con diversi recettori neurotrasmettitoriali, esso può alterare la coscienza (Carhart-Harris et al., 2016). Dopo la scoperta dei suoi effetti, negli anni ’50 e ’60 questa sostanza ha avuto un’attenzione maggiore nel campo della psicologia e della psichiatria: le prime ricerche neurofisiologiche sono state effettuate utilizzando l’elettroencefalografia (EEG) che ha segnalato un aumento della frequenza dei ritmi alpha e una riduzione della potenza oscillatoria (Fink, 1969). Attraverso altri studi fu scoperta un’attivazione nelle regioni temporali mediali durante le psicosi, la stessa attivazione che si verifica sotto LSD e in caso di altri effetti psichedelici (Monroe, 1961; Schwarz, 1956). Altre ricerche sottolineano come una stimolazione elettrica dei circuiti del lobo temporale produca allucinazioni come quelle prodotte dagli psichedelici, ad esempio la visione onirica e una percezione visiva distorta (Mégevand, 2014; Vignal, 2007). Tale sostanza fu resa illegale negli anni ‘60 a causa dell’aumento del suo uso ricreativo e della sua grande influenza (Carhart-Harris et al., 2015; 2016).
Lo scopo di questo studio è quello di esaminare gli effetti di tale sostanza attraverso tre tecniche di neuroimaging complementari: magnetoencefalografia (MEG), etichettatura degli spin arteriosi (ASL) e misurazione della modificazione dello stato di ossigenazione dell’emoglobina nei globuli rossi (Blood Oxygen Level Dependent – BOLD). Queste tre tecniche sono state applicate ad un gruppo di venti volontari sani per osservare i cambiamenti dell’attività cerebrale (Carhart-Harris et al., 2016). I volontari hanno partecipato a due giorni di scansione con la somministrazione di LSD e placebo, nello specifico sono stati somministrati attraverso iniezioni endovenose 75 g in 10 ml di soluzione salina e LSD e 10 ml di soluzione salina e basta (placebo) in 100 minuti. L’ipotesi formulata prevede che il circuito ippocampale, il circuito para ippocampale e le principali reti in stato di riposo – come la default mode network (DMN) – fossero implicate nel meccanismo d’azione della sostanza psichedelica (Carhart-Harris et al., 2016). Le sessioni hanno incluso scansioni di magnetoencefalografia (MEG) e risonanza magnetica funzionale (fMRI) della durata di 75 minuti: le misure sono state fatte durante uno stato di riposo mentre i soggetti avevano gli occhi chiusi e il picco massimo dell’effetto dell’LSD è stato raggiunto dopo 120-150 minuti dalle iniezioni. Le misurazioni BOLD sono state effettuate 135 minuti dopo la somministrazione, le restanti misurazioni magnetoencefalografiche dopo 225 minuti (Carhart-Harris et al., 2016).
I risultati evidenziano un aumento dell’attività della corteccia visiva primaria (V1), un aumento delle differenze del flusso sanguigno cerebrale della corteccia visiva (CBF) e una diminuzione della connettività tra la corteccia retrospleniale (RSC) e il paraippocampo, circuito collegato alla “dissoluzione dell’ego” già precedentemente trattato con ricerche sulla psilocibina (Carhart-Harris, 2016).
Un risultato significativo evidenzia come l’espansione dell’attività della corteccia visiva primaria (V1) è fortemente correlato alle allucinazioni visive che suggeriscono come l’attività cerebrale intrinseca eserciti una grande influenza nell’elaborazione visiva in uno stato psichedelico rispetto a delle condizioni normali (Carhart-Harris et al., 2016): questo risultato può spiegare come normalmente le funzioni psicologiche, come la cognizione o le emozioni, possano “colorare” l’esperienza visiva in uno stato psichedelico (Carhart-Harris et al., 2019).