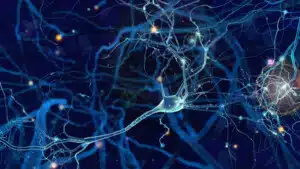Gli scienziati del Florey Institute Of Neuroscience and Mental Health stanno studiando il legame tra COVID-19 e aumento dell’incidenza del morbo di Parkinson
Ad oggi sappiamo che il COVID-19, oltre alle crisi respiratorie, ha anche conseguenze neurologiche, come si può evincere dalla presenza di sintomi quali: encefaliti e iposmia (perdita dell’olfatto); in particolare, quest’ultimo sintomo, si presenta in circa il 90% dei pazienti (Beauchamp et al., 2020).
A causa dei sintomi di stampo neurologico, i ricercatori si stanno chiedendo se ci potrebbero essere altre conseguenze prossime, riscontrabili a livello cerebrale.
Il modo in cui il virus arrivi al sistema nervoso centrale è tutt’oggi sconosciuto, tuttavia già il semplice fatto che sia in grado di arrivarci è sintomo di pericolo cerebrale (Beauchamp et al., 2020).
Il timore che attanaglia l’attuale mondo scientifico è che il virus in questione potrebbe dare origine a un processo neurodegenerativo (Beauchamp et al., 2020).
Gli scienziati del Florey Institute Of Neuroscience and Mental Healt stanno studiando il legame tra COVID-19 e aumento dell’incidenza del morbo di Parkinson (Beauchamp et al., 2020).
La presenza di un sintomo quale l’iposmia è indizio del fatto che ci sia la presenza di un’infiammazione acuta a livello del sistema olfattivo; l’infiammazione gioca un ruolo importante nella genesi delle malattie neurodegenerative, soprattutto nel morbo di Parkinson. Esso consiste nella perdita dei neuroni dopaminergici (cellule che producono dopamina) presenti a livello della substantia nigra e della regione mesoencefalica, ad oggi, la causa che porta alla morte di queste cellule è sconosciuta (Poewe et al., 2017). I sintomi caratteristici del Parkinson sono le difficoltà motorie, tuttavia, con il passare del tempo, e la conseguente neurodegenerazione, compaiono anche sintomi di stampo cognitivo-comportamentali; si tratta di un disturbo che si manifesta principalmente tra gli anziani dopo i 50 anni (Poewe et al., 2017).
Per la diagnosi l’osservazione delle alterazioni motorie è fondamentale, tuttavia, quando esse si manifestano significa che sono già state perse il 50-70% delle cellule dopaminergiche; arrivati a tal punto, diventa difficile trattare il morbo. Attualmente, la procedura clinica più efficace per gestire tale condizione è quella di adottare terapie neuroprotettive, tuttavia, per farlo c’è la necessità di una diagnosi precoce (Beauchamp et al., 2020).
I ricercatori del Florey Insitute, lanciano un monito alla comunità scientifica rimembrando le conseguenze neurologiche che seguirono la pandemia di influenza spagnola nel 1918; infatti, a causa di essa, il rischio di sviluppare il Parkinson negli anni seguenti aumentò di tre volte nella popolazione. Per questo motivo, gli scienziati stanno cercando di comprendere quali potrebbero essere le conseguenze neurologiche del COVID-19, cosi da poter adottare terapie neuroprotettive e diminuire l’incidenza delle malattie neurodegenerative conseguenti alla pandemia mondiale da SARS-CoV-2 (Beauchamp et al., 2020).