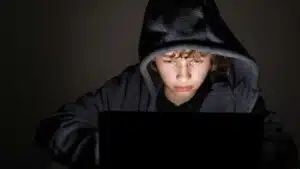La forma di hate speech online legato alle caratteristiche fenotipiche degli individui (es. caratteristiche del viso, colore della pelle) o all’affiliazione ad un gruppo etnico, culturale e territoriale acquisisce i contorni di quello che viene definito cyber-razzismo (Back, 2002).
Un tema attuale e particolarmente controverso è sicuramente quello dell’hate speech (tradotto generalmente in italiano in incitamento all’odio) che, nonostante sia largamente utilizzato, è un termine che non ha oggi una definizione univoca. Dal punto di vista normativo, il riferimento con maggiore autorevolezza è presentato nell’appendice alla raccomandazione n. (97) 20 del 30 ottobre 1997 realizzato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. In questo documento viene definito hate speech quel fenomeno che ricopre
tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basato sull’intolleranza, tra cui: intolleranza espressa da nazionalismo aggressivo ed etnocentrismo, discriminazione e ostilità nei confronti di minoranze, migranti e persone di origine immigrata (Committee of Ministers – Council of Europe, 1997, pag. 107).
Una sempre maggiore preoccupazione della diffusione del fenomeno, anche attraverso la promulgazione via internet, ha attirato l’attenzione della politica, dei professionisti e degli studiosi. In Italia il 30 ottobre 2019 è stata approvata una mozione, con prima firmataria la senatrice Liliana Segre, per istituire una commissione straordinaria per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, che pervadono la scena pubblica accompagnandosi sia con atti e manifestazioni di esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità (Segre et al., 2019, pag. 120). Sempre nel 2019 è uscita la quarta edizione della mappa dell’Intolleranza realizzata dall’Osservatorio Italiano sui diritti Vox (2019) che ha identificato la presenza sui social network di un crescente livello di intolleranza raziale nei confronti di migranti, musulmani ed ebrei. L’analisi condotta da Vox – Osservatorio Italiano sui diritti, tra marzo e maggio 2019, ha evidenziato rispetto al 2018 un netto aumento di tweet con oggetto l’odio verso i migranti (15% in più rispetto al 2018), verso gli ebrei (6% in più rispetto il 2018), e verso i mussulmani (7% in più rispetto il 2018).
Questa forma di hate speech online legato alle caratteristiche fenotipiche degli individui (es. caratteristiche del viso, colore della pelle) o all’affiliazione ad un gruppo etnico, culturale e territoriale acquisisce i contorni di quello che viene definito cyber-razzismo (Back, 2002). Il cyber-razzismo si configura, infatti, come una forma di razzismo a tutti gli effetti caratterizzato da contenuti online offensivi, denigratori e discriminatori su base razziale (Bliuc, Faulkner, Jakubowicz, & McGarty, 2018; Keum, & Miller, 2018). Un gruppo di ricercatori australiani (Bliuc, et al., 2018) ha condotto una revisione sistematica delle ricerche scientifiche sul cyber-razzismo per identificarne le fonti, i canali e le strategie di comunicazione, gli obiettivi, e le potenziali conseguenze. I risultati principali di questa rassegna hanno messo in evidenza che gli episodi di cyber-razzismo messi in atto da singoli individui non avvengono esclusivamente sui social network, ma anche nei commenti dei siti internet, nei gruppi di chat e nei video di youtube. Un aspetto sicuramente peculiare fa riferimento ad episodi di cyber-razzismo di gruppo che si esplicitano in siti-web e forum ‘tematici’ a sfondo razziale (il più famoso è Stormfront; Bowman-Grieve, 2009), con l’intento di reclutare nuovi elementi nel gruppo, promuovere lo sviluppo di un senso identitario, propagandare attraverso internet il pensiero razzista e le ideologie estremiste. Riguardo le strategie di comunicazione, la rassegna di Bliuc, et al. (2018) ha evidenziato che gli individui che pubblicano materiale razzista online tendono ad: esasperare o inventare la presenza di privilegi esclusivi del gruppo vittimizzato a scapito del proprio gruppo di appartenenza (es. ‘clandestini ospitati in alberghi di lusso, italiani nelle tende’; Genoviva, 2016); etichettare diversamente, banalizzare e negare gli episodi di razzismo (‘gli insulti ai calciatori di colore sono semplice folklore’; Mastrodonato, 2019); usare battute, barzellette e canzoncine a sfondo razziale per cercare di normalizzare il razzismo (‘senti che puzza, scappano anche i cani…’; Naletto, 2009); denigrare il gruppo vittimizzato accusando e diffamando in modo stereotipato gli appartenenti al gruppo (‘Gli ebrei sono falsari storici, attaccati al denaro ed usurai’; CDEC, 2019); creare panico sociale, generando reazioni esagerate nei confronti di un gruppo vittimizzato per renderlo agli occhi della società una minaccia all’ordine morale (‘i musulmani sostengono il terrorismo internazionale’; CDEC, 2017).
Indipendentemente dalle modalità con cui il razzismo in rete viene espresso, esso ha comunque delle conseguenze sia sugli individui sia su gruppi di persone. Il cyber-razzismo, infatti, crea nelle vittime esiti simili al razzismo offline, come alti livelli di ansia e depressione, stress e percezione di ingiustizia e discriminazione (Bliuc, et al., 2018; Keum & Miller, 2018). Un altro aspetto da tenere in considerazione è che la frequente esposizione online a contenuti razzisti e di incitamento all’odio possono contribuire ad una desensibilizzazione emotiva portando a legittimare maggiormente l’aggressione verbale (Soral, Bilewicz, & Winiewski, 2018). Con la diminuzione delle reazioni emotive negative al linguaggio offensivo e discriminatorio c’è un maggiore rischio che le persone credano al contenuto diffamatorio e diventino maggiormente accondiscendenti a trattare quelle affermazioni come linee guida (per esempio nel caso di politiche anti-migratorie; Soral et al., 2018).
In linea generale, come sottolineato da Keum e Miller (2018), è importante tenere a mente che considerare quello che avviene su internet come meno importante o meno reale sia estremamente pericoloso. Sottovalutare forme di razzismo esclusivamente perché avvengono in una realtà virtuale può avere delle profonde ripercussioni nella realtà fisica, ed è anzi evidente che l’anonimato online possa promuovere il proliferare dell’hate speech, portando le persone a ricorrere ad espressioni ed opinioni razziste in modo più esplicito rispetto a quanto si farebbe in interazioni offline (Keum, & Miller, 2018). Per questi motivi sembra chiara la necessità di mettere in atto programmi di intervento preventivi ed educativi che educhino ad un uso consapevole di internet, rendendo gli utenti maggiormente coscienti di quello che condividono e facilitare la comprensione del materiale presente in rete.