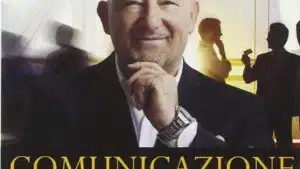Negli ultimi anni, in seguito alla Rivoluzione Tecnologica e alla flessibilità che ha coinvolto il mondo del lavoro, si assiste all’introduzione in azienda di sistemi innovativi per l’aumento della creatività dei dipendenti, per la risoluzione dei problemi e per lavorare informal-mente.
Questi mezzi, infatti, diventano dei potenti facilitatori in azienda poiché si tratta di tecniche trasversali, ovvero applicabili a qualsiasi contesto e situazione, ma soprattutto sono metodologie in grado di far emergere tutte le dinamiche “soft”, quindi non facilmente visibili di un’organizzazione. L’elemento rivoluzionario è che il tutto avviene “giocando”, come nel caso della Lego Serious Play (LSP).
Dal costruttivismo ai LEGO, un modo per imparare
Nello specifico, i partecipanti lavorano attraverso scenari immaginari utilizzando i mattoncini LEGO, per questo motivo questo tipo di attività viene definita “gioco serio” (Serious Game). Il concetto di “gioco serio” è il risultato della combinazione di teorie derivanti dal costruttivismo, secondo cui
l’apprendimento si realizza particolarmente bene quando le persone sono impegnate nella costruzione di un prodotto, qualcosa di esterno a se stessi, come un castello di sabbia, una macchina, un programma per computer, un libro (Piaget, 1951)
o, appunto, un gioco. Il gioco, in questa prospettiva, diventa un’attività limitata nel tempo e nello spazio, che coinvolge un gruppo di persone, che stabiliscono regole e accordi. L’aspetto più importante di queste attività è che non si delineano a priori ruoli o giochi di potere, ma ci si sente liberi di agire usando la fantasia e l’immaginazione, al fine di: descrivere, creare e sfidare.
Lego Serious Play: una metodologia per l’intervento nelle aziende
In particolare, l’innovativa metodologia della Lego Serious Play, nasce a metà degli anni Novanta, quando la LEGO®, famosa azienda danese produttrice di giocattoli, subì una flessione delle vendite. Al fine risolvere il problema, venne ipotizzato che bisognasse introdurre cambiamenti nella produzione. Chiamati dalla Lego come consulenti, Johan Roos e Bart Victor (1999), due professori universitari svizzeri, idearono il concetto e il metodo del gioco serio, al fine di modificare il contesto di introduzione dei famosi mattoncini, favorendo il passaggio da un ambito ludico, ovvero il gioco dei bambini, ad un contesto più serio, ovvero il mondo del lavoro. Ma l’obiettivo era anche quello di consentire ai lavoratori di approcciarsi e svilupparsi in maniera diversa alle loro mansioni.
La metodologia LSP consta di alcune fasi non rigide e modificabili a seconda dell’obiettivo, ma generalmente in un primo momento si avvia la formulazione o specificazione della “domanda”, ovvero la definizione del motivo per cui è stato richiesto un intervento di questo tipo. Questa prima fase aiuta sia il committente, ma anche i partecipanti al gioco a comprendere l’utilità e la finalità dello stesso intervento. Avendo reso esplicita e specifica la domanda, che quindi viene co-costruita, si giunge al cuore dell’azione della LSP, in cui ogni partecipante si impegna nella costruzione del suo modello 3D con i Lego, a seguito di input forniti dal facilitatore LSP. I modelli 3D sono, poi, utilizzati come punti di partenza per la discussione in gruppo, la condivisione della conoscenza, il problem solving, il decision making, il team building. La LSP stimola competenze visive, uditive e cinestesiche, richiedendo ai partecipanti di apprendere e ascoltare, dando “voce” a tutti e, quindi, per il suo carattere universale e democratico, è una metodologia che si adatta a ogni cultura e formazione.
Lego Serious Play: giocare per imparare
In Italia, la metodologia LSP ha iniziato a diffondersi dagli anni 2000 in poi, facendosi spazio in diversi contesti organizzativi e coinvolgendo, come facilitatori, diverse figure professionali, tra cui psicologi e pedagogisti con adeguato brevetto e formazione, in quanto, seppur basata sul “gioco”, la tecnica restituisce potenti risultati, poiché si può
comprendere di più di una persona in un’ora di gioco di quanto si non possa fare in un’intera vita di conversazione (Platone).