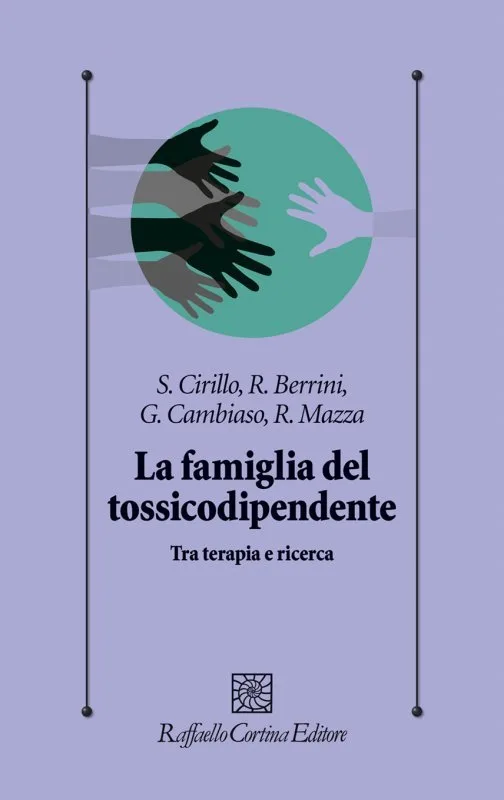La famiglia del tossicodipendente: Gli autori considerano il sintomo del giovane tossicomane da eroina in un’ottica trigenerazionale, che mira ad esplorare non solo le componenti insoddisfacenti della relazione coniugale e le sue dirette risultanze nella relazione con i figli, ma anche le problematiche relative al rapporto di ciascuno dei genitori con la propria famiglia d’origine nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza.
La famiglia del tossicodipendente: le relazioni di attaccamento tra genitori e figli e i meccanismi di difesa
La prima edizione di questo volume rappresentava uno dei primi manuali completi sulla tossicodipendenza, esaminata nell’intreccio dei diversi fattori che contribuiscono alla sua insorgenza. Il testo presentava una ricerca/intervento che rintracciava alcuni scenari familiari, su tre generazioni, utili nel trattamento degli uomini tossicodipendenti da eroina. L’aggiornamento del volume vent’anni dopo la prima edizione, attraverso numerosi casi clinici che tentano di chiarire le elaborazioni teoriche riconducibili all’orientamento psicodinamico e sistemico-relazionale, ha consentito di approfondire alcune teorizzazioni e procedure sorte in seno alla terapia familiare, alla teoria dell’attaccamento e all’infant research, accogliendo nella propria esperienza clinica nuovi studi, come quelli di Liotti o Lorna Smith Benjamin per esempio.
I cambiamenti che hanno coinvolto i consumatori di droghe, relativi alla qualità delle sostanze usate e alla loro diffusione capillare, hanno generato un intreccio di problemi non più circoscritti ai servizi per le tossicodipendenze, ma allargati ai consultori per adolescenti, ai servizi sociali, alle scuole e naturalmente agli ambulatori privati, ai quali le famiglie portano richieste di consultazione, a causa di figli tossicodipendenti di ogni età. Il testo attuale si propone anche di allargare l’attenzione ai percorsi familiari delle donne dipendenti dall’eroina, nonché di sottolineare la necessità di non perdere di vista i rischi che corrono i figli dei tossicodipendenti. L’attenzione con cui il libro è stato accolto venti anni fa è stata indirizzata su molteplici aspetti, ma forse quello che ha colpito di più è stata l’efficacia del richiamare sulla scena il padre del giovane tossicodipendente, tradizionalmente periferico nella famiglia e lasciato spesso in disparte anche dai terapeuti.
Gli autori considerano il sintomo del giovane tossicomane da eroina in un’ottica trigenerazionale, che mira ad esplorare non solo le componenti insoddisfacenti della relazione coniugale e le sue dirette risultanze nella relazione con i figli, ma anche le problematiche relative al rapporto di ciascuno dei genitori con la propria famiglia d’origine nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza.
I ricercatori nell’analisi del problema della tossicodipendenza, evidenziano: “il meccanismo tipico di tale percorso, attraverso il quale si pongono le basi della scelta tossicomanica, è quello secondo cui entrambe le generazioni, quella dei genitori e quella del figlio tossicodipendente, risultano caratterizzate da un disturbo nella relazione d’attaccamento alle rispettive figure genitoriali (in una sorta di circolo autoperpetuantesi, così come descritto da Fromm-Reichmann,Bowlby, Main, Holmes e molti altri), le cui conseguenze tuttavia vengono poi negate per mezzo di vari meccanismi difensivi, tra i quali occupano un posto centrale l’idealizzazione e la scissione a livello individuale e la minimizzazione a livello familiare.
Gli stadio dello sviluppo della tossicodipendenza e la famiglia del tossicodipendente
Gli autori descrivono minuziosamente gli stadi di sviluppo eziopatogenetico della tossicodipendenza, suddividendolo in 7 stadi:
1° stadio Le famiglie di origine
2° stadio La coppia genitoriale
3° stadio Il rapporto madre-figlio nell’infanzia
4° stadio L’adolescenza
5° stadio Il passaggio al padre
6° stadio L’incontro con le sostanze stupefacenti
7° stadio Le strategie organizzate sul sintomo
In base alla ricerca svolta dagli studiosi circa la famiglia del tossicodipendente, sono stati individuati anche tre sottogruppi di famiglie che presentavano i seguenti aspetti:
-nel primo sottogruppo, che rappresenta la maggioranza delle famiglie, apparentemente c’è un accudimento ineccepibile sul piano formale, mentre è inadeguato su quello sostanziale. Sono presenti esperienze traumatiche non sufficientemente elaborate;
-nel secondo sottogruppo, invece, i genitori risentono delle esperienze deludenti avute con la loro famiglia di origine, ed è presente una strumentalizzazione dei figli da parte dei genitori;
-il terzo sottogruppo riguarda, principalmente, la famiglia del tossicodipendente multiproblematica.
I ricercatori, considerati gli stadi sopra descritti, hanno cercato di mettere in evidenza la possibile esistenza di tre percorsi verso la tossicomania:
-1 percorso : l’abbandono dissimulato;
-2 percorso: l’abbandono misconosciuto;
-3 percorso : l’abbandono agito.
Secondo gli autori, analizzando le differenze tra i tre diversi percorsi eziopatogenetici, “emerge con chiarezza come la caratteristica che meglio qualifica la tossicodipendenza, isolata come comportamento sintomatico a sé stante, sia la componente di abbandono affettivo, in vario grado oggettivabile, sperimentata dal soggetto all’interno del percorso relazionale familiare.”
Relazione tra tossicodipendenza e disturbi di personalità
Interessanti gli approfondimenti sulla comorbidità tra tossicodipendenza e disturbi di personalità riportati nel testo, per sottolineare che l’operatore, quando si trova di fronte a manifestazioni tossicomaniche concomitanti a disturbi psicotici, o a comportamenti antisociali all’interno di un tessuto di marginalità sociale, ha meno problemi a farsi una ragione della presenza della droga. Le tossicodipendenze che risultano invece ascrivibili al percorso 1 (la stragrande maggioranza quindi), invece, suscitano maggiori perplessità, dal momento che i soggetti che presentano il sintomo appaiono spesso affetti unicamente da problemi di droga all’interno di contesti familiari e sociali del tutto “normali”, e non infrequentemente sono addirittura inseriti in ambiti lavorativi o approdati a relazioni affettive extrafamiliari sufficientemente stabili.
Tuttavia ad un’indagine più approfondita, traspare la difficoltà, da parte di questi soggetti, a superare forti conflitti interni relativi all’ambivalenza degli affetti (strutture nevrotiche di personalità) o ad affrontare un processo di integrazione di affetti scissi e contrapposti (strutture di personalità borderline). Tali pazienti, secondo gli autori, tendono a utilizzare la droga con lo scopo autoterapeutico di proteggersi dalla sofferenza che inevitabilmente insorgerebbe nel momento in cui dovessero affrontare la conflittualità nevrotica o integrare le componenti affettive scisse e inconciliabili.