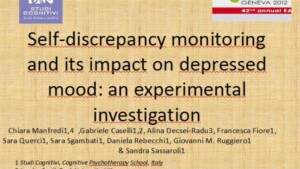Le critiche degli altri ci servono per migliorare? In che misura? E le nostre? Qual è la ricaduta di queste critiche sul nostro umore e sulla nostra autostima? Possono aumentare la tendenza all’autocritica? Poi, i genitori come si collocano in queste dinamiche? Genitori critici possono mettere i figli sotto pressione, ma genitori troppo laissez-faire possono crescere figli poco disciplinati?
Ovviamente (purtroppo) non esiste una domanda univoca a tutte queste domande. Però qualcosa è stato esplorato.
L’autocritica e le sue componenti
La tendenza all’ autocritica è quella propensione che in qualche misura fa parte di tutti noi e che ci porta a “fare le pulci” per esempio alle nostre prestazioni lavorative, al nostro modo di fare, o alla nostra persona nel complesso. Questa tendenza è stata suddivisa in due componenti: il confronto delle nostre caratteristiche con quelle altrui (componente comparativa) e il confronto di noi stessi con l’idea che abbiamo di come dovremmo essere (componente internalizzata) (Thompson & Zuroff, 2004). La propensione ad autocriticarsi è stata correlata a diverse difficoltà a livello psicologico, e ovviamente all’umore depresso: anche a livello intuitivo, possiamo immaginare che una persona che tende più di altre a ripetersi tutto quello che di se stessa non va bene, facilmente sarà più triste di una persona che focalizza la sua attenzione su altro.
Due costrutti che possono in parte essere assimilati all’ autocritica (ma che si configurano in realtà come sostanzialmente differenti) sono la ruminazione e il perfezionismo. La prima differisce dall’ autocritica perché è una modalità di utilizzare il proprio pensiero in modo ciclico e ricorrente, che porta la persona a rimanere focalizzata su qualcosa di negativo (che potrebbe essere un’autocritica, ma anche altro). Il perfezionismo, invece, potrebbe essere il fine ultimo che porta alla tendenza a criticarsi, ma i due costrutti non sono per forza appaiati.
Lo studio sui costrutti della tendenza all’autocritica
Un recente studio (Manfredi et al., 2016) si è proposto di analizzare come questi costrutti fossero in relazione e contribuissero ad aumentare la probabilità di sviluppare sintomi depressivi. In sostanza, ci siamo chiesti quale di queste componenti avesse una diversa influenza sull’umore delle persone, interpellando nello specifico soggetti senza diagnosi e che non avevano richiesto un aiuto psicologico. I dati sono stati raccolti su 194 persone (di cui 139 femmine) attraverso l’utilizzo di questionari carta e matita.
Cosa ci hanno detto le analisi dei dati? Due cose.
La prima: la probabilità di avere un abbassamento di umore dipende, tra tutte le variabili citate nello studio, soprattutto dalla tendenza delle persone ad essere autocritiche. Questa propensione sembra essere il costrutto che sa meglio predire la probabilità di essere depressi.
La seconda: le caratteristiche che più influenzano la tendenza a essere critici nei propri confronti sono 2, la tendenza a ruminare e il perfezionismo. Queste due propensioni sono più importanti della tendenza dei genitori a essere critici nei confronti dei figli. In sostanza, le sole critiche genitoriali non sono sufficienti per “creare” un adulto autocritico: per questo, serve anche che l’adulto sviluppi la tendenza a pensare in modo ciclico e ripetitivo sulle cose passate e una spiccata preoccupazione per la possibilità di sbagliare.
Quello che ne deriva è che il primo punto da scardinare per migliorare il tono dell’umore è questa propensione alla critica verso se stessi, che a sua volta è più probabile in persone che temono di sbagliare e che tendono a rimanere molto a pensare alle cose che non hanno funzionato.
Abstract
Internalized self-criticism (ISC) has been identified as one dimension of depression and has been related to poor interpersonal functioning, the severity of depressive symptoms among patients with a diagnosis of Major Depressive Disorder and suicidal behaviors; finally, it has been indicated as a maintaining factor in depression, able to impair the efficacy of psychological treatment.
The present study aimed to investigate the role of perceived parental criticism, perfectionistic concern over mistakes and ruminative brooding in predicting internalized self-criticism; in addition, we explored the predictive value all the considered variables for depressive mood in a non-clinical population.
The final model showed a complete mediation for concern over mistakes and ruminative brooding in the relationship between perceived parental criticism and ISC, with the final model explaining 32% of the variance. Moreover, ISC predicted the level of depressive symptoms over and above the contribution of the other variables considered.
The findings suggest that a thinking style characterized by ruminative brooding and the tendency to be concerned with mistakes can facilitate the development of a self-critical person, more than a parental style perceived as critical. Moreover, the tendency to be self-critical may be more predictive of depressive symptoms than the other variables considered.