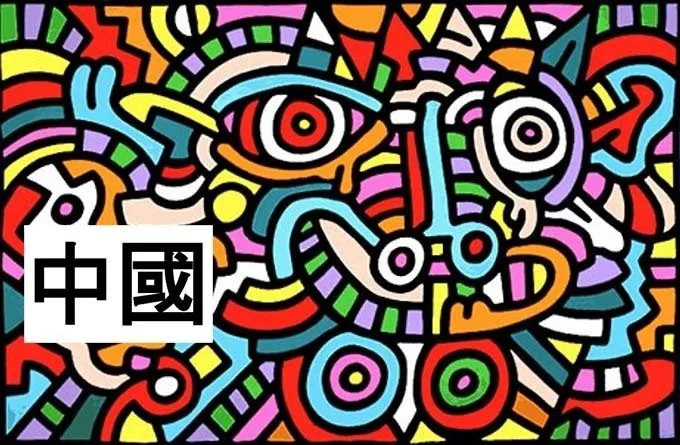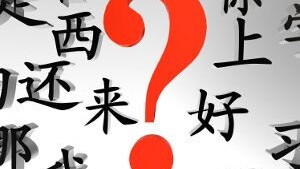The Chinese Mind: cronache psicologiche dalla Cina
Expat nella terra di mezzo, cronache sull’orlo di una crisi di nervi
The Chinese Mind vuole essere una raccolta di riflessioni, storie e ricerche riportatevi da una psicologa wài-guó rén, la straniera, alle prese con la cultura e la gente cinese nella Shanghai contemporanea. Shanghai è un luogo elettrizzante, contradditorio nella sua essenza, costantemente in mutamento, ti lascia con una certezza: tutto, troppo umano per rimanervi indifferente.
Nell’era multiculturale, si spendono sensatissime parole su altrettanto documentati manuali di psicologia riguardo l’appropriazione di quell’insieme di credenze, valori, atteggiamenti, emozioni, reti di significati e di pratiche che caratterizzano una specifica cultura.
Si parla di appropriazione e non di acquisizione perché la complessità di una cultura non si impara studiando sui libri, nè facendo vacanze all’estero, ma si fonda direttamente sull’esperienza, intesa come “l’enciclopedia di conoscenze esplicite e tacite, acquisite mediante il coinvolgimento personale nelle azioni e nelle interazioni con gli altri, accumulate nel corso del tempo” (Anolli, 2011).
Tutto vero, salvo poi renderti conto che la maggior parte degli aneddoti rientrano sotto la nebulosa categoria del “That’s china” – espressione utilizzata dallo straniero smarrito che non ci sta capendo più nulla. Allora le emozioni prevalgono, le teorie dei manuali rimangono in penombra e la sfida che stai vivendo si irradia in tutta la sua complessità.
Buona lettura!
La contraddizione e l’autostima in Cina
In gran parte dei paesi asiatici la realtà non viene concepita come univoca, con confini precisi e coerenti, ma anche semplici e banali domande, ad esempio, “in quale giorno inizierà l’anno scolastico?” lasciano spesso lo straniero, in questo caso la sottoscritta, stupito e accigliato per non ottenere quella che nella prospettiva occidentale è una risposta sicura.
Rimane sempre qualcosa in sospeso, qualcosa in forse, una sorta di Inshallah per cui – e i cognitivisti direbbero che è proprio così – nulla nella vita, neanche negli aspetti più banali e pratici pare essere certo.
Possiamo rilassarci se cerchiamo di comprenderne le ragioni: le credenze e le rappresentazioni cognitive dei paesi dell’Estremo Oriente sono saldamente radicate nel taoismo che implica un presupposto tanto semplice quanto ingerente:
La realtà – o meglio la rappresentazione della realtà – non è univoca ma è contradditoria per natura (definito come “principio di contraddizione”).
Dunque entrambi gli aspetti di una contraddizione (“ciò che è A” e “ciò che è NON-A”) non si autoescludono ma possono convivere in armonia e possono mutare: di fronte a una incoerenza si tende al compromesso in modo che in qualche modo entrambi i lati della medaglia, entrambe le “verità” possano essere conservate (Peng & Nisbett, 1999).
Lo shock occidentale di fronte alle apparenti contraddizioni deriva dal fatto che la nostra conoscenza ha radici nella logica aristotelica in cui il principio di non contraddizione vale eccome: se una cosa è vera non può essere falsa!
Effettivamente sembrerebbe che anche l’autostima, in quanto insieme di credenze su sé stessi non sia esente dal fenomeno.
Prendiamo ad esempio i cinesi: Spencer-Rodgers et al. (2004) hanno riscontrato che i cinesi hanno un autostima significativamente più bassa e profili diversi rispetto agli americani (misurata attraverso il famoso e occidentale questionario Rosenberg Self- Esteem Scale). Infatti accade che i cinesi, per natura più tolleranti alla contraddizione e con un bisogno di coerenza meno stringente rispetto agli americani, si autodescrivono sostenendo sia item positivi che negativi, delineando un profilo di sé appunto molto articolato e includente sia aspetti positivi che negativi. Molto più polarizzate sarebbero invece le autorappresentazioni dei soggetti americani: o sei positivo o sei negativo.
Una maggiore incoerenza e ambivalenza nelle credenze su di sé non sarebbe però un problema per gli orientali. Ad esempio Campbell e colleghi (1996) hanno riscontrato che il grado di coerenza interna e stabilità delle credenze sul sé erano meno correlate all’autostima per i giapponesi che per i canadesi; e la discrepanza tra sé ideale e sé reale era legata alla depressione in misura minore che per il campione occidentale (Heine & Lehman, 1999).
Un limite di questi studi però risiede negli strumenti self-report che sono misure “esplicite” dell’autostima e nella desiderabilità sociale dei soggetti, che negli orientali può tradursi nell’assunzione di un atteggiamento di modestia con una preferenza per risposte moderate e non estreme mentre valutano sé stessi di fronte ad altri (Chen, Lee, & Stevenson, 1995).
Senza contare il fatto che gli strumenti self-report utilizzati in moltissimi studi sono etnocentrici (studiati e messi a punto da individui di cultura non cinese), e -per citare la piu semplice falla – alcuni items possono essere male interpretati.