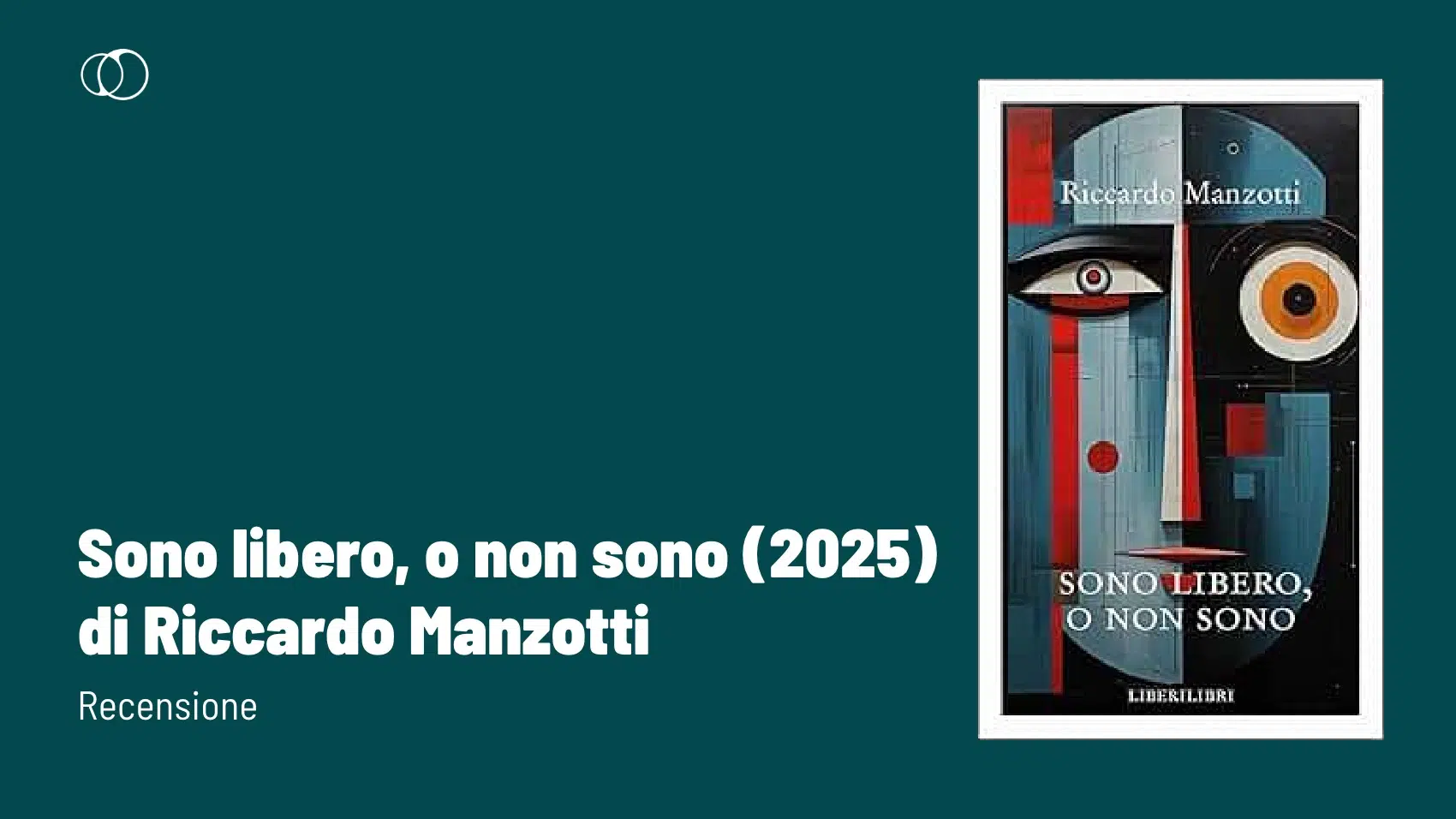O sei libero o non sei: perché la psicologia deve tornare a interrogarsi sull’uomo?
Viviamo in un’epoca in cui si è fatto di tutto per rendere la vita umana più efficiente e più sicura. Eppure, mai come oggi, l’essere umano si sente confuso, disorientato, alienato. Il libro di Riccardo Manzotti, Sono libero, o non sono (Liberilibri), interviene in questa complessità con una proposta radicale ma incredibilmente semplice: senza scelta non c’è esistenza. Non si tratta di rivendicare un astratto e obsoleto libero arbitrio, ma di riconoscere nella scelta l’atto originario che ci costituisce come persone.
Contro la tendenza contemporanea a ridurre la vita a una serie di decisioni procedurali, Riccardo Manzotti ci ricorda in modo potente che la scelta non è una decisione: è l’origine dei criteri stessi. E quando si rinuncia alla scelta, si rinuncia alla vita come possibilità, come espressione di libertà.
È indubbio che la complessità sia una delle caratteristiche fondamentali del nostro tempo. Tecnologie emergenti, reti globali, sistemi decisionali sempre più opachi rendono difficile comprendere dove finisca il nostro potere d’azione e dove cominci quello degli altri, o quello delle macchine. In questo scenario, che assume toni quasi distopici, l’individuo appare impotente, sopraffatto da meccanismi più grandi di lui.
A tutto ciò si aggiunge il linguaggio tecnico della scienza e della burocrazia, che ha come conseguenza logica una forma di deresponsabilizzazione. Il risultato? Un’umanità che non sa più cosa significhi scegliere, e che confonde il vivere con il funzionare. La scelta viene assimilata erroneamente a un algoritmo (massima espressione della decisione); la vita a un protocollo.
Ma questa “confusione” non è solo una sensazione soggettiva: è un effetto sistemico. In assenza di riferimenti antropologici forti, la persona smette di essere tale, riducendosi a un nodo funzionale, a un esecutore di processi esterni. È qui che lo scientismo, nel senso criticato dall’autore, gioca un ruolo cruciale. Lungi dall’essere scienza in senso autentico, lo scientismo è la mitologizzazione della scienza come unica forma legittima di sapere, e della tecnica come unica soluzione possibile. Karl Jaspers (1931) osservava che “la scienza sa, ma non sa il senso del suo sapere”. Lo scientismo, invece, è la scienza che finge di sapere il senso del proprio sapere — per omissione o per presunzione. E in questo modo, deresponsabilizza: toglie all’individuo la possibilità di scegliere. Se un algoritmo stabilisce cosa è meglio, perché mai dovrei chiedermi cosa ha senso? Agisco come sono stato programmato a fare: punto.
Purtroppo, la psicologia non è estranea a questa deriva: ha partecipato attivamente a questa riduzione. Basti pensare al comportamentismo metodologico di Watson (1913) che, pur essendo stato fondamentale per l’inserimento della psicologia nelle scienze naturali, ha escluso la coscienza dal proprio oggetto di studio, rinunciando così a descrivere la persona in quanto soggetto agente e relegando la scelta a una mera illusione.
È in questo vuoto che l’ipotesi dell’identità mente oggetto (Mind-Object Identity; MOI) di Manzotti propone un’alternativa radicale: non una mente interna o nascosta, ma una mente che coincide con il mondo colto attraverso l’azione. La scelta libera non è un epifenomeno né un mistero: è l’emergere, nel mondo, di un punto di vista incarnato.
L’essere umano come scelta: verso un’antropologia della libertà
La crisi del soggetto – negato, ignorato, svuotato – rende urgente una nuova antropologia. Non si può fondare etica, politica, educazione o psicoterapia senza sapere cosa sia l’essere umano. Il libro di Manzotti propone un’antropologia e una psicologia della libertà: l’uomo è colui che sceglie.
La psicologia contemporanea, in particolare, deve tornare a interrogarsi sulla natura della persona. Troppo spesso ha adottato acriticamente paradigmi neuroscientifici o comportamentisti che escludono la dimensione esistenziale. Ma una psicologia senza una filosofia dell’uomo diventa inevitabilmente terapia dell’adattamento, non pratica di liberazione.
Nel cuore del libro c’è un’affermazione semplice e potente: la scelta è ciò che ci fa esistere. Non si tratta di selezionare un’opzione tra tante, ma di creare lo spazio stesso delle opzioni. La scelta autentica è un atto creativo, che dà forma al mondo. Non nasce dal calcolo, ma da ciò a cui decidiamo di dare valore.
La libertà è la possibilità di fare una differenza nel mondo. Non perché siamo “interiormente liberi”, ma perché possiamo agire nel mondo in modo tale da cambiarlo, anche solo un po’. L’azione è sempre retroattiva: rende vero ciò che prima era solo possibile. Questo principio è in linea con il principio di selezione per conseguenze di B.F. Skinner (1981), ma lo arricchisce di una dimensione ontologica. Questa visione si oppone frontalmente alla logica delle “decisioni” guidate da KPI (Key Performance Indicator), algoritmi o parametri standardizzati. La scelta, al contrario, è sempre un atto esistenziale, rischioso, imprevedibile.
In ultima analisi, questo libro è una riflessione sul valore. I valori non sono dati, né oggettivi né soggettivi: sono reali perché scegliamo di spenderci per essi. La vita ha valore solo nella misura in cui la spendiamo in modo libero e consapevole.
Vivere scegliendo: filosofia, libertà e responsabilità nell’era della psicologia cieca
“Sono libero o non sono” è un libro che può essere letto a diversi livelli: come saggio filosofico, come atto politico, come provocazione culturale, persino come stimolo personale. Ma è soprattutto un libro che non lascia indifferenti. Anche se può essere apprezzato da lettori non specialisti, dovrebbe essere letto da ogni psicologo proprio perché troppi psicologi hanno abdicato a posizioni filosofiche fondamentali. Già nel 1913, Karl Jaspers metteva in guardia contro l’illusione di poter escludere la filosofia dalla psichiatria: anche quando non se ne è consapevoli, una visione filosofica finisce per agire nel pensiero scientifico, spesso in modo implicito e confuso. Senza una riflessione chiara sull’uomo, anche il linguaggio della scienza rischia di diventare opaco e disumanizzante. E per la psicologia questo è ancora più vero: senza filosofia, psicologia e psicoterapia diventano cieche alla libertà, cieche alla scelta, cieche al valore.
“La vita è incertezza. Ogni volta che saliamo su un’automobile, camminiamo per la strada, iniziamo una relazione sentimentale, apriamo un’impresa, corriamo rischi terribili. Non fare nulla sarebbe ancora peggio, perché allora avremmo la certezza di sprecare la nostra vita.” (p. 72).
La risposta a questa incertezza non è semplicemente tollerarla, ma trovare per cosa valga la pena tollerarla. Questo libro, allora, è un invito urgente: a tornare a pensare la persona come essere capace di scegliere, e a riconoscere che non si è mai veramente vivi finché non si accetta la responsabilità di scegliere per cosa valga la pena vivere.