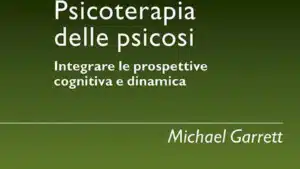Attraverso il manuale “Psicoterapia delle psicosi”, edito da Raffaello Cortina (2021), Michael Garrett propone una visione delle psicosi e delle metodologie di intervento non solo pienamente rinnovate, ma al contempo lontane da quelle descrizioni che facevano di questi disturbi delle semplici etichette, alle quali attenersi categoricamente e in maniera unidirezionale.
Il libro
L’autore, pagina per pagina, offre un’ampia panoramica del significato che le psicosi assumono all’interno sia del singolo individuo sia del contesto entro il quale egli vive questa condizione.
L’integrazione della dimensione cognitiva e di quella dinamica fanno di questo libro un manuale attraverso il quale l’operatore della salute mentale può trovare non solo dei nuovi spunti di riflessione, ma anche nuove metodologie con le quali rapportarsi all’idea stessa di psicosi.
A differenza dei precedenti manuali sul tema, le parole dell’autore desiderano restituire dignità al paziente e ai suoi familiari, che assieme a lui si trovano ad affrontare quotidianamente una condizione di difficoltà e sofferenza che non sempre viene ascoltata ed esplorata e che andrebbe sostenuta.
Oltrepassare le etichette diagnostiche
Un aspetto oltremodo interessante sembra provenire dal contributo di James Hillman (2019), rispetto ai concetti di “nominalismo e categorizzazione del sintomo”. Il noto psicoanalista infatti definiva ambo i termini quali fattori limitanti la cura della persona nella sua totalità. Nondimeno, fermarsi o, peggio ancora, focalizzarsi esclusivamente sul sintomo rischierebbe di innescare quella cecità da parte dell’operatore della salute mentale, che altro non comporterebbe se non l’impossibilità di percepire la simbologia di cui il sintomo stesso è portavoce. In quest’ottica, il linguaggio assume la fisionomia di quel canale in grado di dar voce a quello che spesso il corpo non riesce ad esprimere, e che nelle psicosi spesso risulta ancor più enigmatico, ma non per questo privo di quella logica invisibile e lontana nel tempo che il terapeuta non dovrebbe stancarsi mai di tenere in considerazione.
Se da un lato la dimensione cognitiva offre la possibilità di esplorare pensieri, percezioni e stili di coping, al contempo quella dinamica consente di ricollegarsi a quella dimensione temporale che, per quanto lontana, non cessa mai di riflettersi sul setting terapeutico. Le tecniche presentate non possono non accompagnarsi a quella consapevolezza attraverso la quale ciascun operatore della salute mentale, come ricordato da Eugenio Borgna, deve tener conto della sensibilità e della fragilità di chi abbiamo davanti (Borgna, 2018). E che dietro alla sua fragilità altro non chiede se non di rinascere.