Michela Adele Pozzi.
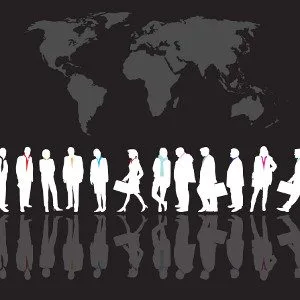
Rampini presenta dei dati che ci consentono di accostare l’imponenza del fenomeno migratorio nel mondo:
«In totale, in questo istante un miliardo di abitanti del pianeta vivono l’esperienza dell’emigrazione: un essere umano su sette […] Un terzo dell’umanità si sente psicologicamente sul piede di partenza, disponibile o costretto, attirato o rassegnato a doversi rifare una vita “altrove”».
Trascurando (non certo per importanza) di considerare gli innumerevoli casi di migrazioni dovute alle difficili condizioni di vita nel Paese di origine, vorrei qui soffermarmi sul fatto che moltissime persone scelgono spontaneamente di trasferirsi all’estero, in modo più o meno definitivo, al fine di trovare migliori opportunità di studio o lavoro. Questo fenomeno ci costringe ad una rappresentazione del migrante molto diversa dall’immagine dei numerosi profughi disperati che raggiungono le nostre coste via mare.

Innanzitutto, dobbiamo pensare ad una persona mossa da desideri di autorealizzazione, carriera, acculturazione, che sceglie per questi di lasciare il proprio Paese, la propria città, la propria famiglia, spesso sapendo che vi tornerà solo per brevi vacanze: tale immagine risulta oggi vincente a livello sociale, in quanto mobilità, flessibilità ed adattabilità costituiscono valori forti nella nostra cultura.
Tornando all’articolo, Rampini ci pone una domanda cruciale: «Ma è proprio vero che il XXI secolo ci ha reso tutti cittadini del mondo, cosmopoliti e flessibili?». Attraverso l’esperienza di Susan Matt, studiosa americana delle migrazioni, l’Autore ci porta a considerare i notevoli (ma spesso taciuti) effetti psicologici di questa scelta di vita: spaesamento, depressione, sindromi da stress di acculturazione, in una definizione «Sindrome nostalgica».
Mentre un tempo tale condizione era clinicamente riconosciuta, oggi parlare di nostalgia pare anacronistico, anzi, è un vero e proprio tabù: d’altronde, quando è possibile mettersi in contatto con chiunque all’istante, contraendo in modo vertiginoso lo spazio e il tempo della distanza, ha ancora senso l’esistenza di questo termine? Forse non nei dizionari cui accediamo tramite gli smartphone, ma certamente si nel nostro alfabeto emotivo.
Con le parole della Matt, «Sembra quasi che le emozioni e i danni affettivi dell’emigrazione siano un ostacolo imbarazzante sulla strada del progresso e della prosperità individuale. L’idea che sia facile e che ci si debba sentire a casa propria in ogni angolo del pianeta deriva da una visione dell’umanità che celebra l’individuo solitario, mobile, facilmente separabile dalla sua famiglia, dalle sue radici, dal suo passato».
Già, sentirsi a casa propria: possiamo domandarci se, dopo “nostalgia”, “casa” sia un altro termine che si sta cercando di eliminare dal dizionario?
A questo riguardo, l’articolo di Romagnoli offre una suggestione interessante: «Metti di aver cambiato 8 città in 4 continenti. Ventisei appartamenti aperti e chiusi (trauma da trasloco? Basta sopravvivere la prima volta). Poi qualcuno ti chiede: non hai nostalgia di casa? Cerchi la risposta, ma quel che non trovi è “casa”». Come farà l’Autore nel corso dell’articolo, ognuno di noi può proporre una propria definizione, provando ad immaginarne le possibili variazioni in base a diverse circostanze:

Cos’è per noi “casa” se siamo adolescenti o una giovane coppia in procinto di sposarsi, cosa quando non vediamo l’ora di partire per le vacanze o quando siamo sfiniti dopo una giornata di lavoro, cosa quando scegliamo di trasferirci all’estero per poter praticare il nostro lavoro o quando atterriamo in mezzo a persone che non parlano la nostra lingua? La differenza, qui, la fanno le emozioni, non certo la presenza di quattro mura, un pavimento e un tetto. I sentimenti che si muovono dentro di noi quando ci confrontiamo con il concetto di casa attengono a qualcosa di profondo, riguardante le nostre origini.
Non a caso, per lo psichiatra e psicoanalista svizzero Carl Gustav Jung, nel sogno la casa rappresenta «una specie di immagine della psiche» (C.G. Jung, 1961), in cui la discesa ai piani inferiori e sotterranei si accompagna alla scoperta di strati più remoti appartenenti all’inconscio personale e collettivo: «La coscienza era rappresentata dal salotto: aveva un’atmosfera di luogo abitato, nonostante lo stile di altri tempi. Col pianterreno cominciava l’inconscio vero e proprio. Quanto più scendevo in basso, tanto più diveniva estraneo e oscuro. Nella caverna avevo scoperto i resti di una primitiva civiltà, cioè il mondo dell’uomo primitivo in me stesso, un mondo che solo a stento può essere raggiunto o illuminato dalla coscienza».

La casa, «il luogo tra i luoghi» (B. Massimilla, 2009), concentra su di sé un carattere archetipico, oltre che un significato personale: anche se possiamo trasferirci ed adattarci a vivere praticamente ovunque, quella nostalgia che cerchiamo affannosamente di negare mediante il ricorso ai più svariati mezzi di comunicazione costituisce un richiamo primitivo a quello spazio intimo fatto di persone, oggetti, ricordi, emozioni.
Essa è dunque testimone della presenza di un legame indissolubile, che può risultare scomodo rispetto ai nuovi valori che nel giro di poche generazioni si sono affermati: ma questo lasso di tempo storico è infinitamente piccolo rispetto ad un tempo interiore, che ci lega al mondo animale e ai nostri antenati primitivi che, dopo la scoperta del fuoco, presero a riunirsi intorno a un focolare.
BIBLIOGRAFIA:
- Rampini, F. (2012, 28 marzo). Il mal di casa dei nuovi migranti. La Repubblica, 32-33.
- Romagnoli, G. (2012, 28 marzo). I luoghi della memoria. Lo struggente viaggio tra le città del mondo. La Repubblica, 33.
- Matt. S. (2012). The New Globalist Is Homesick. The New York Times. March 21, 2012
- Jung, C.G. (1961). Ricordi, sogni, riflessioni. Raccolti ed editi da Aniela Jaffè. Milano: Bur. (2006).
- Massimilla, B. (2009). L’anima nei luoghi della vita e del cinema. Rivista di Psicologia Analitica, Nuova serie Volume 80/2009 n. 28, 9-28.

