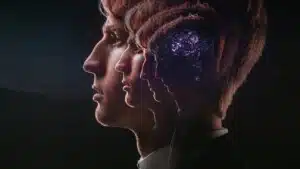Sembra che al diminuire dell’HRV (Heart Rate Variability) sia associato un peggioramento nei risultati dei compiti cognitivi in cui è coinvolta l’area prefrontale. Può essere quindi considerato l’HRV come un parametro predittore della performance cognitiva?
Tutti conoscono il gioco degli scacchi. Non forse tutti però sanno che questo gioco è utilizzato per lo studio di alcuni processi cognitivi (come memoria e problem solving) (Amidzic et al., 2006; Troubat et al., 2009). Nel corso degli anni si è accertato in particolare di come la corteccia prefrontale, legata alla pianificazione delle decisioni, sia importante in questo gioco (Koechlin & Hyafil, 2007).
La corteccia prefrontale è associata con la funzione vagale (regolatrice del sistema nervoso autonomo), che può essere misurata attraverso l’Heart Rate Variability (HRV) – la variazione dell’intervallo tra due battiti (Thayer et al., 2012).
Nel sistema nervoso autonomo troviamo un bilancio dinamico tra il sistema simpatico e quello parasimpatico (Shaffer et al., 2014): l’attività parasimpatica, che porta a un incremento dell’HRV, è attiva durante il riposo e le situazioni legate al rilassamento. L’attività simpatica è associata a situazioni stressanti e porta a una riduzione dell’HRV.
L’HRV è considerata una misura dell’interazione cuore-cervello (Shaffer et al., 2014) e si modifica nei compiti cognitivi e attenzionali, oltre che nella risposta ansiogena alle situazioni (Porges & Raskin, 1969): quando l’attività cognitiva si fa più intensa, c’è un aumento dell’attività simpatica (con relativo diminuzione dell’indice HRV) (Mukherjee et al., 2011; Luque-Casado et al., 2013). Si è inoltre visto che, al diminuire dell’HRV, è associato un peggioramento nei risultati dei compiti cognitivi in cui è coinvolta l’area prefrontale. Questi risultati potrebbero indicare l’HRV come un parametro predittore della performance cognitiva (Muthukrishnan et al., 2017).
In uno studio recente (Fuentes-García et al., 2019) si è voluto verificare se la performance negli scacchi fosse associata a delle differenze nell’HRV, nella percezione soggettiva di difficoltà, stress e complessità.
Le ipotesi iniziali erano che:
- l’indice HRV sarebbe stato ridotto e gli indici di difficoltà, stress e complessità soggettivi sarebbero aumentati al crescere della difficoltà degli esercizi;
- i giocatori più abili avrebbero riportato valori più alti di HRV e percepito meno difficoltà, stress e complessità durante gli esercizi rispetto ai giocatori meno abili.
Per questo studio sono stati reclutati 16 giocatori di scacchi – tutti maschi, età media 35 anni e punteggio ELO medio superiore a 1900. A questi giocatori sono stati sottoposti sei esercizi scacchistici di livello crescente (due facili, due medi, due difficili), avendo mezzo minuto per risolverne ognuno. I giocatori sono stati divisi in due gruppi di performance (alta e bassa) in base ai risultati ottenuti. L’indice HRV è stato preso alla baseline e durante gli esercizi; dopo ogni livello di difficoltà sono stati registrati gli indici di difficoltà, stress e complessità soggettivi con una Visual Analogue Scale (VAS).
I risultati hanno mostrato come – in entrambi i gruppi – ci fosse un decremento dell’indice HRV all’aumentare della difficoltà degli esercizi. Inoltre, durante gli esercizi l’HRV era significativamente più alto nel gruppo ad alta performance rispetto a quello a bassa performance. Il gruppo a bassa performance ha infine percepito i problemi scacchistici in maniera più complessa rispetto a quello ad alta performance.
In linea con le ipotesi iniziali e con la letteratura in materia, questi risultati hanno evidenziato che in effetti è presente una modulazione del sistema nervoso autonomo (la diminuzione dell’HRV) all’aumentare dello sforzo cognitivo anche nel gioco degli scacchi e che questa modulazione sembrerebbe essere associata con la performance dei giocatori. Ciò potrebbe aprire una nuova finestra che veda nell’HRV un interessante e utile strumento nell’allenamento dei giocatori, riuscendo a stimarne gli sforzi cognitivi e le capacità.