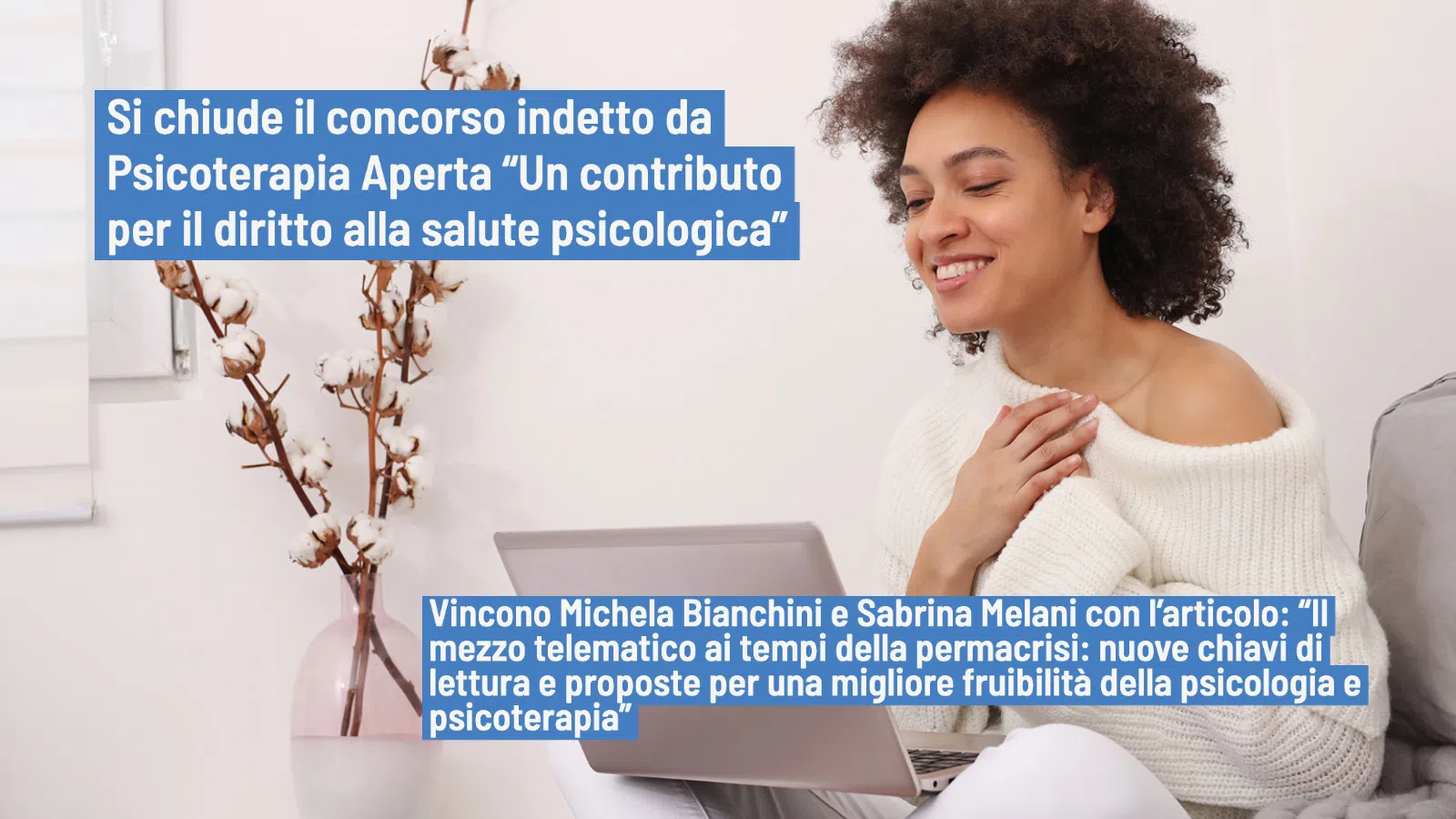Trasformazioni digitali e psicoterapia disincarnata
Questo articolo è pubblicato come contributo vincitore dell’edizione 2025 del concorso Un contributo per il diritto alla Salute Psicologica, promosso da Psicologia Aperta.
A cura di Martina Mancuso e Giovanna Di Giacomo
Negli ultimi anni, l’irrompere delle tecnologie digitali ha profondamente trasformato la pratica psicologica, ridefinendone confini, modalità e significati. La crescente diffusione di piattaforme online, app per la salute mentale e servizi di telepsicologia ha introdotto nuove possibilità di accesso, rendendo l’incontro terapeutico svincolato da coordinate fisiche e temporali (Stoll, Müller & Trachsel, 2020).
La tecnologia, in questo senso, si configura come una leva potenzialmente emancipativa: favorisce l’accessibilità, rompe l’isolamento, consente continuità di cura anche in contesti di marginalità e riduce lo stigma sociale promuovendo una cultura più aperta sul benessere psicologico. L’esperienza della pandemia da Covid-19 ha ulteriormente accelerato questo processo, confermando che è possibile instaurare una relazione terapeutica significativa anche in spazi virtuali (Kocsis & Yellowlees, 2018).
Tuttavia, come ogni trasformazione culturale, anche questa non è priva di ambivalenze. Se da un lato amplia le opportunità, dall’altro rischia di ridurre il supporto psicologico a un servizio standardizzato, individualizzato e privatizzato, eroso dalla logica del mercato. Il rapporto tra psicoterapia e comunità – che storicamente ha rappresentato una dimensione fondamentale della disciplina – appare oggi sempre più sfumato, quando non completamente assente. In questa prospettiva, la cura psicoterapeutica viene assimilata a un bene di consumo, regolato da dinamiche di domanda e offerta.
La psicoterapia è chiamata a confrontarsi con la tentazione – talvolta rischiosa, perché acritica e automatica – di aderire ai valori dell’efficienza, della prestazione e della rapidità. La diffusione di formule come “sedute brevi” o “pacchetti benessere” riflette una trasformazione profonda dell’immaginario della cura. Si afferma una psicoterapia disincarnata, on-demand, che si adatta ai bisogni immediati del mercato, piuttosto che interrogare le condizioni strutturali del disagio.
La cultura terapeutica contemporanea, nel suo intreccio con l’economia del capitalismo avanzato, rischia di rafforzare l’idea che il benessere sia una responsabilità puramente individuale, da ottenere attraverso un investimento personale, consumabile e misurabile (Illouz, 2007). In questo quadro, la psicoterapia si presenta sempre più come una prestazione da ottimizzare, una “soluzione” rapida a problemi soggettivi, un dispositivo di adattamento (Prilleltensky, 1994).
Dunque questa deriva – che apparentemente democratizza la cura rendendola più accessibile – produce un paradosso. Da un lato amplia l’offerta, rendendola più capillare e flessibile; dall’altro svuota di significato la dimensione etica della psicoterapia. Etica, nel senso etimologico del termine: ethos (ἦθος) è un termine greco il cui significato, in origine, era “il posto da vivere”, uno spazio in cui si abita, si vive, si costruisce senso.
Rendere la psicoterapia più accessibile è un bene, ma se questo avviene snaturando la relazione terapeutica (riducendola a servizio usa-e-getta), allora si perde ciò che la rende veramente trasformativa: la sua etica, intesa come luogo esistenziale e relazionale dove si cresce insieme.
Dove alberga la psicoterapia oggi? Dove poggia il suo sguardo?
La psicoterapia è chiamata oggi a interrogarsi sul proprio posizionamento.
Uno sguardo etico: epistemologia della complessità
Per rispondere alla sfida di una psicoterapia che rischia di appiattirsi su logiche adattive e individualistiche, è necessario tornare a interrogare le fondamenta epistemologiche su cui si costruisce l’incontro clinico. L’epistemologia della complessità offre un quadro teorico fertile per ripensare il ruolo dello psicoterapeuta oggi, restituendo profondità, pluralità e responsabilità all’agire clinico.
Morin ci ricorda che complexus significa ciò che è tessuto insieme (1993): abbracciare la complessità implica riconoscere che ogni forma di conoscenza, anche quella psicologica, è intrinsecamente situata. Non si tratta più, quindi, di spiegare la sofferenza ricorrendo a una causa unica esterna, ma di ascoltarne le molteplici stratificazioni, i livelli e la posizione soggettiva di chi la interroga.
Da questa prospettiva, la psicoterapia non è più un processo di “aggiustamento” all’adattamento normativo, ma un luogo di esplorazione del senso, del desiderio, del possibile. L’Io non è una struttura statica, ma un processo dinamico, ricorsivo, attraversato da conflitti, contraddizioni, trasformazioni. È un Io che si fa Soggetto (Minolli; 2009, 2015).
Inoltre, come suggerisce Stengers (1985), ogni costruzione teorica nasce dentro un contesto di pensiero: ciò vale anche per le categorie psicologiche che usiamo. L’etica dell’analista non si fonda sull’adesione a protocolli rigidi o sulla pretesa neutralità, ma su una posizione riflessiva e responsabile, capace di riconoscere la complessità delle situazioni e l’irriducibilità del soggetto.
La psicoterapia può tornare a essere un luogo di resistenza alle semplificazioni tecnicistiche e ai dettami del benessere performativo, e recuperare il proprio potenziale trasformativo: non solo sul piano individuale, ma anche su quello sociale e culturale.
La smaterializzazione del setting tradizionale dovuta alle piattaforme online può quindi essere riletta con le lenti della complessità: si fa spazio l’occasione di fare un passo indietro e ritornare a riflettere sul setting, non come un elemento rigido o esclusivamente tecnico, ma come una cornice viva e porosa, che può accogliere e favorire certi processi. Il setting non è ciò che definisce, da solo, l’evento terapeutico, ma è ciò che lo rende possibile. È l’ambiente – fisico, simbolico, relazionale – che può sostenere un certo tipo di incontro. Pensare il setting in modo critico e creativo significa interrogarsi su quali condizioni siano oggi necessarie per abitare l’incontro terapeutico, senza dogmi e quindi senza rinunciare alla complessità. Significa poter immaginare luoghi altri, spazi nuovi – anche fuori dalle stanze convenzionali – in cui la psicoterapia possa continuare a essere un gesto umano e generativo.
Il setting: da contenitore simbolico a spazio vivo
Il setting ha avuto, nella storia della psicoanalisi, una funzione fondamentale: dare forma e tempo all’incontro, proteggere il silenzio, ascoltare senza urgenza. Il setting ha permesso di abitare la cura in un modo diverso, offrendo un contenimento tanto per il paziente quanto per il terapeuta (Migone, 1992). In Freud (1926) tecnica e teoria erano strettamente intrecciate: ogni mutamento nel metodo di lavoro implicava un ripensamento della teoria, e viceversa. Il setting era allora lo sfondo vivo dell’incontro, non un insieme di regole astratte, ma una forma che si plasmava sull’esperienza.
In molti contesti istituzionali e formativi si è trasformato in una serie di norme da applicare, un rituale da rispettare più che un campo da abitare. Il setting è diventato così criterio di appartenenza professionale, garanzia di ortodossia, e non più strumento clinico dinamico (Galli, 1984). In questo irrigidimento, la singolarità del paziente è stata talvolta sacrificata all’uniformità della teoria; la soggettività del terapeuta è stata nascosta dietro l’illusione di una neutralità oggettiva; il dialogo con la complessità della realtà, messo tra parentesi.
Eppure, proprio oggi, in un tempo in cui le forme di relazione si fanno fluide e intermittenti, il setting potrebbe tornare a essere essenziale. Non come gabbia, ma come spazio di domanda. Non come struttura identitaria, ma come luogo che consente la presenza — per il paziente e per il terapeuta. Un setting che non chiude, che tiene, ma non irrigidisce. Che non anestetizza il dubbio del terapeuta, ma anzi lo custodisce, lo permette.
Psicologo al Parco: un setting incarnato, un gesto politico
Se il setting non è solo un rituale, ma uno spazio vivo capace di favorire la presenza e l’incontro, allora è legittimo — e anzi necessario — domandarsi come possa trasformarsi per rispondere alle domande del tempo. La proposta di Psicologo al Parco nasce da qui: da una riflessione sulle trasformazioni della domanda di cura e dal desiderio di tornare a una psicologia incarnata, accessibile, umana che sposta il luogo della cura, e con esso la sguardo di chi cura e di chi viene curato.
L’incontro tra terapeuta e paziente avviene all’aperto, fuori dalle mura dello studio, nei parchi, nelle piazze, nelle cascine urbane. Uno spazio naturale, non controllato, che riconosce complessità all’incontro. Non si tratta solo di una cornice diversa, ma di una ridefinizione radicale del setting, inteso non più come recinto protetto, ma come ambiente permeabile, abitato, partecipato.
Questa proposta non nasce per negare il valore della stanza d’analisi, ma per ampliare le possibilità della cura, esplorando nuovi territori — fisici e simbolici — in cui la psicoterapia possa tornare a essere prossimità, presenza, alleanza. Ogni innovazione, naturalmente, porta con sé interrogativi importanti, che vanno affrontati con rigore:
- Qual è la validità terapeutica di un incontro che avviene all’aperto?
- Come incidono i fattori ambientali — suoni, odori, clima, passanti — sul processo psicologico?
- È un approccio adatto a tutti, o solo ad alcune condizioni cliniche e soggettive?
- Come si tutela la privacy?
Lungi dall’eludere queste domande, il progetto lo Psicologo al Parco nasce proprio per tenerle vive, nella convinzione che il lavoro clinico non sia mai garantito dalla tecnica in sé, ma dalla qualità della presenza, dall’etica della relazione e dalla capacità di stare nel dubbio.
Germogli Urbani: semi di comunità
All’interno di questa visione si inserisce il progetto Germogli Urbani, nato in collaborazione con il Vivaio Clinico Istituto SIPRe Milano nel 2025 con l’obiettivo di offrire sportelli di consultazione all’aperto, a tariffe calmierate, in spazi verdi e accessibili di Milano, come Redo Merezzate e Cascina Cuccagna. Il progetto è patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
L’intento è duplice: da una parte, offrire un supporto psicologico individuale, su prenotazione, in un ambiente informale e accogliente; dall’altra, ridefinire il rapporto tra psicologia e territorio, tra professionisti e cittadini. Non si tratta solo di fare colloqui in un parco: si tratta di restituire alla cura il suo valore pubblico, il suo potenziale trasformativo, la sua capacità di sfidare lo stigma.
Psicologo al Parco è, in questo senso, un gesto clinico e politico, che rifiuta le scorciatoie della semplificazione e si muove nella complessità del reale. È un invito a ripensare il setting non come difesa, ma come opportunità. Non come rifugio, ma come possibilità incarnata di cura.
Per una psicoterapia radicalmente umana
La sfida oggi non è solo quella di trattare il disagio individuale, ma di ripensare i contesti in cui esso prende forma. Una psicoterapia che si limiti ad adattare i soggetti a una realtà disfunzionale rischia di essere complice di quel disagio. Serve una psicoterapia che sia anche critica sociale, promotrice di diritti, agente trasformativo.
Ma attenzione..
“Una cultura psicologica priva di pregiudizi”, questo è il motto di Psicologo al Parco: in realtà, sappiamo bene che la conoscenza tutta è un coacervo di pregiudizi di cui è impossibile liberarsi. L’obiettivo non è scoprire un punto altissimo e irraggiungibile in cui la mente è bianca, pura e finalmente aperta a riempirsi di chiunque: il punto è cosa farne di questi pregiudizi, abitarli, interrogarli o combatterli. Insomma, esporre il fianco.
Psicologo al Parco è lo psicologo che è uscito fuori. Non sta dalla parte dell’individuo, non sta dalla parte della società. Perchè? Perché Edgar Morin ci insegna che l’individuo è nella società che è nell’individuo. Per metodo, la psicoterapia cura l’individuo che soffre e chiede aiuto.
Nell’incontro con il singolo, al Parco, lo Psicologo al Parco incontra l’individuo che è la società… e la società, che è nell’individuo.
In un’epoca di crescente digitalizzazione e isolamento, il gesto di sedersi su una panchina a parlare con uno psicoterapeuta diventa profondamente controcorrente. Un atto semplice, ma rivoluzionario.
Considerazioni finali: abitare il mondo con la psicoterapia
La proposta di Psicologo al Parco invita la comunità terapeutica a interrogarsi su cosa costituisca davvero il cuore del processo analitico:
È il rispetto formale delle regole tecniche, o la qualità della relazione tra soggetti?
È la protezione dall’imprevedibilità del reale, o la capacità di stare nella realtà senza arretrare?
Accogliere il cambiamento non significa rinunciare alla solidità teorica, ma esercitare discernimento: distinguere ciò che è essenziale da ciò che è storicamente contingente. Il parco, come nuovo spazio terapeutico, diventa allora metafora di una psicoterapia che non teme di esporsi al mondo, che sa abitarlo, attraversarlo, trasformarlo — senza perdere, ma anzi approfondendo, la propria intensità e profondità.
Questa è forse la direzione di una psicoterapia del futuro: non solo dentro gli studi, ma anche nei contesti, tra le persone, con la comunità. Una psicoterapia che non resta spettatrice, ma partecipa.
Una psicoterapia che non si addormenta sull’interpretazione dei sogni ma è pronta a dirsi cosciente: una psicoterapia che oggi è pronta ad aprire gli occhi, guardare il mondo, abitarlo e restituirgli uno sguardo di senso.