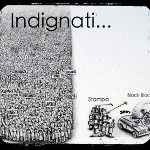Marzo 2002: il Boston Globe rilascia un video documentario sugli abusi ai minori insabbiati dalla chiesa cattolica, il video diventa virale in poche ore grazie a Youtube e alle altre piattaforme di condivisione online, l’opinione pubblica si accende come un fiammifero e si innesca una catena di processi giudiziari (dapprima in Boston, dove 24 preti vengono processati, poi si allarga a macchia d’olio).
Spagna 2004: il Primo Ministro Aznar addossa maldestramente la responsabilità degli attentati di Madrid ai separatisti baschi, mentendo deliberatamente alla nazione. Venuta a galla la menzogna, gli spagnoli indignati si coordinano con gli sms e scendono in piazza compatti e agguerriti: Aznar è costretto a dimettersi.
2009 Moldavia: una protesta contro le elezioni presidenziali truccate, coordinata attraverso sms, Twitter e Facebook, innesca una reazione a catena che porta elezioni legislative anticipate e alla sconfitta del partito comunista, al governo dal 2001.
A lato di questi casi esemplari del potere politico dei social media, ci sono anche storie meno fortunate, in cui forme di coordinazione dal basso non hanno avuto esiti così felici o indolori, come il Green Movement in Iran nel 2009, le manifestazioni contro Lukashenko in Bielorussia nel 2006 o la rivolta delle Camice Rosse in Thailandia nel 2010: in cui i movimenti di protesta, organizzati anche grazie ai social media, sono stati più o meno sanguinosamente soppressi dai governi di turno. Poi si arriva al 2011 e alla “primavera araba” e nella scossa tellurica del cambiamento diventa improvvisamente evidente il ruolo centrale di blogger e social networks.
E ora la giusta domanda: gli strumenti digitali aiutano la democrazia? Il più autorevole tra i pessimisti è stato Malcolm Gladwell, che dalle colonne del New Yorker ha dato una risposta (stranamente) superficiale, facendo di tutta l’erba un fascio e identificando le azioni politiche sui social media con il fenomeno definito “slacktivism”, che ben si descrive con il classico e pigro “like” alla causa del giorno su Facebook, sia essa salvare i delfini o salvare il Darfur. Utenti casuali si associano con un click in proteste virtuali dall’animo grande e nessun risultato. Ok questo è corretto, ma c’è ben altro. Il fatto che da facebook dei navigatori annoiati non possano cambiare il mondo è vero e condivisibile ma è altrettanto vero che grazie a facebook e twitter e gli altri social media (e il web 2.0 in generale) si può coordinare un movimento, unire le forze, fare per l’appunto, rete.
Le parole ci vengono in aiuto: medium = tramite, strumento. Uno strumento relativamente economico, a distribuzione capillare, che abbatte la gerarchia tradizionale della comunicazione: tra un’emittente e molti riceventi. Il web e i social media ristabiliscono una simmetria a lungo persa con i mezzi di comunicazione di massa: rendendo ogni utente un emittente-ricevente, connesso. Le distanze si annullano, i tempi di risposta e organizzazione delle persone si riducono al passaparola di un tweet e mai come oggi le profezie visionarie di McLuhan si avverano davanti ai nostri occhi: viviamo veramente nel villaggio globale e il medium, tanto per cambiare, è il messaggio.
Se escludiamo dal ragionamento quindi quel che è definito slacktivism, ci rimane la potenza e la capillarità dei social media nel coordinare e mettere in comunicazione le persone. Nel suo saggio “Political Power of Social Media”, Clay Shirky cerca di rispondere alla domanda in maniera cauta e possibilista: Gli strumenti digitali aiutano la democrazia? Nel breve periodo non possono far male e nel lungo molto probabilmente si. Soprattutto dice: i social media hanno il massimo impatto come strumento politico in quei paesi dove già è stabilita una sfera pubblica di opinione informata che tiene sotto controllo l’operato dei governi. In pratica: là dove già c’è democrazia, i social media aiutano a tenerla in salute. Il passaggio più interessante del saggio di Shirky riguarda la sua critica alla politica di Hillary Clinton riguardo alla diffusione e al libero accesso a Internet nel mondo. La Clinton promuove quella che Shirky definisce “Instrumental view”: l’idea che si possa supportare lo sviluppo democratico nel mondo imponendo ai paesi non democratici di garantire il libero accesso ad internet ed alle informazioni: New York Times, Google, Youtube,Wikipedia… Contrapposta a questa visione un po’ antiquate e centralistica, c’è la “Environmental view”: che si basa sul concetto organicistico secondo il quale i cambiamenti positivi (e pro-democratici) all’interno di una società sono il risultato o conseguenza indiretta dell’esistenza di una sfera pubblica informata, non il contrario. L’assunto fondamentale è questo:
L’accesso alle informazioni, dal punto di vista politico, è molto meno importante che l’accesso alle conversazioni. Tradotto: è molto più importante per uno stato democraticamente arretrato che le persone abbiano la possibilità di dialogare, coordinarsi e confrontarsi piuttosto che possano leggere il Guardian o Wikipedia online. I blogger tunisini ed egiziani sarebbero d’accordo. Un’opinione pubblica nasce dal confronto e dal dialogo riguardo a problemi economici o di politica quotidiana, non da discorsi impalpabili riguardo a valori politici astratti.
FINE PRIMA PARTE. Domani: Il Potere Politico dei Social Media in ITALIA.
BIBLIOGRAFIA:
- Shirky C, (2011), “The Political Power of Social Media“, Foreign Affairs – Volume 90 Number 1 January/February 2011
- Gladwell M, (2010), “Small Change, Why the revolution will not be tweeted“, The New Yorker, 4-10-2010
- Gladwell M, Shirky C, (2011), “From Innovation to Revolution, Do Social Media Make Protests Possible?“, Foreign Affairs – Volume 90 Number 2 March/April 2011
- “Slacktivism“, Definizione su Wikipedia.
- McLuhan M, (1967), “Gli Strumenti del Comunicare” , Il Saggiatore, Milano