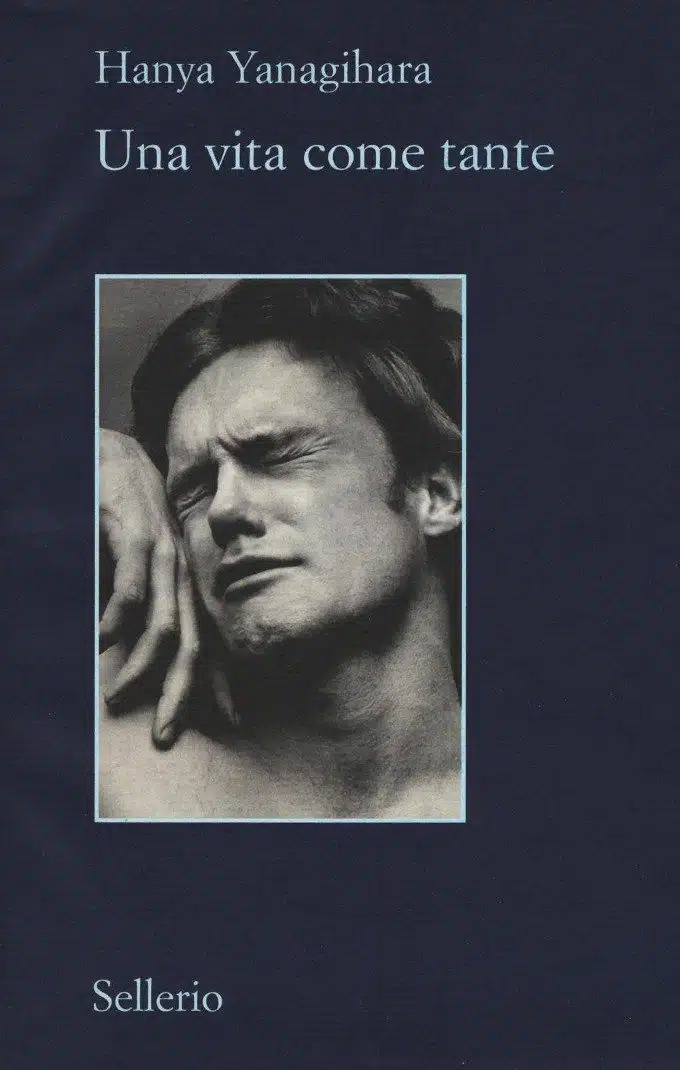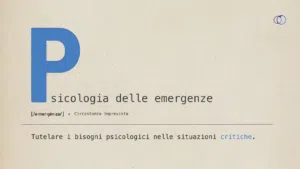Questa recensione di Una vita come tante di Hanya Yanagihara è un po’ uno spoiler. Avete il tempo di fermarvi qui e non procedere oltre, se siete convinti che in un racconto la sorpresa del colpo di scena sia irrinunciabile. Oppure potete proseguire fino alla fine o solo ancora un po’, vi sarà un secondo avvertimento a metà recensione, dove alcune svolte del romanzo saranno raccontate nei dettagli.
Su State of Mind abbiamo già recensito Una vita come tante perché ha un interesse sia psicologico oltre che letterario e sa intrecciare tra loro i due interessi. Il bello di questo romanzo è che il suo particolare gusto letterario illumina la visione contemporanea che si ha del trauma e viceversa.
Nell’altra recensione pubblicata di Una vita come tante su State of Mind si sostiene, a ragione, che questo romanzo è importante perché ci aiuta a capire quale fenomeno estremo e particolare sia il trauma. La forza del libro risiederebbe nella sua capacità di farci capire cosa significa davvero subire un trauma e correre un pericolo di vita. Non una facile e consolatoria identificazione ma l’orrore verso un’esperienza estrema e inimmaginabile.
Infatti il trauma è al centro del romanzo e colpisce ripetutamente e crudelmente il suo protagonista, Jude. Un trauma –lo ripetiamo- estremo, eccessivo, incredibile e multiplo. Lasciando da parte i meriti letterari del romanzo (che comunque non è nostra competenza valutare) la trama sconvolgente del romanzo può svolgere una funzione positiva: un lavoro che fa capire cosa sia davvero un trauma. Ovvero un evento o una serie di eventi violentissimi e distruttivi che lasciano la vittima con un profondo senso di pericolo e mancanza di protezione.
È un’operazione di cultura psicologica importante. Viviamo in un’epoca in cui la definizione di trauma si sta dilatando e diventa onnicomprensiva. In questa linea ci sono opportunità e rischi. L’opportunità di far crescere la nostra conoscenza di questa importante area clinica, studiando i rapporti tra trauma e disturbi dissociativi; ma anche il rischio di appiattire l’intero campo clinico al trauma: siamo tutti traumatizzati e abbiamo tutti bisogno di una terapia specifica del trauma.
Tuttavia, leggendo le varie recensioni di Una Vita come Tante, l’impressione è che il romanzo abbia generato reazioni contrarie. Malgrado l’estremismo delle esperienze di Jude, i recensori sembrano essersi identificati con lui. Identificati non solo in termini letterari -il che è giusto: la letteratura deve generare identificazione- ma anche personali. Le recensioni internazionali parlano del romanzo come di uno strumento fondamentale per comprendere un certo malessere moderno che riguarda tutti. Ad esempio il Guardian o il New Yorker sostengono che la grandezza del romanzo stia tutta nella possibilità di identificarsi con Jude e con le sue sofferenze. In un certo senso, tutti noi siamo come Jude e tutti noi abbiamo sofferto episodi simili ai suoi. Non uguali in termini di ripetitiva efferatezza ma simili in termini di intensità della sofferenza emotiva. Siamo tutti gettati in una realtà violenta ed estranea che ci malmena e ci sopraffà, traumaticamente. E questo romanzo ce lo farebbe capire.
È possibile che sia così. L’umanità è sofferente e noi tutti ci consideriamo dei maltrattati meritevoli di consolazione e riconoscimento –sempre insufficiente- e ricordiamo le sconfitte piuttosto che le gratificazioni. E questo romanzo ci conferma questa visione che abbiamo di noi stessi. E di noi stesse.
Tuttavia vi è un caso in cui Una Vita come Tante ha generato una reazione diversa. La recensione di Daniel Mendelsohn sulla New York Review of Books fa riflettere. Fa riflettere prima di tutto sulla struttura del romanzo, molto ben costruita secondo le regole del thriller. Forse fin troppo ben costruita, per un romanzo che intende essere così coinvolgente in termini di identificazione personale e non di suspense tra il giallo, il nero e l’horror (e qui iniziano gli spoiler, ultimo avvertimento).
Il primo “trucco” narrativo usato dalla Yanagihara per incatenarci alle sue pagine è centellinare per tutto il romanzo la rivelazione di cosa esattamente sia capitato a Jude. È geniale come l’autrice nelle prime duecento pagine ci inganni facendoci credere che si tratti di un intenso ma non inquietante romanzo di formazione giovanile, quattro amici che fanno carriera a New York e hanno successo dopo i difficili inizi –il bellissimo Willem, futuro attore che sbarca il lunario facendo il cameriere, JB nero haitiano, sovrappeso, gay e futuro grande artista d’avanguardia che fatica a piazzare le prime opere, il futuro avvocato (Jude stesso) e il futuro architetto -Malcolm, mezzosangue bianco e nero di ottima famiglia- che fanno un frustrante tirocinio in grandi studi. Piccioncini che devono spiccare il volo, che hanno qualche esperienza difficile alle spalle al tempo stesso commovente ma non traumatica: i genitori freddi e distanzianti di Willem (di etnia scandinava; le etnie contano in questo romanzo) o la madre e le zie impiccione e invischianti di JB, viziatissimo fin dall’infanzia. Negli Stati Uniti questo tipo di romanzo è stato reso popolare da Mary McCarthy nel 1963 col suo best seller The Group: la traiettoria di vita di un gruppo di amiche dall’università in poi.
È un trucco. Dopo le prime duecento pagine il passato di Jude conquista il primo piano. Pian pano emerge che il suo passato è ben più spaventoso e terribile di quello degli altri tre, le cui sofferenze troppo normali iniziano a sbiadire. Perfino i problemi di droga di JB diventano banali. Il lettore è spiazzato, passando da un’atmosfera di romanzo di formazione all’horror. E l’autrice è abilissima nel non far capire subito non solo cosa sia capitato a Jude, ma anche a come sia ridotto nel presente. Man mano che le pagine scorrono, Jude diventa sempre più storpio e deforme ma mai in termini chiari. A volte è in carrozzella, a volte cammina ma zoppicando. Zoppica ma non si capisce quanto: è un fatto evidente o poco percettibile? L’autrice gioca a non farcelo capire. Poi apprendiamo che si lesiona, si taglia le carni profondamente quasi quotidianamente procurandosi una perversa anestesia per dimenticare qualcosa. Che cosa? Un ricordo traumatico di qualcosa che gli è capitato di terribile. Anzi di disgustoso e di cui si vergogna profondamente.
Le rivelazioni arrivano (ultimo avvertimento) con la tempistica di uno strip tease sanguinario che ci fa prigionieri costringendoci ipnoticamente a girare le pagine. Le prime rivelazioni sono scioccanti. Jude è un orfano abbandonato, cresciuto in un monastero di monaci che lo hanno violentato a turno per anni costringendolo ad atti di sesso orale. Il sesso orale è un tema ricorrente ed è alla base del disgusto di Jude. L’atmosfera gotica e psicopatica del monastero degli orrori è –a mio non professionale parere- letterariamente un’acme del romanzo.
Jude poi fugge dal monastero con un monaco, fratello Luke, l’unico che fino a quel momento l’aveva trattato bene e non aveva abusato di lui. Anzi lo aveva stimolato a studiare e gli aveva insegnato moltissime cose, avendo intuito le eccezionali qualità scolastiche di Jude e gettando le basi intellettuali della sua futura enorme capacità di preparazione giuridica. Il sollievo però è di breve durata: la fuga con il monaco, che si spoglia del suo abito religioso, diventa un pellegrinaggio per l’America profonda, quella dei motel e dei fast-food sulle route sterminate, in cui la coppia si guadagna da vivere con la prostituzione di Jude. Il monaco vende i servizi sessuali di Jude, che adesso ha all’incirca una decina di anni, in tutti i motel dello sconfinato midwest. I clienti lo usano sessualmente e lo disprezzano apertamente chiamandolo con epiteti ignobili (“troia”, “puttana”), instillando in Jude un profondissimo senso di disgusto e vergogna di se stesso e la convinzione di essere corresponsabile di quel che accade e quasi di desiderarlo. È una riproposizione catastrofica del viaggio di Lolita e Hubert, e questa è solo una delle tante allusioni letterarie della Yanagihara, la quale non si limita affatto a essere una semplice narratrice di sofferenze ma è una coltissima conoscitrice della letteratura, delle sue tecniche e delle sue allusioni.
Questa sezione on the road mi è parsa letterariamente altrettanto intensa di quella del monastero. Anzi superiore, perché il personaggio del monaco, che è anche perversamente innamorato del piccolo Jude e lo convince ad avere rapporti sessuali con lui illusoriamente consenzienti e al tempo stesso continua a farlo studiare intensamente trasmettendogli una enorme cultura, è particolarmente riuscito nel suo sentimentalismo criminale. La psicologia del monaco è talmente raccapricciante da mescolare insieme estrema empatia ed estrema manipolazione: è lui a insegnare a Jude a procurarsi dei tagli nelle carni per anestetizzarsi.
A questo punto Jude è liberato dalla polizia, che era da tempo sulle tracce del monaco lenone e pedofilo. Dopo una drammatica scena di arresto in uno dei motel (durante la quale il monaco si chiude in bagno e si impicca!) Jude è affidato ai servizi sociali. Sembrerebbe il lieto fine, ma purtroppo non è possibile: siamo appena a metà romanzo. E adesso il lettore si chiede: siamo solo a metà, cosa diamine deve ancora accadere? Cosa diamine può ancora accadere?
Accade che a Jude accade ancora di tutto. Oppure no, non di tutto: accade che a Jude accadono di nuovo le stesse cose. Gli infermieri e gli operatori del servizio sociale sono anch’essi dei perversi e iniziano anche loro a stuprare Jude. L’atmosfera stavolta è ospedaliera e a me ha ricordato quella di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Jude scappa di nuovo, questa volta da solo. Vaga per giorni tra i campi e i boschi, finisce poi nella regione degli Appalachi, la provincia dei bianchi più poveri, più campagnoli e più perversi, quelli che si svegliano un mattino con il fucile e sterminano i clienti di un fast food o di un supermercato. Jude si riduce a mendicare come un hobo nelle cittadine in un’atmosfera di horror provinciale e metafisico alla Stephen King. E alla Stephen King finisce: Jude è rapito da un serial killer e sequestratore di schiavi sessuali che lo reclude nella sua spaventosa e isolata casetta di campagna e lo sottopone a pratiche di sesso sadico. A questo punto sembra che per Jude –che ora ha 15 anni e quindi ha trascorso anni vagando da una casa degli orrori all’altra- non possa esserci altro che la liberazione della morte.
E invece misteriosamente Jude si salva. Effettivamente è un miracolo, proprio nel senso che non si non si capisce bene come avviene questa salvezza. Il suo ultimo aguzzino ha ormai deciso di farlo fuori, lo porta in campagna di notte e poi lo lascia libero di fuggire a piedi mentre lui lo insegue in auto e lo investe, ripetutamente. Gli passa proprio sopra con l’auto. Poi qualcosa è accaduto. Sarà arrivata la polizia, questo non ci viene rivelato dalla furbissima Yanagihara che ci incatena con questi trucchi alla trama. Si, ormai furbissima ma un po’ meno artista, perché questa terza parte dei vagabondaggi infernali di Jude rischia di diventare solo ammirevole tecnica del thriller e scarsa sostanza poetica e letteraria. L’orrore degli operatori sociali e poi del sequestratore e probabile serial killer (quanto ne aveva già attirati e uccisi negli anni nella sua casetta?) è spaventoso ma non è originale, è coinvolgente ma è anche letterariamente vuoto. Il serial killer è solo un mostro terrificante e non ha la complessità di fratello Luke, il monaco lenone e innamorato, colto, sentimentale e perverso. E forse proprio per questo il sequestratore non è nemmeno così terrificante come lo era invece il monaco. Insomma, a mio parere il romanzo dopo la morte del monaco forse perde colpi e si riduce a una macchina volta pagina (turning page novel, come dicono gli americani) che ipnotizza il lettore ma rischia di non dirgli nulla.
Oppure si, gli dice qualcosa, ma in termini molto diversi dall’apparenza. Forse l’autrice scopre le sue carte nell’ultima parte e dietro la traumatica emotività del libro rivela la sua natura di autrice cerebrale e iper-letteraria. E questo si rivela nell’ultima sezione della storia, quella in cui le rivelazioni finalmente finiscono e si torna al presente.
È un presente apparentemente rasserenato e tranquillo. Jude ha fatto una eccezionale carriera come avvocato –e anche i suoi amici hanno raggiunto il pieno successo: Willem è diventato una stella di Hollywood, Malcolm un’archistar e JB un grande artista- e ha fatto (quasi) pace con i suoi fantasmi che gli impedivano di avere una vita sentimentale normale. Per buona parte del romanzo, infatti, Jude investe nel lavoro e nell’amicizia, ma non ha mai una relazione. Pian piano emerge che è gay ma si astiene da qualsiasi relazione potenziale, provando vergogna e disgusto per quel che ha fatto e per le sue deformità, che rimangono sempre non ben definite: abbiamo capito che Jude è storpio e ha la pelle in vari punti coperta di cicatrici. Eppure al tempo stesso l’autrice non fa in modo che in mezzo agli altri la sua deformità venga notata, generi disagio o reazioni. Jude è un mostro ma è normale, forse come tutti noi? Questo ancora una volta suggerisce che l’autrice non ha inteso raccontare la storia di un mostro, ma ha voluto far identificare tutti noi con il protagonista.
L’ultima parte del romanzo presenta un inizio di lieto fine che è l’ennesimo inganno della Yanagihara, la quale ormai gioca col lettore come il gatto col topo: Jude supera i suoi blocchi emotivi e, dopo un’ennesima disavventura violenta (frequenta per un po’ un certo Caleb il quale lo molla naturalmente gettandolo dalle scale con la carrozzella, ma ormai Jude è un pupazzo indistruttibile) nasce l’amore con Willem, l’ex cameriere diventato una stella di Hollywood. La svolta positiva è anch’essa una furbissima sorpresa perché nulla faceva presagire la presenza di desideri gay in Willem che fino a quel momento della storia era ortodossamente eterosessuale. Willem è stato però fin dall’inizio il più vicino a Jude, un vero fratello intimissimo e gentile, e fin dagli anni universitari ha diviso l’appartamento con Jude.
Potrebbe essere il lieto fine, ma non lo è. Jude ha un ultimo nemico, un ultimo aguzzino che non riuscirà a sconfiggere. Dopo il monaco e il sequestratore sadico e serial killer tocca alla Yanagihara. Si, è lei la vera e ultima tormentatrice di Jude. L’idea non è mia, ma del recensore della New York Review of Books Daniel Mandelsohn, recensore che mi ha fatto guardare al romanzo con occhi diversi. Yanagihara colpisce Jude nella maniera più efficace e terribile facendo morire Willem in un incidente automobilistico proprio quando le porte del lieto fine si stavano per aprire. Per soprammercato nell’incidente muoiono anche Malcom l’architetto e la sua compagna, che erano in auto con Willem. Il colpo naturalmente distrugge psicologicamente Jude, al quale non resta che il suicidio dopo alcune pagine. Alcune pagine significano comunque molte decine e decine di pagine; il ritmo della Yanagihara rimane pachidermico.
È difficile valutare il significato di questa catastrofe finale. Forse il lieto fine sarebbe stato troppo banale. Dopo tanto dolore, riesce difficile credere alla possibilità di una vita felice. Fatto sta che tuttavia il colpo finale non avviene, come negli altri casi, a causa della perversità umana o di una certa tendenza autodistruttiva di Jude. Avviene per caso, il caso di una sciagura come l’incidente automobilistico. Significa qualcosa? Forse non significa niente, forse è semplicemente un finale debole a conclusione di una seconda metà del romanzo che potrebbe essere effettivamente debole, non all’altezza della prima metà.
Oppure no. Oppure il finale è forte e il suo significato sta nel fatto che il colpo finale a Jude glielo rifila la sua vera aguzzina: Hanya Yanagihara. La disgrazia finale e senza redenzione di Jude -per questo si chiama Jude: Giuda, non c’è redenzione per lui- avviene per precisa volontà della scrittrice, la quale ha voluto così esprimere il vero messaggio del romanzo, che non è il romanzo di formazione in cui Jude e i suoi amici che crescono e diventano adulti (non lo diventano) e nemmeno l’analisi psicologica del trauma insuperabile di Jude, ma è un messaggio catastrofico e metafisico: non vi è speranza, non vi è significato, non vi è un Dio (e nemmeno un dio) che garantisca un senso e dia un significato alla sequela di sciagure, disgrazie e sofferenze e tutto accade per caso, per puro caso, comprese le perversità e i traumi, senza che nessuno ne sia davvero responsabile. Questo lo dice la romanziera esplicitamente nelle prime pagine, quando scrive –presentando i quatto amici- che a New York nessuno credeva in niente e in nessuno (figuriamoci in un dio) e tutti pensavano solo a se stessi.
E soprattutto Yanagihara lo dice con la sequenza di disgrazie che fa capitare a Jude. La madre che lo abbandona, il monastero gotico dei monaci stupratori e pedofili, il road movie col monaco lenone e innamorato, gli operatori sociali uguali ai monaci (e già il sospetto doveva nascere che questo è un romanzo diverso da quel che sembra: non è un romanzo psicologico e realista ma è una distopia) e infine il sequestratore che è la versione estrema del monaco lenone. Non è finita: Caleb l’amante picchiatore e infine la Yanagihara in persona che come un dio crudele fa fuori Willem, il redentore di Jude.
A questo punto suggerisco il vero predecessore letterario di Una vita come tante. La somiglianza è fortissima, anche se l’autrice fa in modo che emerga lentamente. Il vero modello di Una vita come tante non è Oliver Twist o David Copperfield ma è Justine o le disavventure della virtù del divin marchese de Sade. Per chi non l’avesse letto (scusate lo spoiler) “Justine” è un romanzo che narra le vicissitudini di una ragazza di nobile lignaggio -appunto Justine- la quale rimasta orfana è sistematicamente stuprata, violentata e abusata sessualmente in tutte le istituzioni che avrebbero dovuto accudirla nella sua crescita. Anche Justine, come Jude, viene inizialmente accolta in un monastero e proprio li iniziano gli stupri e le orge e anche Justine, dopo una serie sempre più inverosimile di violenze successive in ognuno dei luoghi dove viene accolta, si salva un attimo prima di essere giustiziata, così come Jude si salva misteriosamente quando ormai è certo che il suo ultimo aguzzino ha deciso di ucciderlo arrotandolo sotto l’auto. Justine infatti sta per essere giustiziata per un omicidio che naturalmente non ha commesso ma viene salvata miracolosamente sul patibolo da sua sorella Juliette che, al contrario di Justine (e di Jude), ha assecondato felicemente per tutta la vita vizi e perversioni, facendo fortuna e acquisendo addirittura un titolo nobiliare e un potere tale che le consente di sottrarre la sorella alla morte. Le somiglianze non finiscono qui. Anche Justine, arrivata alla salvezza finale e accolta dalla sorella che finalmente le può dare i mezzi e la protezione per una vita serena e tranquilla, muore per uno scherzo del destino: colpita da un fulmine mentre è affacciata alla finestra!
D’accordo, in Sade tutto è presentato in maniera sarcastica e cinica. L’autore non simpatizza con Justine ma quasi la deride, sommergendola di disgrazie inquietanti. In ogni luogo in cui capita Justine si è dediti a stupri, orge e omicidi. Eppure a uno sguardo retrospettivo anche Yanagihara ha uno sguardo apparentemente partecipe e invece, man mano che le pagine scorrono, sempre più distaccato mentre a Jude succede di tutto. Le disgrazie si susseguono e l’autrice fa in modo che noi non ci rendiamo conto dell’improbabilità di una simile sequenza di disgrazie: passi il monastero (con tutta la cronaca degli scandali sessuali dei religiosi di questi anni in USA, è letterariamente verosimile) ma poi anche gli operatori sociali, il sequestratore in stile Stephen King e infine il picchiatore Caleb. E la morte di Willem nell’incidente automobilistico è come il fulmine che ammazza Justine.
Che dire? Il mio giudizio finale –per quel che vale, non sono un critico letterario- rimane sospeso. Il romanzo Una vita come tante rimane li, nella mia memoria, come un oggetto strano. In fondo non riesco a credere che sia un romanzo fallito. E però nemmeno mi sembra sia quello che dice di essere: la dolorosa storia di un uomo e della sua sofferenza. Più passa il tempo e più mi appare come una macchina letteraria consapevolmente fredda e perfettamente funzionante il cui messaggio di fondo è che tutto è privo di senso. E lo dice non con il sarcasmo esplicito del Marchese de Sade, il sarcasmo di chi ha appena perso la propria fede e non riesce ancora a esprimere la sua disperazione con calma ma vuole urlartela in faccia, quasi sperando di essere smentito. No, lo esprime con la calma di una verità acquisita.