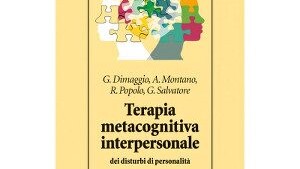Quando penso alla sintonizzazione, per come l’ho capita negli anni, penso che a noi terapeuti l’enigma della Sfinge ci fa un baffo. Per evitare di essere divorato dal paziente – o meglio, da ciò che il paziente rappresenta per lui – il terapeuta deve rispondere correttamente a tre domande che il paziente gli pone. In assenza di indizi. E per di più poste da una Sfinge che non è assolutamente consapevole di porre queste domande.
Il terapeuta e il paziente sono sullo stesso sentiero
(D. Brazier)
Il comportamento di attaccamento,
che emerge durante il primo anno di vita,
richiede tempo per svilupparsi,
mentre una conversazione intima
può verificarsi con uno sconosciuto,
che si potrebbe non rivedere mai più
(Russel Meares)
“Mi chiede insistentemente cosa deve fare. Se deve lasciare o no il fidanzato.
È un fiume in piena, mi racconta una valanga di informazioni e se cerco di intervenire ho anche la sensazione che si infastidisca. Non riesco mai a far finire la seduta in tempo.
Viene da quasi un anno in terapia e non posso fare a meno di pensare che non ci siamo mossi di un passo.
Mi manda messaggi chilometrici, ormai quasi ogni giorno, più volte al giorno, e se non rispondo mi manda un ultimo messaggio tagliente per farmi capire che è arrabbiato, e poi nella seduta successiva è faticosissimo fargli capire che non ho risposto perché proprio non potevo.
Si mette a parlare male della moglie per venti minuti di orologio, concludendo che forse non è mai stata veramente adatta a lui, perché nella vita lui si sente un leader e ha bisogno di un’altra, della donna giusta accanto. Lì non ho potuto fare a meno di mettermi nei panni di questa povera donna, ed è stato più forte di me, non me ne fregava di sbagliare: sono stato capace di dirgli, testuali parole: ‘veramente dai suoi discorsi non si evincono tanto le caratteristiche del leader; un leader vero me lo immagino come una persona capace prima di tutto di capire l’animo del prossimo, e dai suoi discorsi non si sente tanto questa tendenza”
Ai terapeuti roba del genere capita. È spesso la ragione per cui molti terapeuti portano un caso in supervisione. Sì, d’accordo, state pensando: ‘niente di nuovo, i soliti cicli interpersonali (Safran & Segal, 1993; Dimaggio & Semerari, 2007) da cui un terapeuta sufficientemente addestrato può riuscire a disingaggiarsi. Per esempio, il paziente incalza, vuole soluzioni pratiche ai suoi problemi; il terapeuta si sente impotente e inefficace perché alla scuola di specializzazione, nei week end in cui insegnavano a piegare la realtà come Doctor Strange della Marvel, aveva l’influenza; quindi eroga interventi e protocolli un po’ a casaccio, oppure si arrocca sul proprio modello (nel disperato tentativo di sentirsi meno inefficace); interventi, protocolli e modelli tendono a non funzionare (tende a capitare, se l’assetto interno di chi li dispensa è problematico); il paziente non si sente compreso e incalza ancora di più, e così via, fino a eventuali rotture o stalli.
Il fatto è che c’è un problema che viene prima dei cicli interpersonali e che molto spesso – al netto delle dinamiche patologiche del paziente – predispone alla loro occorrenza. In tutti i frammenti riportati all’inizio il problema che viene prima è che il terapeuta non è sintonizzato con il paziente, forse non è stato sintonizzato sin dall’inizio. I cicli possono essere una delle conseguenze generate della mancata sintonizzazione; ma la mancata sintonizzazione costituisce un problema, prima che per ciò che genera, per ciò che non genera: non genera le risposte adeguate a una serie di domande implicite poste dal paziente.
Quando penso alla sintonizzazione, per come l’ho capita negli anni, penso che a noi terapeuti l’enigma della Sfinge ci fa un baffo. Per evitare di essere divorato (o strangolato, secondo altre fonti), Edipo doveva rispondere a un solo quesito sulla base di tre indizi (chi è contemporaneamente bipede, tripede e quadrupede?). Per evitare di essere divorato dal paziente – o meglio, da ciò che il paziente rappresenta per lui – il terapeuta deve rispondere correttamente a tre domande che il paziente gli pone. In assenza di indizi. E per di più poste da una Sfinge che non è assolutamente consapevole di porre queste domande.
Sicurezza: la prima domanda del paziente
La prima domanda è quella di sicurezza, nel senso inteso da Stephen Porges (2014, 2018); domanda che l’autore considerava, con densità di significato secondo me sottovalutata dalla maggior parte dei clinici, un preambolo all’attaccamento: la sua soddisfazione è precondizione per l’instaurarsi di un attaccamento sicuro. Il paziente che incontra il terapeuta incontra pur sempre un estraneo. Il suo sistema di rilevazione della minaccia registrerà al di fuori della consapevolezza se l’estraneo e l’ambiente dell’incontro sono sicuri, e quanto c’è veramente da fidarsi dell’autenticità dei segnali di ingaggio sociale che l’altro sta inviando. A livelli impliciti, corporei, attraverso un processo inconscio che Porges chiama neurocezione, l’organismo del paziente letteralmente reagirà all’organismo del terapeuta. Prendiamo un terapeuta che incontra un nuovo paziente, o che incontra di nuovo un paziente con cui c’è uno stallo. Diciamo che è un terapeuta preparato, colto, intelligente, capace di mostrare un’attitudine interpersonale limata dallo studio approfondito dei processi della relazione terapeutica; ma magari è sottilmente ansioso, perché la seduta è per lui un banco di prova del proprio valore, e il demone del giudizio che di solito sonnecchia inizia a dare i primi segni di un imminente risveglio. Non se ne rende conto, ma compie atti respiratori superficiali, ha una frequenza cardiaca accelerata, e parlerà al paziente – dicendo cose intelligentissime, per carità – con una voce poco prosodica, forse con frasi brevi e smorzate. Nel complesso, questo terapeuta trasmetterà all’organismo del paziente segnali che a livelli altrettanto sottili lo agiteranno, o aumenteranno l’agitazione già presente, o comunque gli impediranno l’accesso a quello stato di sicurezza che predispone la mente a osservare sé stessa. A esplorare i contenuti psicologici.
Un terapeuta capace di sintonizzarsi è invece quello che non vive l’incontro con l’altro come uno spazio in cui ci sarà qualcosa da dimostrare a qualcuno. Che è capace di rilassarsi e vivere la seduta con curiosità e partecipazione. Che è abituato a compiere profonde espirazioni mentre dialoga, e a usare una voce prosodica e ricca di modulazioni, un’espressione mimica che risuona prontamente e senza sforzo alle espressioni e ai contenuti manifestati dal paziente. Questo terapeuta dice all’organismo del paziente qui sei al sicuro, e il tuo corpo ricorderà questa esperienza, vorrà ripeterla, quindi puoi rilassarti, e possiamo esplorare insieme il tuo mondo interno.
Essere visto: la seconda domanda del paziente
Un terapeuta sintonizzato è quello capace di rispondere correttamente anche alla seconda domanda implicita del paziente. Si tratta del bisogno che porterebbe chiunque di noi, come disse uno scrittore della mia città “a consegnarsi mani e piedi a un estraneo” pur di vederlo esaudito: essere visto, veramente. La speranza è che un altro riconosca e capisca l’unicità e il valore del flusso della propria esperienza interiore. Sappia scorgere in noi lo strato profondo, il “nucleo di esistenza personale”. James lo chiamava il Sé di tutti gli altri sé, paragonandolo a un santuario racchiuso all’interno di una cittadella (1890). Una cittadella molto spesso inespugnabile, inaccessibile al suo stesso possessore. Il terapeuta sintonizzato è quello che mantiene costantemente accesa la sonda che rileva il flusso dell’esperienza interiore del paziente. Russerl Meares (2005), rispolverando James (che tra l’altro, non ha manco tanto bisogno di essere rispolverato), parla della sintonizzazione come una connessione tra un “me” e un altro che viene avvertito come parte della mia esperienza. L’altro, il terapeuta, media la consapevolezza della costante presenza in me di una vita interiore, o come direbbe James, del flusso di coscienza in cui consiste nella sostanza il Sé. Questo flusso sta, soprattutto all’inizio della terapia, e soprattutto con i pazienti meno capaci di stabilire un contatto con quel flusso, dietro le parole e le conversazioni “convenzionali”. La conversazione “convenzionale” è fatta di segni, ossia ciò che dice il paziente rimanda ad aspetti “convenzionali” della realtà collettivamente percepita. La fidanzata o il fidanzato rompiscatole rimandano a fidanzate o fidanzati rompiscatole come convenzionalmente intesi, non diversamente da come un altro segno, le strisce di attraversamento pedonale, rimandano per tutti noi a quel segnale che fa capire che è proprio lì che è meglio attraversare la strada se si vuole ridurre il rischio di essere investiti.
Il terapeuta sintonizzato è quello che dietro la “stessa storia monotona” come la definiva Janet (1911, cit in Meares, 2005), dietro il flusso dei segni convenzionali del paziente, riesce a rintracciare momento per momento un processo interiore in atto, che deve restituire al paziente. Quello che mette il paziente in condizione di connettersi meglio possibile con la propria soggettività, con il flusso delle proprie esperienze interne. Il terapeuta non sintonizzato è invece quello che, non interessato ad azionare (o non capace di farlo) la sonda che dietro la comunicazione segnica ricerca costantemente il flusso di esperienza interna, si assesta sul registro della comunicazione convenzionale. Non azionare quella sonda determina la più desolante delle conseguenze rispetto al dialogo terapeutico: la tendenza a entrare nel merito. Entrare nel merito può significare, per esempio, pensare che si stia veramente parlando di fidanzate rompiscatole. E magari cercare di confutare le convinzioni del paziente su quanto sia rompiscatole la sua fidanzata, o addirittura chiedersi se non sia forse meglio aiutarlo a lasciarla per farlo stare meglio (pensa il terapeuta: ‘se lascia la fidanzata non soffrirà più, se non altro smetterà di lamentarsi, la terapia riuscirà, e io mi piacerò di più allo specchio domattina’,). Esattamente il contrario di quello che serve per condurre una buona seduta, una buona terapia, che dovrebbe partire dal presupposto che ciò che dice il paziente è solo il significante degli elementi del flusso dell’esperienza interna che è nostro obiettivo intercettare; dal presupposto che la fidanzata rompiscatole è una delle molteplici tracce che un elemento dell’esperienza interna può lasciare alla coscienza per aiutarla ad accedere a quel santuario del Sé. Così, per esempio, percorrendo in modo tecnicamente orientato il flusso dell’esperienza interna, a partire dal significante fidanzata rompiscatole, si può pervenire a un nucleo insospettato: l’angoscia di sentirsi sbagliato, deludente per chiunque diventi significativo.
Accettare i bigliettini da visita: la terza domanda del paziente
Infine, la terza domanda implicita posta da ogni paziente. Che la pancia del terapeuta comprenda un punto fondamentale (e agisca di conseguenza): il paziente non ha alcuna colpa se le sue tasche sono state riempite a sua insaputa da innumerevoli copie di un biglietto da visita. Il biglietto da visita che ci presenta sin dal primo momento della prima seduta. Anzi, a molti capita già al telefono, quando ci accordiamo per l’appuntamento. Quando tra colleghi, magari nella pausa pranzo, parliamo di pazienti, per la maggior parte del tempo parliamo di questo biglietto da visita e dell’effetto che ci fa. Sul biglietto da visita sono scritti, che so, gli occhi fissi sulle nostre scrivanie e mai nei nostri occhi; le risposte monosillabiche alle nostre domande, che dopo un po’ nostro malgrado diventano poliziesche; le richieste urgenti e tiranniche di aiuto, e i velati rimproveri se l’aiuto non arriva prontamente; la delusione malcelata per i risultati-che-non-arrivano-eppure-sono già-quaranta-secondi-che-sto-in-terapia; l’espressione sfottente mentre ci imbraniamo con la compilazione di una fattura (manco fossimo Fantozzi davanti al MegaDirettoreGalattico). Non solo cose sgradevoli, anche cose gradevolissime: sul biglietto possono esserci anche i complimenti che ci fanno sentire speciali e ci rendono improvvisamente più recettivi ai colori e agli odori della natura quando lasciamo lo studio, soprattutto se l’estate è abbastanza vicina.
Come vuole la nostra TMI (Dimaggio, Montano, Popolo & Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, Popolo & Salvatore, in corso di stampa), quel biglietto da visita è la manifestazione di una contromisura contro gli effetti devastanti dell’aspettativa negativa di come il mondo risponderà a bisogni fondamentali. Vorrei essere amato e accudito, mi aspetto di essere maltrattato, divento diffidente; la cosa funziona perché la diffidenza mi fa sentire forte e intelligente, non di cristallo come si sente di solito il me maltrattato; e siccome funziona, si automantiene; pura e semplice questione di sopravvivenza; e finisce che tratto l’altro come se avesse fatto qualcosa di gravissimo. Quando l’altro è il terapeuta, quest’ultimo davanti a me si sentirà in colpa e non saprà perché, e gli verranno in mente ricordi di patatine rubate di nascosto alle feste di compleanno delle elementari. O ancora, vorrei essere apprezzato per le mie qualità, mi aspetto di essere umiliato, la mia vita diventa una costante ricerca di un pubblico ammirante per tener a debita distanza lo spettro dell’umiliazione. Il terapeuta che si comporti come il pubblico fiacco di un artista nella fase calante della carriera subirà la condanna della sconfitta umiliante che io passo la vita a cercare di scongiurare.
Il terapeuta dovrebbe accettare con gentilezza, apertura, curiosità il biglietto da visita, soprattutto sulla base della consapevolezza che anche nelle sue tasche c’è un biglietto simile, e che per il paziente come per sé stesso le cose più importanti sono quelle scritte nella facciata posteriore. Solo così gli sarà possibile stabilire una risonanza interpersonale (Lewenson, 1995, cit in Meares, 2005), con cui si intende quel processo che ha l’effetto di innescare la trasformazione di un sistema in precedenza lineare in un altro dotato di complessità. Il terapeuta capace di accettare con rispetto e delicatezza il biglietto da visita del paziente, di rispettare le strategie relazionali stratificate sui nuclei più profondi dell’identità, sarà in grado di accompagnare il paziente ai bisogni fondamentali che stanno dietro.
Paziente e terapauta tra sistemi motivazionali
Ora, torniamo a quei cinque scenari descritti all’inizio di questo scritto. Che sta succedendo nell’animo – e nell’organismo – del terapeuta in quei cinque scenari? Il quesito si può formulare anche in modo più tecnico: quale sistema motivazionale è attivo e sta guidando il terapeuta? Qualche indizio: in tutti e cinque i casi, poco ma sicuro, qualsiasi cosa anche remotamente assimilabile alla gioia di vivere è lontanissima dalla stanza della terapia. In tutti e cinque i casi le emozioni evocate dalla relazione con il paziente hanno tono edonico negativo. Noia, irritazione, rabbia, sovraccarico, costrizione, indignazione. La soluzione all’indovinello è facile. L’assetto interno del terapeuta è regolato dal sistema di affermazione e difesa del rango. Ogni terapeuta, in fondo al proprio animo, lo sa come funziona peculiarmente questo sistema dentro di sé. Al netto della quota regolata, per tutti noi, dalla lotta della sopravvivenza, che è anche lotta per la sopravvivenza di un’immagine positiva di noi stessi (a quanto pare veniamo al mondo con la consegna genetica di essere per forza superiori a qualcuno per poter respirare a pieni polmoni) cosa rimane? Gli elementi della propria storia personale che conferiscono una trama specifica, una declinazione idiosincratica a quella lotta a cui siamo destinati. E quegli elementi autobiografici in moltissimi casi rendono quella trama avvincente e tragica, perché ne costituiscono le innumerevoli violazioni di canonicità: sono i pezzi della storia di vita dove stanno le cose andate per il verso storto, gli intoppi nel percorso che nel migliore dei mondi possibili dovrebbe condurre all’essere in pace con sé stessi, consapevoli del proprio valore. Sguardi delusi di madri davanti ai nostri segni di insicurezza, commenti rapidi e taglienti di padri, magari sul percorso di studi scelto (‘ma in fondo che fa esattamente uno psicologo, si fa pagare per parlare?’), giudizi caustici nei momenti in cui c’era bisogno solo di un abbraccio. Sono i ‘la tua amica ha avuto 9, perché tu hai avuto 8 visto che non sei certo meno brava di lei?’; gli innumerevoli ‘potevi fare meglio’; i ‘sei il più bravo della classe’ detti con l’intonazione dell’aposiopesi, perché la parte più rilevante è la postilla omessa: ‘quindi mi aspetto che tu lo sia sempre’). E tanto, tanto altro.
Questo è il carico che tutti i terapeuti sostengono. Certo, i giovani di più. Ma non è detto. Forse gli esperti hanno solo imparato meglio a ignorarlo, o hanno accumulato fonti alternative di gratificazione dell’autostima, utilissime a rendere inoffensiva la minaccia di un paziente che non risponde ai loro interventi, ai loro modelli, ai loro protocolli.
In sintesi: il paziente fa solo il suo mestiere, soffre, spesso tanto, ma non sa perché, o crede solo di saperlo, e vorrebbe risposte, vorrebbe solo essere traghettato il più lontano possibile dalla sofferenza. È facile, soprattutto se la richiesta del paziente è pressante e “magica”, e soprattutto se – accade quasi sempre, ed è pure comprensibile – il paziente non ha una rappresentazione chiara di cosa si fa in una psicoterapia e di come esattamente la psicoterapia possa aiutarlo, che il terapeuta senta minacciata l’immagine positiva di sé, e che la voglia difendere coi denti. Il sistema del rango è attivo, gli schemi del terapeuta attivano strategie di coping cablate su sistemi motivazionali tendenzialmente incompatibili con la sintonizzazione: il paziente diventa un avversario. E se il paziente diventa un avversario, si verifica il problema che credo sia alla base di tutto ciò che non funziona in una seduta e in una terapia: è ostacolato il processo di sintonizzazione.
Aiutare i terapeuti a superare gli ostacoli personali al processo di sintonizzazione con il paziente è l’obiettivo dei Seminari sulla Disciplina Interiore del Terapeuta.
Nella prossima puntata riporteremo una serie di testimonianze redatte dai partecipanti dopo l’esperienza del IV Seminario.