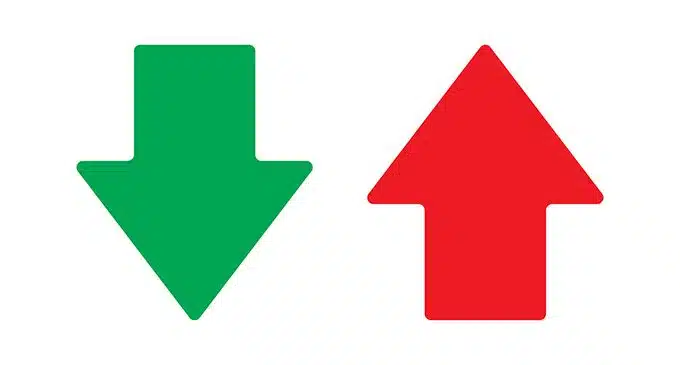Ultimamente nell’ambiente della terapia cognitivo comportamentale italiana e non si discute della contrapposizione tra processi top down e bottom up. I primi sarebbero quelli del pensiero esecutivo, consapevole, volontario, dichiarativo e quindi immediatamente verbalizzabile e infine processabile dal pensiero razionale. I processi bottom up invece sarebbero automatici, emotivamente carichi, associativi, inseriti nell’esperienza immediata e connessi con la sensorialità corporea ma non sempre immediatamente controllabili volontariamente (Kahneman 2011-2012; Martin & Sloman, 2013).
Giovanni M. Ruggiero, Gabriele Caselli e Sandra Sassaroli
La classificazione ha i suoi cultori e i suoi detrattori, i suoi limiti e il suo valore, che è soprattutto euristico. I limiti di questo modo di ragionare sono vari. Ad esempio, se definiamo top down un modello metacognitivo come quello di Adrian Wells (2013), va osservato che Wells a sua volta non lavora sul “capire” razionalmente un contenuto distorto ma sul gestire diversamente alcuni processi mentali, tra cui l’attenzione. E per gestire questi stati attentivi Wells non si limita a “spiegare” ma assegna degli esercizi in cui il paziente apprende nella pratica a gestire diversamente le funzioni attentive. Sono esperienze anche queste.
Se parliamo di esercizi immaginativi notiamo che un esercizio di questo tipo può essere fatto in due modi: condividendo il razionale all’interno di una formulazione del caso anch’essa condivisa, oppure utilizzando l’esercizio per creare un’esperienza con il paziente da valutare consapevolmente solo in un secondo momento. Noi crediamo che il modo migliore di farlo sia il primo, anche perché è difficile pensare a un intervento bottom-up laddove al paziente è chiesto di governare consciamente le proprie facoltà mentali, nel caso l’immaginazione. Questo significa che l’esercizio bottom-up s’inserisce in una cornice di concettualizzazione ed esecuzione top-down: le funzioni superiori decidono che certe esperienze vanno fatte e non solo sapute concettualmente.
Terzo scenario tra i tanti possibili: l’uso della relazione terapeutica. E in particolare l’uso delle varie situazioni critiche in seduta. Ad esempio l’esperienza condivisa alla Semerari oppure le rotture e riparazioni alla Safran e Muran (2000), e così via. In questo caso immaginiamo che il top down tenda a confinarsi in un’analisi a posteriori dell’accaduto relazionale che, come forse direbbe Liotti, ha solo la funzione di memorizzare nel top un intervento che però si è svolto tutto nel bottom in modo da poterlo facilmente riattivare quando necessario. Questo punto è quello che ci trova perplessi. In primo luogo è difficile comprendere il peso dell’intervento e della memorizzazione successiva né è sempre chiaro in modo operativo ove si situi maggiormente il processo terapeutico, nella componente relazionale in sé (bottom up) nella discussione esplicita successiva (top down) o nell’interazione tra le due.
Procedendo per questa strada, infatti, si finirebbe per diventare meno cognitivisti di Otto Kernberg (Kernberg, Yeomans, Clarkin e Levy, 2008). Il suo modello di psicoterapia focalizzata sul transfert, infatti, prevede che le pulsioni inconsce che emergono nella relazione di transfert siano davvero oggetto di lavoro terapeutico solo quando emergono al livello di conoscenza cosciente durante gli interventi di chiarificazione, confronto e interpretazione di transfert. In Kernberg c’è una valorizzazione del ruolo del pensiero cosciente che invece nei modelli relazionalisti si rischia di perdere, compresi i modelli relazionalisti cognitivi come quelli di Semerari e Dimaggio (Dimaggio, Semerari, Carcione, Nicolò e Procacci, 2007), Liotti e Monticelli (2014) e Safran e Muran (2000).
Si potrebbe obiettare: poco male, se quella è la verità. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Vero, ma noi non sappiamo ancora qual è la verità. Nel frattempo si procede a tentoni ma anche mantenendo una direzione. Non per cieca ideologia ma per ordine mentale e rigore metodologico. Chiamiamola sana ideologia: si verifica un’ipotesi alla volta e a fondo per evitare il rischio di testare un po’ tutto e in maniera insufficiente e al tempo stesso accogliere un po’ di tutto. Basta poco per passare dall’apertura all’ecclettismo deteriore.
Inoltre, ci sembra che un simile intervento, pur possibile, rischi di fare troppo aggio su elementi casuali, governabili solo a posteriori, non programmabili in un progetto terapeutico condiviso e tanto meno prevedibili in una formulazione del caso condivisa ma da vivere e utilizzare sul momento, come occasioni irripetibili che sicuramente il terapeuta esperto sa e deve saper utilizzare al volo.
Il rischio principale però è che così la componente artigianale non solo diventi di gran lunga prevalente (poco male, se questa è la realtà) ma peggio, che in una profezia che si auto-avveri si rinunci a cercare gli aspetti controllabili e replicabili della psicoterapia per accontentarsi di una abilità irriproducibile e tutta intuitiva. Ci si chiede inoltre anche quanto sia insegnabile una simile abilità e quanto sia scevra da distorsioni interpretative che dipendono più dalle idee del terapeuta che del paziente. Tutto questo, s’intende, al di là di una doverosa attenzione da dare al come ci si sente in seduta.
Un altro rischio è che la ricerca si riduca alla descrizione di processi talmente complessi da non poter essere mai governati consapevolmente, con la conseguenza deprimente che da questo quadro non ci si potrà mai aspettare un miglioramento progressivo dell’efficacia terapeutica, ma solo un cristallizzarsi di un’arte sempre uguale a se stessa, incapace di progredire e addirittura non intenzionata a migliorare, che tende a trasmettersi sapienzialmente da maestro ad allievo in un rapporto ancora una volta artigianale nel senso peggiore del termine.
Il rischio di questa deriva è la riduzione della scienza psicoterapeutica e della professione dello psicoterapeuta a una posizione di consulente, esperto di elementi aspecifici, elementi facilmente replicabili da ogni professionista della relazione d’aiuto. O ancora peggio, la riduzione della psicoterapia all’effetto placebo, che in fondo non è altro che l’insieme degli elementi che funzionano appunto in modo aspecifico. D’altro canto Wampold e Imel nel loro “Great Psychotherapy Debate” appena uscito nel 2015 parlano esplicitamente di un uso costruttivo e positivo del termine “placebo” per definire il lavoro psicoterapeutico. La psicoterapia come buon placebo: idea geniale o pillola indorata?
Per concludere, i termini top down e bottom up sono sicuramente molto limitati e limitanti e finiscono per separare processi largamente sovrapposti. A volte, tuttavia, davanti ad alcuni rischi e possibili derive, può essere utile distinguerli e attribuire a essi e alla loro interazione un peso scientifico specifico, riconoscibile e operazionalizzabile. Quando fare questo? Quando per esempio il bottom up rischia di ridursi a un’esperienza emozionale correttiva unica, irripetibile, non programmabile e a rischio di essere vissuta come salvifica in un rapporto apparentemente paritario con un terapista che sembra un semplice artigiano, ma in realtà potrebbe essere più propenso a presentarsi come un sacerdote sapienziale e ieratico.
Al tempo stesso, occorre anche essere consapevoli che il compito storico della terapia cognitivo comportamentale è stato l’approfondimento del ruolo della direzione top down nel processo terapeutico e ci sembra giusto proseguire questo percorso. Inoltre ci sembra conveniente proseguire il lavoro nell’area in cui si è diventati storicamente più competenti ed esperti. Ed è anche vero che nel nostro gruppo di lavoro riteniamo che i processi top down siano realmente i più promettenti dal punto di vista clinico. Ma questa è un’altra storia e un altro articolo.