LEGGI GLI ARTICOLI PRECEDENTI: Mindfulness e Psicoterapia Cognitiva: il lato opaco dei cimbali Parte 1 – Parte 2

– 1 – “Mindfulness fascists”? Per prima cosa, credo sia importante evitare di diventare “mindfulness fascists”, per usare un’espressione coniata da Russ Harris (2009). Rendere tutto mindfulness-based o intravedere nella mindfulness la soluzione di tutte le problematiche è davvero molto pericoloso. Uno dei rischi principali è che, a parere di chi scrive, il percorso terapeutico venga confuso con un percorso iniziatico in cui l’allievo deve imparare un “modus vivendi”.
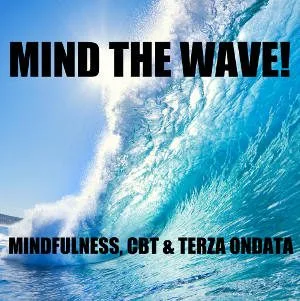
– 2 – Anti-Mindfulness tout cour? È anche vero il contrario… mi riferisco in particolare all’atteggiamento scettico di alcuni colleghi che vedono nella mindfulness il pericolo di una nuova fase new age anni ’70 che potrebbe far perdere di vista la scientificità e la legittimità della mindfulness all’interno di protocolli di intervento terapeutici, e sottolineo “terapeutici” e non di supporto/sostegno a persone che sostanzialmente stanno già bene. Alcuni dati di efficacia sono già stati citati nella brillante serie di Caselli qui su State of Mind. In sintesi, la mindfulness sembra migliorare le capacità di decentramento, la regolazione delle emozioni (Baer et al., 2006; Brown & Ryan, 2003), ha un effetto sulle capacità di spostamento volontario del focus attentivo, rappresenta un modalità con potenziali anti-rimuginio ansioso e/o anti-ruminazione depressiva… LEGGI QUI e promuove un atteggiamento di accettazione.
Purtroppo il concetto di mindfulness per sua natura non si presta in modo lineare alle regole ferree dell’evidence based, ciononostante la letteratura scientifica sta andando verso questa direzione e questo riflette un aspetto fondamentale per non confondere la mindfulness con altro, per certi versi prezioso, stimolante e utile, che però non è psicoterapia.
-3- Ma come viene concettualizzata la mindfulness? Costrutto molto complesso da comprendere se non coadiuvato da una pratica (anche breve e esplorativa) personale, sembra esserci un certo accordo nel considerare la mindfulness come un modello bi-componenziale (Bishop et al., 2004) che include:
- Una componetente di autoregolazione dell’attenzione – l’allenamento a mantenere l’attenzione su ciò che avviene nel qui ed ora permetterebbe di accrescere il riconoscimento e il distacco critico dai pensieri disfunzionali nel momento presente;
- Una seconda componente di curiosità e apertura – tale competenza permetterebbe di sperimentare un atteggiamento funzionale verso l’esperienza del momento presente.
Inoltre, la mindfulness si pone come concetto alquanto transteorico, integrabile e utilizzabile in diverse forme di psicoterapia, tra cui (oltre alla terapia cognitiva) approcci, costruttivisti (più o meno radicali), psicodinamici, umanistici, gestaltici, etc… e, forse, in un periodo in cui si avverte un bisogno di integrazione nella teoria, di consenso e sinergia nella clinica e di “grandi modelli” che spieghino il funzionamento del paziente nel più ampio raggio possibile (vedi Schema Therapy e ACT ad esempio… ) un concetto come questo, se studiato e validato secondo i principi dell’evidence-based, potrebbe aprire scenari futuri: di ricerca e soprattutto di applicazioni cliniche.

– 4 – Fare, fare e fare… Un concetto caro alla mindfulness e che credo sia utile in questo dibattito è quello chiamato del doing mode, la modalità del fare, che rappresenta l’atteggiamento anti-mindfulness per eccellenza. Espressione utilizzata in ambiente mindfulness per indicare il rimanere incastrati nella modalità del fare e non concentrarsi mai su osservare quel che si sta facendo in modo decentrante e mentalizzante, cioè consapevole.
Proviamo a pensarci, quando viviamo esperienze per noi negative proviamo emozioni negative, il provare emozioni negative ci fa desiderare che le cose siano in modo diverso da quello che sono (o che noi crediamo che siano…) e cosa facciamo? Iniziamo a rimuginare sul futuro, o a ruminare nel passato, ci giudichiamo, giudichiamo gli obiettivi che ci eravamo prefissati, desideriamo allontanarci a tutti i costi da quella situazione che noi non vogliamo assolutamente tra i piedi…
In queste situazioni si attiva ciò che viene chiamato il doing mode, concetto molto vicino al sé concettualizzato di cui ho parlato su State of Mind. Tra le caratteristiche principali di tale modalità troviamo l’utilizzo quasi esclusivo della parte verbale (il linguaggio della nostra mente), che considera i nostri pensieri come l’unica realtà possibile, che viaggia nel tempo (avanti o indietro in base alle “preferenze” personali), che si pone come obiettivo principale l’allontanare e il non voler avere a che fare con ciò che ci fa soffrire, un evitamento in sostanza e che, dopo anni e anni di cattiva abitudine, diventa automatico, scontato e per molte persone l’unica modalità possibile (perché “sono fatto così”…).

Il doing mode sembra di fatto un atteggiamento molto diverso dall’esperienza di flow, citata da Caselli. Scrive:
“È possibile che una persona scelga consapevolmente di godersi una modalità del fare ‘sana’ dove non è presente a sé stesso momento dopo momento? Penso all’esperienza che viene descritta con il concetto di ‘flow’ che è ‘ottimale’, ‘soddisfacente’ e che è caratterizzata tra le altre cose da assenza di percezione del tempo e da scarsa autoconsapevolezza.”
A mio parere la risposta è sì. Nel flow, però, manca totalmente (o quasi…) l’aspetto della disfunzionalità e della automaticità, tanto che il flow viene considerato come un’esperienza ottimale in cui ottimizzo il tempo e massimizzo la prestazione. Il doing mode, però, non ha tali vantaggi, bensì porta a micro-episodi di alienazione disfunzionale non coerente e utile allo scopo prefissato (cosa che invece avviene nell’esperienza di flow…).
BIBLIOGRAFIA:
- Baer, R.A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment. 13:27–45.
- Bishop, S.R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N.D., Carmody, J., Segal, Z.V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D. & Devins, G. (2004). Mindfulness. A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and practice. 11(3), 230-241.
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
- Ciarrochi & Bailey (2008). A CBT practitioner’s guide to ACT. New Harbinger Publications: New York
- Blackledge, J.L., Ciarocchi J. & Deane, F.P. (2009). Acceptance and Commitment Therapy: Contemporary Theory, Research and Practice. Australian Academic Press.
- Hayes, S.C. & Strosahl, K.D. (2010). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. Springer: New York.
- Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. Guildord Press: New York.
- Harris R. (2009). ACT made simple. New Harbinger Publications: New York.
- Nairn, R. (1999). Diamond mind. A psychology meditation. Boston: Shambhala.
- Siegel, R.D., Germer, C.K., & Olendzki, A. (2009). Mindfulness: what is it? Where did it come from? Clinical Handbook of Mindfulness. 2, 17-35. DOI: 10.1007/978-0-387-09593-6_2.
- Luoma, J.B., Hayes, S.C., & Walser, R.D. (2007), Learning ACT An Acceptance & Commitment Therapy Skills-Training Manual for Therapists. New Harbinger Publications: New York.





